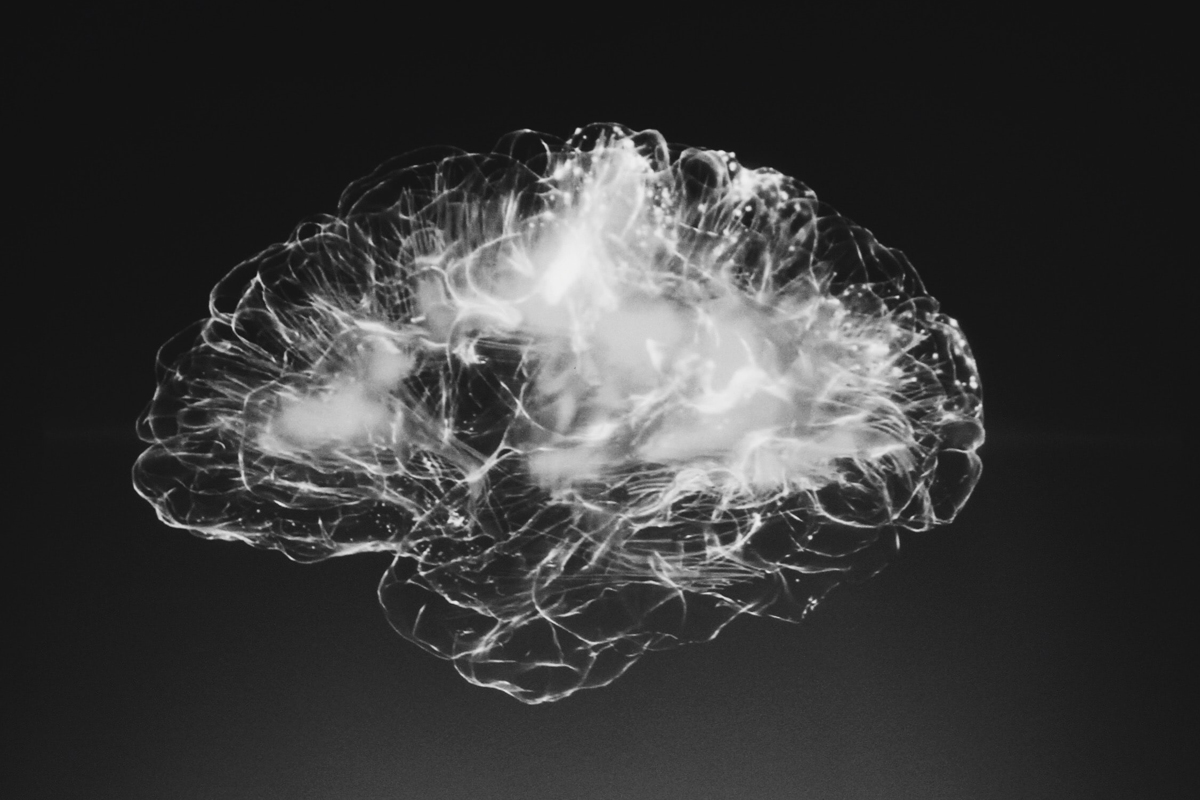Cosa sappiamo della morte? Sicuramente che è un evento. Benché la trasformazione sostanziale che permette di definirla come tale non sia visibile immediatamente, possiamo comunque identificarla come immodificabile e irripetibile, se confrontata con tutti gli altri accadimenti nella vita di un individuo. Al netto di queste caratteristiche, su cui tutti possono concordare, fornire una definizione corretta della morte con termini possibilmente validi per tutte le discipline che se ne occupano e che non siano equivoci può apparire tutt’ora un’impresa non di poco conto. Eppure un terreno comune sarebbe auspicabile da trovare soprattutto per filosofia e scienza medica, poiché entrambe definiscono le questioni generali di bioetica e, praticamente, decidono della vita di ogni paziente.
Tradizionalmente i parametri per accertarsi della morte di un individuo erano due: quello anatomico (ossia la distruzione del corpo) e quello cardio-polmonare (la cessazione del battito cardiaco e della respirazione naturali). Con l’avvento e la diffusione del respiratore artificiale – precedentemente utilizzato in casi eccezionali, ma poi entrato a far parte delle pratiche salvavita comuni – le cose si sono complicate. Molti pazienti, infatti, mantenevano battito, temperatura corporea e altre caratteristiche fisiche “da vivente” se supportati da respirazione artificiale, ma non presentavano più alcuna attività a livello cerebrale. Erano da considerare effettivamente ancora in vita oppure si aveva a che fare già con cadaveri? Era così necessario introdurre un nuovo parametro neurologico, che affiancasse i due unanimemente riconosciuti.
Nel 1959 i neurologi francesi Mollaret e Goulon tentarono di risolvere la questione almeno sul piano pratico introducendo la definizione di coma dèpassè: per un paziente che non presenti attività cerebrale né superficiale né profonda, passate 24 ore, è possibile sospendere ventilazione. I due però non specificarono se il paziente fosse da considerare effettivamente morto, cessata l’attività cerebrale, oppure no. Quasi dieci anni dopo, la Commissione della Harvard Medical School equipara il coma dèpassè alla morte, fornendo quattro criteri di diagnosi: assenza di attività cerebrale, assenza di movimento spontaneo o indotto, assenza di respirazione spontanea e assenza di riflessi nel tronco encefalico. Escludendo condizioni cliniche che potessero trarre in inganno e senza necessità di elettroencefalogramma di verifica, solo sulla base di queste valutazioni era possibile dichiarare morto il paziente e procedere addirittura all’espianto degli organi, pur mantenendo la ventilazione artificiale.
Benché scientificamente venissero lasciati pochi dubbi, alcuni filosofi, tra cui Hans Jonas, contestavano la decisione di equiparare la morte cerebrale alla morte effettiva del paziente, tanto più che le definizioni di morte troncoencefalica e morte corticale si affacciarono a complicare ulteriormente la questione.
Per Jonas, una persona muore quando perde completamente la sua unità funzionale, quindi considerare la morte del cervello come parametro quasi unico e definitivo parrebbe una scelta teorica arbitraria, viziata da una concezione antropologica errata e da esigenze pratiche utilitaristiche (come si diceva, prelevare organi in un corpo che mantiene ancora le sue funzioni di vivente, ad esempio, garantisce una qualità dei tessuti maggiore rispetto ad un prelievo effettuato su di un cadavere).
Per i sostenitori del parametro della qualità della vita una persona senza cervello funzionante, che quindi abbia perso le sue capacità cognitive e relazionali, ha concluso la propria vita umana degna di essere vissuta; conclusa quindi in egual maniera può dirsi anche la sua vita biologica. Ma può esistere vita umana senza vita biologica? Inoltre il rischio di un errore teoretico nel considerare il cervello come centro di tutto l’uomo, a discapito di un intero organismo sistemicamente organizzato e complesso, appare solo come una riproposizione di un indigesto dualismo millenario che, invece di insistere sulla dicotomia anima-corpo, si struttura su quella più moderna di cervello-resto del corpo.
Appare chiaro che la morte cerebrale è la morte di un essere umano a un certo stadio del suo sviluppo (ciò comporta il riconoscimento di dignità umana antecedente anche alla formazione del cervello e sono quindi da considerere esseri umani anche anencefalici, individui con malformazioni et similia). La definizione va inoltre integrata con tutti gli altri criteri ma costituisce una diagnosi di morte a sé stante solo se si riesce effettivamente a provare che con la perdita delle funzionalità cerebrali si assiste anche alla perdita dell’unità organica. Finché l’individuo è tenuto in vita, anche se dalle macchine, sarà sempre considerato inviolabile.
Vittoria Schiano di Zenise
[Photo credit Alina Grubnyak su unsplash.com]