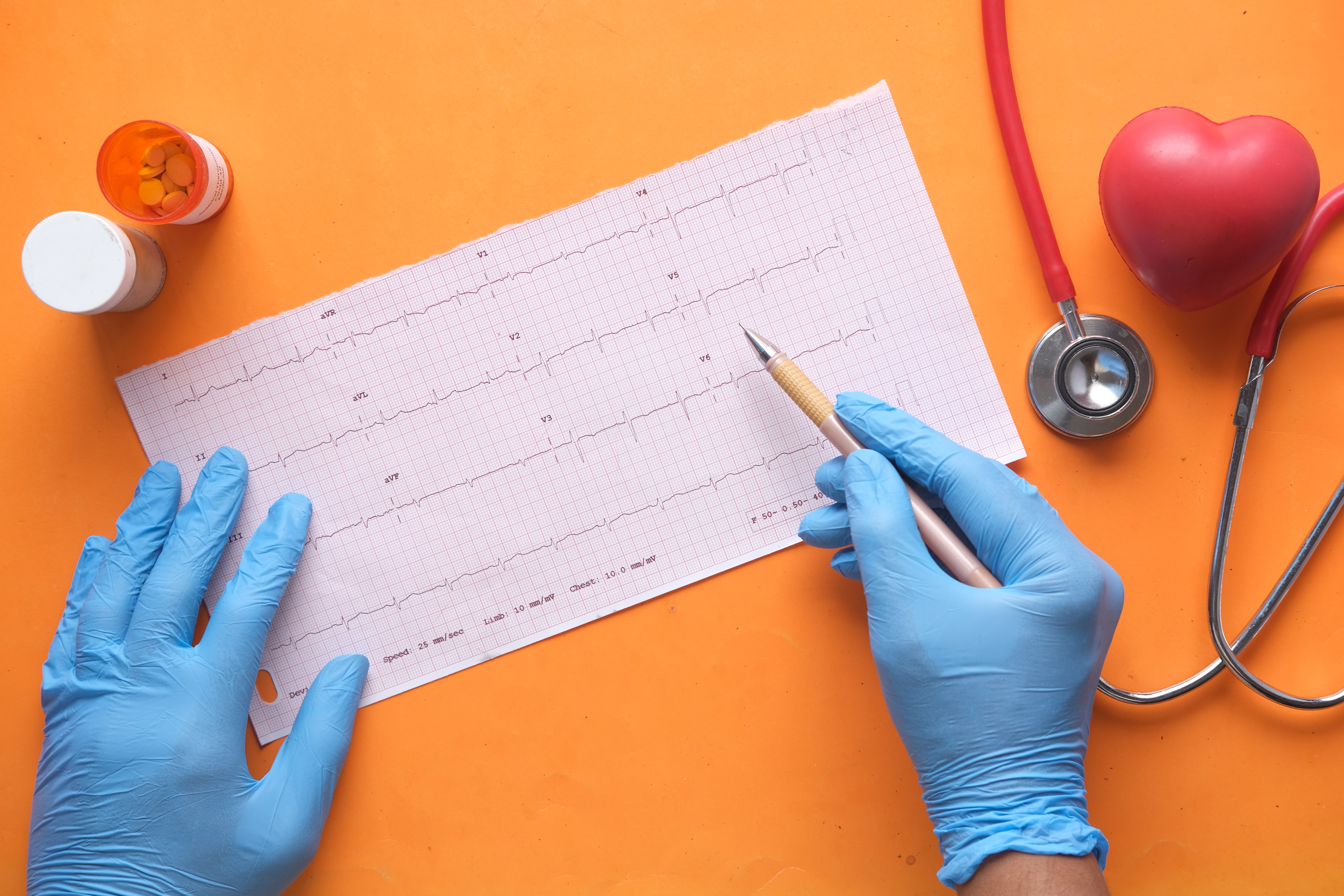La scena è intensa. Il montaggio veloce. Serrato il dialogo, che apre lo straordinario film La forza della mente (regia di Mike Nichols), fra il prof. Harvey Kelekian, famoso oncologo (interpretato da Christopher Lloyd), e la prof.ssa Vivian Bearing (Emma Thompson), nota ricercatrice universitaria di letteratura inglese.
Kelekian incombe sulla Bearing: «Lei ha un cancro». La comunicazione della diagnosi è una sentenza. «Un cancro metastatico dell’ovaio in stadio avanzato», continua, che si presenta ai medici come «un insidioso adenocarcinoma».
«Insidioso?» chiede Vivian.
«Insidioso significa non rilevabile a uno stadio iniziale», spiega Kelekian.
«Insidioso significa subdolo», commenta Vivian.
Visibilmente infastidito, Kelekian continua la sua dettagliata dissertazione. Illustra la situazione clinica, i trattamenti consigliati e i rischi. Poi, fingendo una improbabile simmetria, riprende: «il tumore si sta espandendo molto velocemente e questa cura è molto aggressiva». L’unica cura possibile. Grazie al consenso al trattamento, la Bearing darà inoltre «un significativo contributo alla ricerca e alla conoscenza».
«La conoscenza, sì», ripete sopraffatta Vivian prima di sottoscrivere i moduli a un appagato Kelekian.
Il dialogo è una rappresentazione di quell’attitudine clinica a osservare esclusivamente la malattia e non il malato. Foucault la definiva «sguardo clinico»1. Nello sguardo clinico il malato non entra mai nel campo visivo del medico. Il centro della scena è consegnato alla malattia e ai saperi che la definiscono. È uno sguardo disumanizzante e alienante, tanto per il paziente quanto per il curante. L’uno è oggetto, l’altro è un tecnico-controllore. Fra di loro nessuna relazione. I loro mondi si incrociano per un “sintomo”, ma non si incontrano in una relazione. L’idea di conoscenza di Kelekian, ad esempio, non è la conoscenza a cui aspira Vivian. L’uno e l’altra attribuiscono, persino, un significato diverso agli stessi termini: cosa significa “insidioso”?
La sequenza drammaturgica è anche metafora di una scena di cura quotidiana, nella quale emergono il potere e i limiti della tecnica: capace di insinuarsi nelle nostre vite, ma anche inadeguata a darle un senso.
Certamente gli sviluppi tecnologici hanno determinato grandi progressi e cospicui vantaggi per la vita di ciascuno, ma la questione è un’altra: parliamo, infatti, di un modo di approssimarsi alla realtà oggettiva – fisiopatologica – della malattia, ma non alla realtà soggettiva, antropologica, del malato. Un modo, che definiamo tecnico-procedurale, che chiude la porta a una realtà più grande. La cura non è, infatti, il solo intervento tecnico-specialistico. La cura è «il lavoro del vivere e dell’esistere», è la «fabbrica dell’essere» (L. Mortari, Filosofia della cura, 2015). L’uomo «si trova consegnato all’esistenza secondo la modalità della cura» (ibidem). Noi assumiamo la nostra esistenza avendone cura, questo vuole dire che se abbiamo cura di certe relazioni il nostro essere sarà costruito dalle cose che prenderanno forma in queste relazioni. Se ci prendiamo cura di certe persone, quello che accade nello scambio relazionale con l’altro diverrà parte di noi.
Rispetto al tema che stiamo affrontando, appaiono, quindi, del tutto insufficienti le cosiddette procedure di “umanizzazione dei servizi sanitari”. Occorre piuttosto ri-scoprire la visione di una buona cura. Di un lavoro esigente, che riempie ogni attimo di tempo, vissuto con gentilezza, attenzione ed empatia; che accoglie la fragilità come forma di vita mediatrice di valori. Un lavoro nel quale si mantiene sempre il contatto con la persona, nel quale non si distoglie mai lo sguardo da essa: uno sguardo pronto a ricevere il massimo di realtà possibile, allenato a focalizzarsi su ciò che si cerca, ma pronto a cogliere anche ciò che resta nell’ombra. Un lavoro nel quale si ascoltano tutte le parole del sofferente perché parlano della malattia, ma vanno al di là di essa. Un lavoro fatto di complessi intrecci e profonde dinamiche relazionali tra tutti gli attori coinvolti. Tutti impegnati, momento per momento, nella ricostruzione dei loro contesti di consapevolezza, inseparabilmente emozionali e cognitivi, pragmatici e simbolici (cfr. R. Lusardi, S. Manghi, I limiti del sapere tecnico, 2013).
«Una buona cura tiene l’essere immerso nel buono. Ed è questo buono a dare forma alla matrice generativa del nostro vivere e a strutturare quello strato di essere che ci fa stare saldi fra le cose e gli altri. Fare pratica di cura è dunque mettersi in contatto con il cuore della vita» (L. Mortari, Filosofia della cura, 2015).
Massimo Cappellano
Massimo Cappellano, giornalista, dirige l’Ufficio Stampa dell’Asp di Catania. Laureato in Storia Contemporanea all’Università di Catania, è stato docente invitato presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. È studioso di tutto ciò che si muove nel crocevia in cui si incontrano antropologia, filosofia, sociologia, politica e religione. È autore dei saggi Il grido e l’incontro. Due figure per ripensare la modernità (2009) e Comunicare partecipazione. Comunicazione pubblica e partecipazione civica come leve per il cambiamento della Pa (2019), e co-curatore del volume Lessico Sturziano (2013).
NOTE
1. Cfr. M. Foucault, Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, 1998.
[Photo credit Towfiqu barbhuiya via Unsplash]