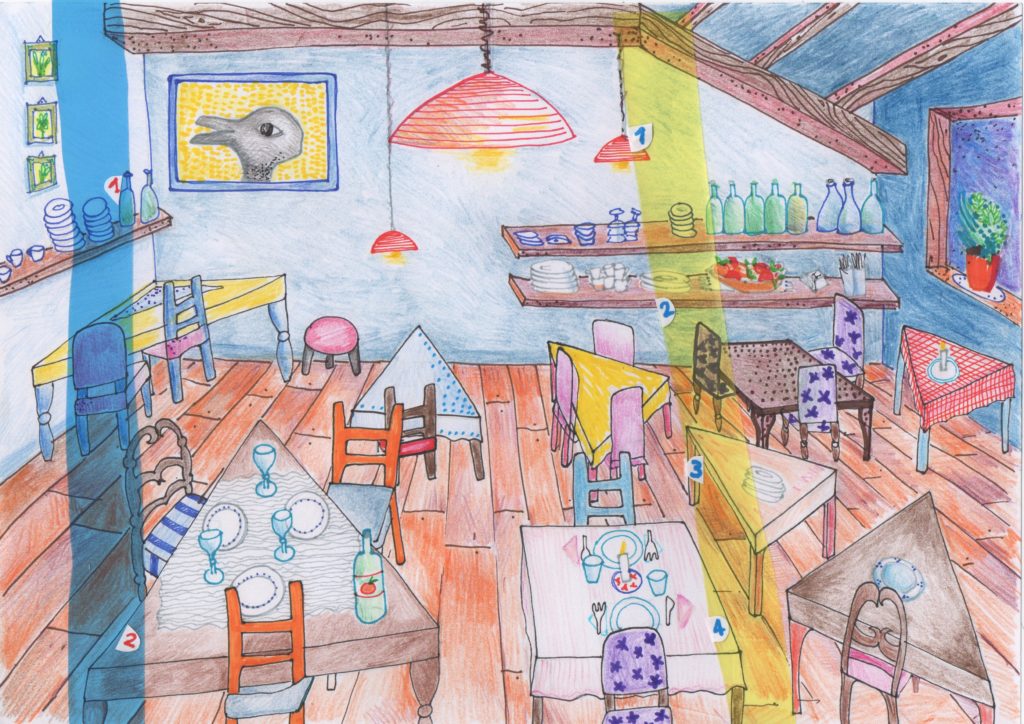Non c’è vera moralità senza coscienza, così come non c’è una viva coscienza senza moralità. Per salire sul palcoscenico della vita, abbiamo bisogno di costruirci una nostra moralità, di crearci una persona – nel senso etimologico del termine – che consenta alla nostra coscienza di rivelarsi al mondo in tutta la sua unicità. Se però ci dimentichiamo di ascoltare quella voce che proviene dal nostro corpo, se ci facciamo sopraffare dalle grida del mondo, rischiamo di diventare «beingless beings»1, uomini vuoti e apatici, automi facilmente manipolabili. Il pericolo principale è quello di avere una morale svuotata di coscienza, cioè un complesso di comportamenti meccanici, di atti che rispondono non tanto a leggi interiori, quanto a regole imposte dall’esterno. Si creerebbe una netta scissione tra esteriorità e interiorità: il corpo è indotto (o addirittura costretto) a fare ciò che non vuole, ad essere ciò che non è. Come avverte Kurt Vonnegut, «noi siamo ciò che fingiamo di essere, perciò dobbiamo stare molto attenti a ciò che fingiamo di essere» (K. Vonnegut, Madre Notte, 2021, p. 5). Per dirla con Hannah Arendt, «sono le apparenze ad apparire in pubblico, mentre le qualità del cuore e della mente, sono politiche nella misura in cui chi le possiede desidera mostrarle in pubblico, ponendole sotto i riflettori della pubblica piazza» (H. Arendt, Responsabilità e giudizio, 2012, p. 172). D’altronde, è bene che la maschera che indossiamo in società non ci tolga il respiro; una morale priva di coscienza produrrebbe soltanto ipocriti frustrati e infelici, che nel mentire agli altri tradiscono fondamentalmente sé stessi, che si autocensurano prima di mischiarsi nella folla, che reprimono i propri sentimenti per far spazio agli obblighi della società. Il mondo sarebbe dominato (o forse lo è già?) da simulatori come Jean-Baptiste Clamence, il protagonista de La caduta di Camus, che fa il bene soltanto per ottenere una misera gratificazione personale. «Quando lasciavo un cieco sul marciapiede dopo averlo aiutato ad attraversare la strada, gli facevo un cenno di saluto. Quel gesto del cappello – confessa Clamence – non era evidentemente rivolto a lui, non poteva vederlo. A chi era destinato allora? Al pubblico. Dopo la parte, i saluti…» (A. Camus, La caduta, 2019, p. 32). Questa confessione ci pone di fronte ad una grande questione di filosofia morale: può l’individuo fare del bene sinceramente e spontaneamente, senza che gli venga imposto da una tavola valoriale? Come si possono conciliare i bisogni vitali della coscienza con la necessità di preservare una convivenza umana?
Pur nella consapevolezza che gli ipocriti continueranno ad esserci, è forse possibile concepire una forma di educazione che abbia tra i suoi obiettivi principali lo sviluppo delle coscienze. Il pedagogo non dovrebbe imporre modelli, ma potrebbe condurre gli esseri umani a forgiare un proprio stile di vita e ad amarsi per come sono realmente. Apprezzarsi è una precondizione indispensabile per provare amore per gli altri, un amore incondizionato e disinteressato che non vuole nulla in cambio, ma che cerca soltanto di dare qualcosa all’altro. L’amor di sé non va però confuso con il narcisismo. Un narcisista è incapace di amare. Non ama né sé stesso né l’altro, ma un’immagine mistificata e ingigantita di sé; riesce soltanto a concepire una realtà fittizia in cui l’altro è assente. Al contrario, una reale accettazione di sé stessi comporta l’accettazione dei propri limiti, quei limiti che consentono all’individuo di entrare in relazione con l’altro e dargli voce. In altre parole, il bene o è altruistico o è opportunismo, megalomania, falsità. Direbbe Bakunin:
«la libertà, la moralità e la dignità umana sono tali solo in quanto l’uomo fa il bene non perché gli viene imposto, ma perché lo sente, perché lo vuole, perché lo desidera» (M. Bakunin, Dio e lo Stato, 2008, p. 123).
Dunque, la bontà è principalmente una questione di onestà, la stessa onestà che spinge il dottor Rieux, personaggio centrale de La Peste, a combattere in prima linea contro l’epidemia. Non c’è eroismo nel suo gesto, ma un attaccamento alla vita e un rifiuto di ciò che fa morire gli esseri umani. Il suo impegno ha una forte carica etica: bisogna fare del bene ed evitare di creare altro male, perché è il modo migliore per vivere con sé stessi e con gli altri.
Serafino Di Sanza
Nato nel 2003 e cresciuto in Basilicata, è uno studente iscritto al corso di Scienze internazionali e diplomatiche dell’Università di Bologna. Amante del pensiero libertario, considera come suoi maestri spirituali Albert Camus, Simone Weil e George Orwell. Crede nella forza rivoluzionaria della cultura, unica arma non violenta in grado di migliorare il mondo.
NOTE
1. Cfr. G. Melchiori, Introduzione, in Gente di Dublino, 2015, p. XIII.
[Photo credit Jose A. Thompson via Unsplash]