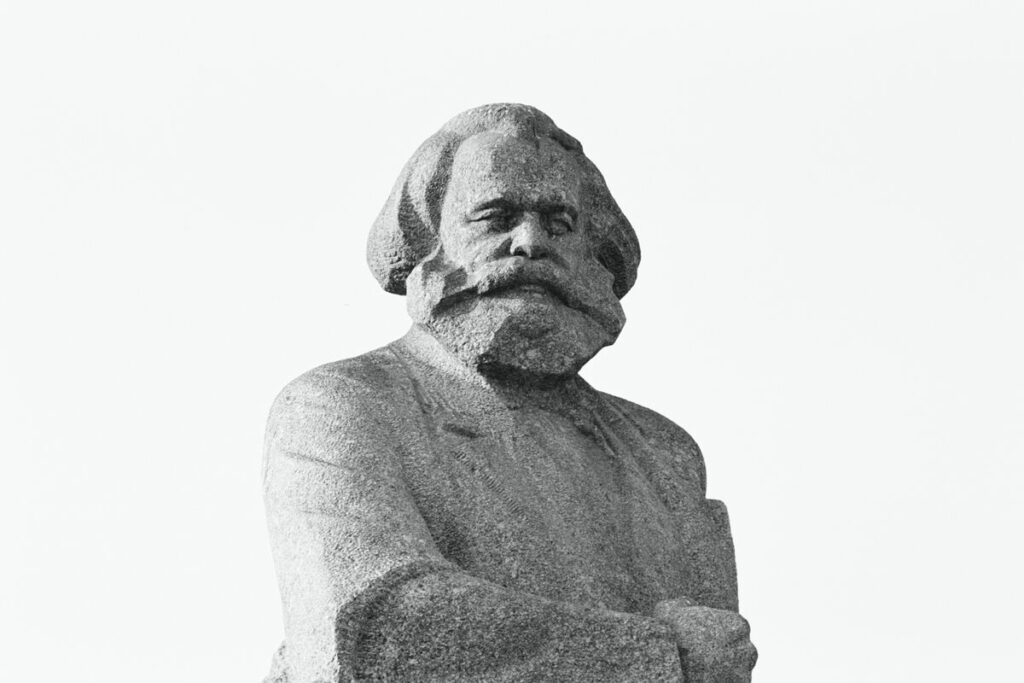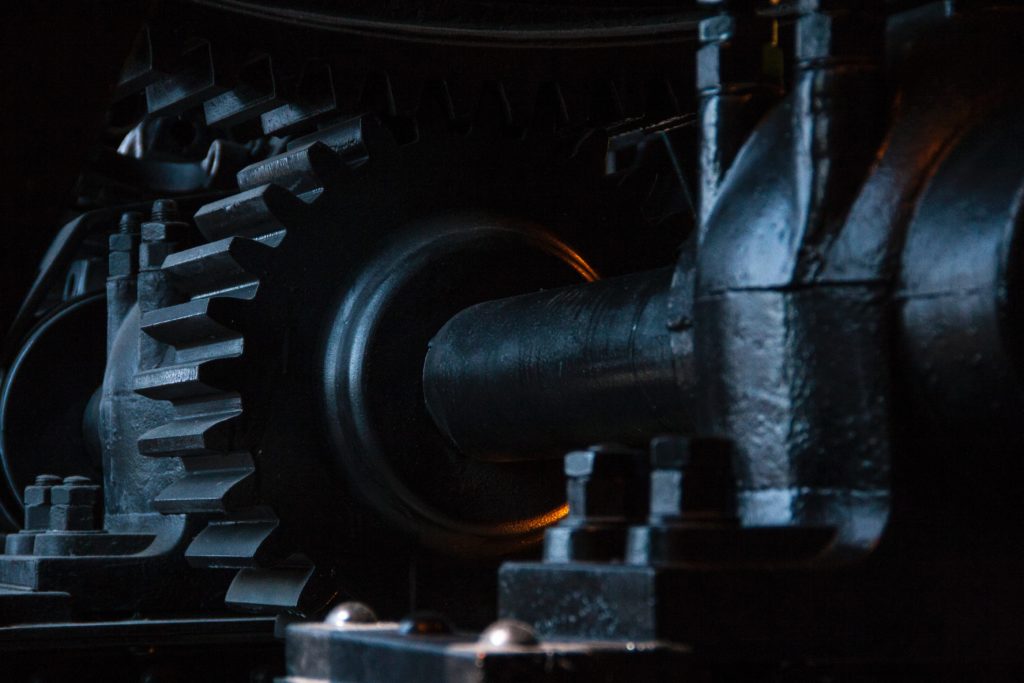«Il maggio del 1994, nei miei ricordi, fu un mese insolitamente soleggiato e caldo. A ogni intervallo i miei compagni di scuola andavano a sedersi sul prato, intrecciavano margherite e suonavano la chitarra – il mondo luccicava, la vita era un’unica, grande promessa. Mentre loro correvano spensierati incontro al futuro, io a ogni passo sprofondavo sempre più in una melma invisibile. Era come se la terra mi trascinasse giù per un eccesso di gravità. Avevo quattordici anni e conoscevo l’oscurità da un pezzo» (E. Meijer, I limiti del mio linguaggio, nottetempo, Milano 2014, p. 13).
Così Eva Meijer inizia la sua breve disamina sul “male del secolo”, la depressione, come definita dall’OMS. Lei ha vissuto questa malattia, che quasi considera una compagna di vita, ha cercato di parlarne con le persone a lei vicine ma si è resa conto che raccontare la depressione non è semplice perché ci si scontra con i limiti del linguaggio, che danno il titolo alla sua opera – I limiti del mio linguaggio. Piccola indagine filosofica sulla depressione – pubblicata a giugno in Italia.
L’autrice scrive che la cosa bella e difficile del linguaggio consiste nel non poter mai dire esattamente ciò che si vuole perché si dice sempre o di più oppure di meno. Solo riconoscendo e comprendendo questi limiti del linguaggio, l’autrice ha tentato di definire la depressione e, nel farlo, si è ricollegata alla storia della malinconia che, molto spesso, viene nominata con parole che si rivelano inappropriate a descriverla. Nata come malinconia, legata all’immagine della bile nera così cara all’anatomia antica, è poi diventata “depressione” con Freud e il suo Lutto e Melanconia (1917) e con il libro Sole nero. Depressione e melanconia (1987) di Julia Kristeva. Freud anticipa la teoria di Kristeva ma è solo quest’ultima che, per parlare del fenomeno in questione, prende in prestito una parola più recente che fa riferimento a un fenomeno geologico, alla condizione di una parte di superficie terrestre che si trova a un livello inferiore rispetto al resto della superficie vicina. Troviamo anche un’altra immagine geografica usata da Meijer per definire la malattia in questione. Immaginiamo di essere in un bosco e di camminarvi dentro. A un certo punto ci voltiamo e non ricordiamo più qual è stato il nostro punto di partenza. Siamo senza alcun punto di riferimento. Questa sensazione di disorientamento fa sì che il mondo attorno a noi aumenti e che noi, al contrario, diventiamo sempre più piccoli. Le persone depresse, per questo, non coincidono più con loro stesse e, anzi, diventano a metà tra le condizioni di presenza e assenza, tra l’essere presente, nell’hic et nunc, e il non esserlo.
Per chiarire questa coesistenza di presenza e assenza, pensiamo alle foto di Francesca Woodman, fotografa americana che realizzò numerosi autoritratti, ricordata da Meijer1. Il suo corpo è spesso presente nelle sue opere, la maggior parte delle volte nudo, ma soprattutto in movimento, appena scomparso o nell’atto di scomparire. Succede anche, a volte, che del suo corpo rimangano le impronte, oppure che se ne veda il riflesso, intero o solamente di parti, nello specchio. I corpi nelle fotografie di Woodman, dunque, sono sì presenti ma, allo stesso tempo, fanno parte di qualcosa di più grande in cui stanno, invece, scomparendo. Allo stesso tempo, la persona che soffre di depressione è presente come corpo nella realtà e allo stesso tempo è assente poiché si sente estraneo e lontano dalla realtà che vede e vive.
Un’altra artista che descrive, o meglio rappresenta, la depressione è Tracey Emin, anch’essa citata da Meijer2. Il suo lavoro più conosciuto, e più utile in quest’occasione, è My Bed, realizzato nel 1998. Si tratta di un letto sfatto, con le lenzuole bianche, dei collant e degli asciugamani appoggiati sopra. Accanto a questo letto c’è poi un tappetino blu dove sono messi, in maniera disordinata, diversi oggetti come sigarette, bottiglie di vodka, preservativi, ecc. Anche questo è un caso di presenza-assenza dell’artista, e della persona depressa, perché si tratta del letto in cui l’artista inglese ha passato quattro giorni di depressione, dopo la fine di una relazione. Questo letto è testimone della sofferenza di Emin e della sua presenza corporea, così come lo è anche lo spettatore che vede l’opera, anche se quest’ultimo non sempre ha capito che si tratta di un’opera d’arte, come nel caso di una signora che, nel 1999, ha visto questo letto disordinato a una mostra e ha voluto metterlo un po’ in ordine. L’immagine del letto è un’altra delle immagini che ben descrivono la depressione, che spesso viene vissuta proprio nel letto, in uno stato di inattività, lontano dalla vita reale. In questo luogo del sonno e del sogno, scrive Meijer, esiste un tempo sospeso, un anti-tempo in cui vive la persona depressa che è anch’essa sospesa, tra la vita e la morte.
Questa è, in breve, la condizione tra presenza e assenza, realtà e irrealtà, vita e morte che vive la persona depressa, che ha perso qualsiasi appiglio e punto di riferimento ed è anche la condizione che in alcuni momenti di tristezza e malinconia tutti noi possiamo sperimentare. Sicuramente non si tratta di una condizione piacevole e positiva, ma comprendere che il nostro corpo può essere e può stare, anche senza che la mente lo percepisca, può permetterci di rivalutare e dare più valore alla nostra presenza più vera e completa.
NOTE
1. Cfr. E. Meijer, I limiti del mio linguaggio, nottetempo, Milano 2014, pp. 21-22.
2. Cfr. ivi, pp. 22-24.
[Photo credit Yuris Alhumaydy via Unsplash]