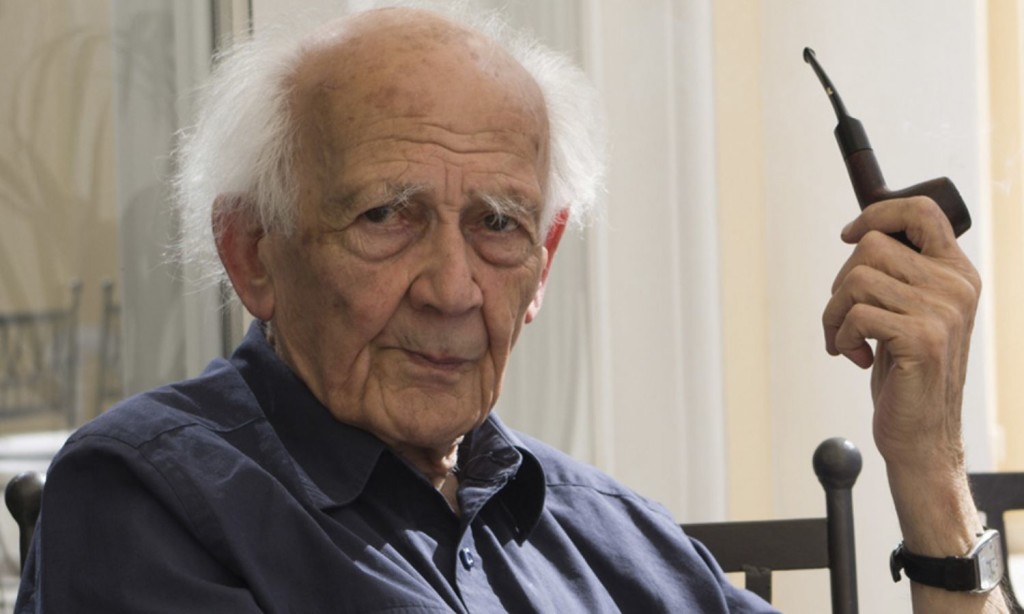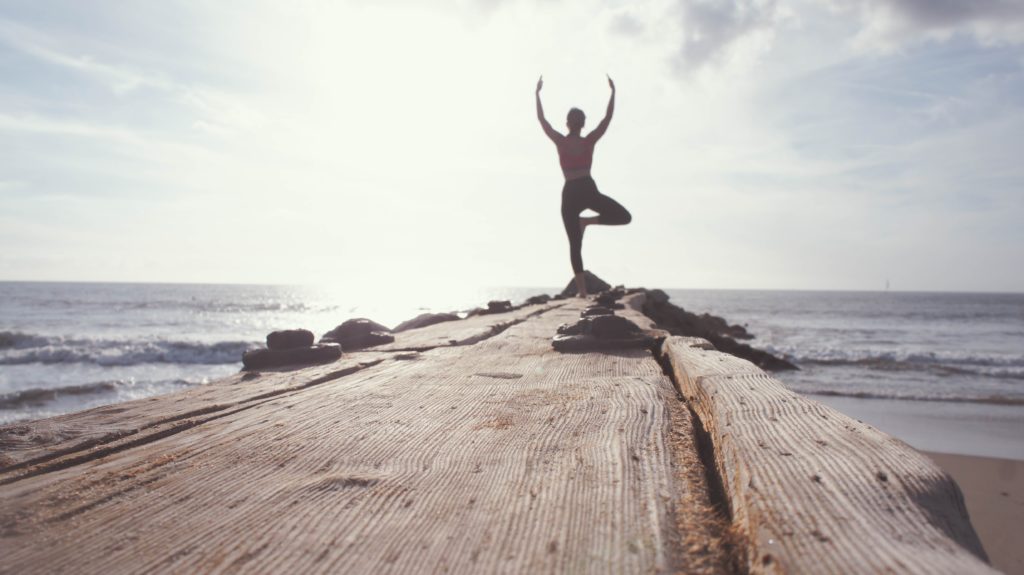La filosofia, anche da un punto di vista puramente etimologico, è da sempre legata alla sapienza e alla tensione erotica, ovvero amorosa, alla conoscenza; tale legame è però spesso sviluppato in forme e articolazioni differenti: talora denunciando i limiti dell’intelletto umano, in altri casi potenziando la pretesa della ragione a conoscere il mondo, molto spesso evidenziando quanto l’attitudine alla conoscenza e alla riflessione sia essenziale e costitutiva per l’uomo. A tal proposito, particolarmente interessante è la concezione che Søren Kierkegaard, filosofo danese dell’Ottocento, sviluppa circa tali tematiche.
Il punto di partenza de La malattia per la morte (1849) è proprio la definizione che Kierkegaard offre dell’umano:
«l’uomo è una sintesi d’infinito e di finito, di tempo e di eternità, di possibilità e necessità, insomma una sintesi. Una sintesi è un rapporto tra due principi» (S. Kierkegaard, La malattia mortale, SE, 2008, p.17).
Nella concezione del filosofo danese, il soggetto è un’unione dinamica e travagliata di elementi contrari e posti in un equilibrio fortemente precario; visto unicamente in questo modo però, si precisa, esso non è ancora un io, non è affatto spirito e dunque non è rapporto che si rapporta a se stesso. L’aggiunta che il filosofo introduce al discorso amplia fortemente la prospettiva sull’umano: l’individuo non è unicamente costruzione passiva di elementi in contrasto, ma anche riflessione su tale ed interna dinamicità. L’uomo non è dunque colui che è unicamente affetto dal proprio essere costituito nel mondo in un certo modo, ma è anche e soprattutto una tipologia di ente in grado di rivolgersi a se stesso e alle proprie insanabili dicotomie tramite la riflessione.
Il pensiero è dunque elemento caratterizzante e vivo dell’essere umano; tale concezione non deve però portare a credere che nelle pagine dell’opera kierkegaardiana esso non sia sottoposto a critica e ad analisi: per l’autore infatti, l’individuo, posto nella possibilità di comprendere se stesso, non riesce in realtà quasi mai ad intendersi pienamente, in quanto incapace di volgere lo sguardo alla potenza che lo ha posto, Dio. Ed è proprio in tale incapacità che l’individuo sviluppa, in forme diverse e con gradi differenti di coscienza, la disperazione, la malattia per la morte che è sottesa al titolo all’opera. Disperazione è «il fraintendimento [lo squilibrio] di un rapporto di sintesi che si rapporta a se stesso» (Ivi, p.19), e con ciò il peccato contro la divinità, visto come potenziamento della disperazione stessa, è continuare a disperare e non voler fondersi in Dio, nonostante esso si sia fatto uomo per comunicarci cosa sia il peccato e quanto l’umano possa avvicinarsi al divino, divenuto infatti esso stesso carne.
La disperazione non è dunque una malattia mortale, in quanto incapace di farci soccombere, ma è una malattia per la morte, finalizzata al consumarsi, che fa il gioco del lento morire nel quale l’individuo si mostra incapace di rapportarsi a se stesso e a ciò che lo ha posto. L’analisi kierkegaardiana delinea differenti forme della malattia, attuando una vera e propria «fenomenologia dello spirito disperato» (E. Rocca, Kierkegaard, Carocci, 2012, p. 242), e in ciò Kierkegaard è piuttosto chiaro nel trattare di come il pensiero non si espliciti affatto, o meglio fin da subito, come una salvezza ai nostri mali: volgersi a se stessi e alla propria problematicità nel mondo non significa infatti venir meno ad essa, essere salvi per il semplice fatto di aver volto lo sguardo alla propria condizione. Pensare è piuttosto dare luogo ad un percorso tortuoso: la disperazione del filosofo danese cresce con la coscienza che si ha di essa, e così il peccato, in quanto il peccare ha senso se posto dinanzi a Dio e l’affermazione del divino si manifesta all’uomo quando egli è più cosciente.
Non si può negare che tale tragicità non abbia in Kierkegaard la propria stessa soluzione: solo alla fine di un cammino, accettando Dio e fondendosi totalmente in esso, è possibile infatti venir meno a quello squilibrio causato dal non corretto rapporto con il trascendente, posto in realtà proprio a definizione della malattia indicata. Inoltre, il filosofo analizza una tipologia di pensiero necessitato a confluire in un’accettazione totale del divino che passa, in ultima istanza, attraverso la fede: in un mondo in cui l’umano potrebbe non essere posto da Dio, ma gettato sulla base di nessuna legge di esistenza e di necessità, forse la disperazione è nullificata o ampliata, in quanto si traduce nell’incapacità di osservare ciò che non c’è.
Nonostante le divergenze che si possono maturare e le critiche che si possono muovere a tale riflessione filosofica, come del resto a qualsiasi esercizio di pensiero, ciò che La malattia per la morte ci consegna è un quadro piuttosto realistico, tragico e speranzoso dell’umano: il soggetto non è circoscrivibile alle riflessioni che su di esso possono essere svolte, eppure è proprio tale sguardo lucido e spesso sofferente volto alla nostra esistenza, che può permetterci con Dio, o forse senza, di trovare una collocazione in essa.
NOTE
[Photo credit Stefano Pollio via Unsplash]