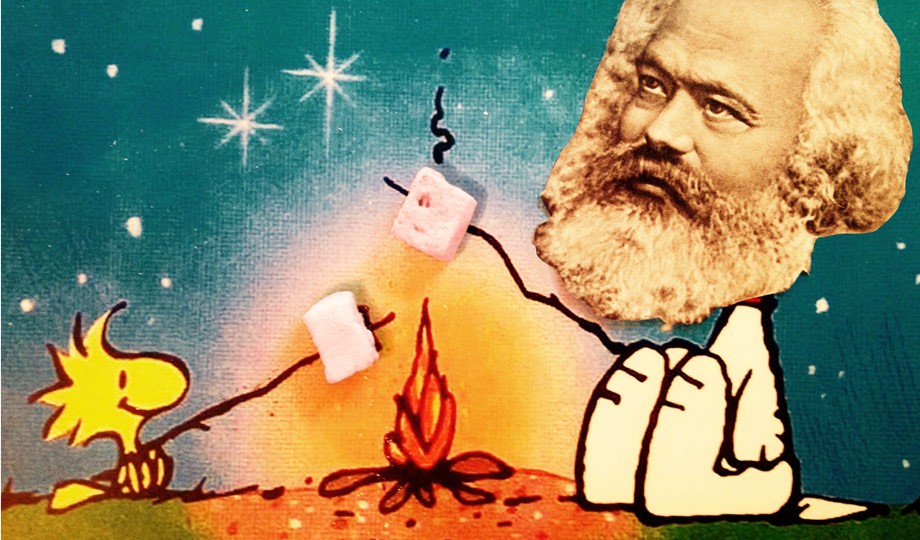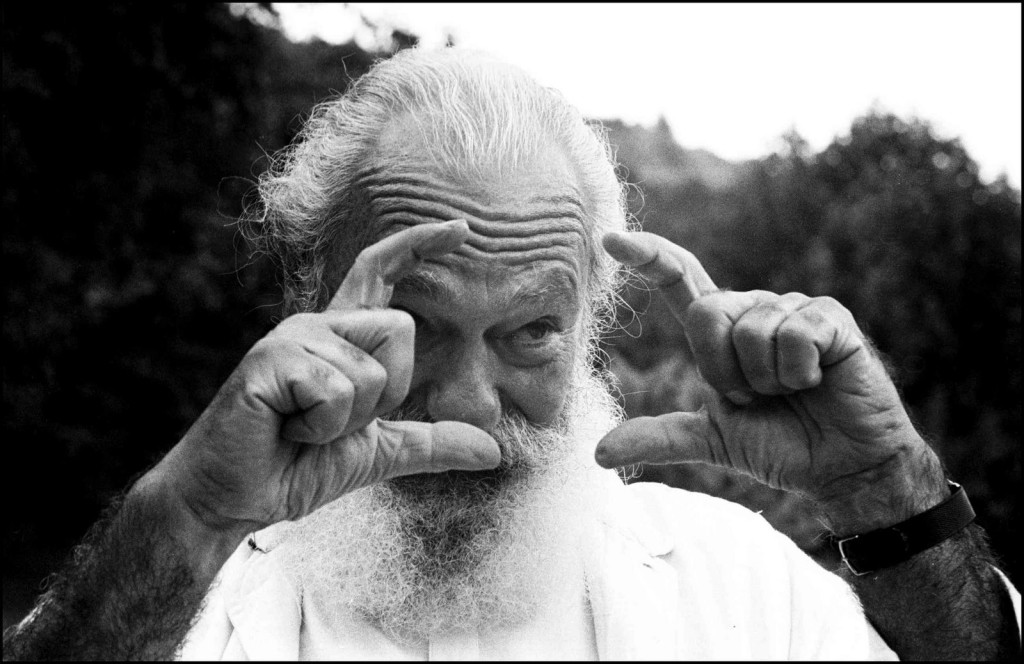Lo psicanalista Massimo Recalcati, nell’esordio della prima di tre lectio magistralis su Jacque Lacan, introduce il tema della vita umana, ponendo all’uditorio la domanda circa ciò che la caratterizza rispetto alla vita animale o non umana in generale. Recalcati risponde affermando che ciò che umanizza la vita è il bisogno di senso, ovvero che l’uomo sia caratterizzato dalla domanda sul senso della propria esistenza.
È possibile sostenere questa affermazione, partendo dalla semplice e storica constatazione del fatto che molti filosofi, artisti e scrittori abbiano esplorato in profondità la questione del senso.
Tutti noi abbiamo bisogno di senso, qualcosa che ci faccia alzare al mattino, che ci permetta di coricarci alla sera, nel silenzio, col cuore stanco ma pago. La questione è certamente faticosa: la domanda sul senso si presenta crudamente, in un giorno qualunque, e ci inchioda come la sbarra di un passaggio a livello quando siamo in ritardo.
Non è una domanda gridata, non trasuda dagli schermi, in nessun colloquio di lavoro è richiesta una risposta. Non è una domanda utile, non accresce la nostra popolarità né migliora la nostra produttività, anzi. La questione aleggia sullo sfondo dell’esistenza, senza avanzare pretese nei nostri confronti; non esige, non rivendica, non produce: solamente, sta.
Nonostante lo sforzo indefesso teso a colmare ogni istante delle nostre giornate, volto ad alimentare l’impressione di sentirci appagati e realizzati, nonostante sia possibile ignorare a lungo la domanda sul senso, essa in alcuni istanti della nostra esistenza, si presenta come un evento. Avviene attraverso una contingenza, il sistema esistenziale vacilla: un addio, un figlio che arriva, una pandemia inaspettata, il dolore, la morte. Ed è lì, in quella contingenza, che vale per noi e non per altri, proprio nel nostro più proprio esser-ci, che la domanda sul senso risale. Heidegger scrive che l’essere umano è costantemente immerso nella contingenza degli enti, cioè di tutto ciò che è, e proprio questo stare dentro la contingenza rappresenta la condizione irripetibile perché si apra la ricerca di senso:
«Esser-ci significa essere tenuto immerso nel Niente, l’esserci è già sempre oltre l’entenella sua totalità. Questo essere oltre l’ente noi lo chiamiamo trascendenza […]. Solo sul fondamento dello stupore, […] sorge il “perché?”[…]. Solo perché possiamo domandare e fondare, è assegnato alla nostra esistenza il destino della ricerca» (M. Heidegger, Che cos’è metafisica, Adelphi, 2001, p. 65).
Il fatto stesso di essere immersi nelle cose, negli eventi della vita, il fatto stesso di essere contingenti, precari, finiti, ci apre alla possibilità di porci in ricerca, del senso stesso dell’esistenza. È la nostra condizione di fragilità che ci apre la possibilità del senso. Il domandare, il metterci alla ricerca di senso pone ciascuno di noi in quell’atteggiamento di apertura verso una visione più ampia, intensa e profonda dell’esistenza e del mondo.
«La gioia nomina la possibilità di una vita sensibile alle situazioni di dischiusa, a quelle interruzioni del quotidiano che lo aprono improvvisamente a una visione già ampia e a un’intensità più profonda. Se si sopprimono queste dischiuse il mondo diviene una pianura di indistinzione e silenzio» (I. Guanzini, Filosofia della gioia, Ponte alle Grazie 2021, p. 29).
Proviamo a cambiare, dunque, la dinamica di pensiero con cui affrontiamo la questione; forse dare una risposta non è davvero necessario, forse la domanda sul senso non esiste per spingerci a formalizzarne una; probabilmente il suo agire risiede proprio in questo suo continuo restare domanda: deve rimanere viva e per farlo ha bisogno della sua inesauribilità. Noi, in quanto esseri umani, abbiamo la possibilità di esitare, come scrive il filosofo tedesco Hans Blumenberg:
«Si può dubitare se sia possibile pensare il senso della vita; sarà permesso pensarci anche senza mai riuscire ad avvicinarsi ad una risposta. La pensosità è una pausa anche rispetto ai risultati banali che il pensiero ci procura quando ci si interroga sulla vita e sulla morte, il senso e il nulla. Cultura è anche rispetto dei problemi cui non possiamo dare risposta e ci fanno riflettere e ci lasciano pensosi» (H. Blumenberg, Pensosità, Elitropia, 1980, pp. 16-18).
La pensosità è una pausa del pensiero, è permettere che domande inevase agiscano in noi, è lasciarsi condurre da esse. Questo è un invito a non affannarsi: abbiamo la possibilità di sostare, accogliere la domanda sul senso come la possibilità data al nostro pensiero di dilatarsi e ospitare l’imprevedibile, il non logico, le storture insite nell’esistenza.
Maria Chiara Pelosi
Nata nel 1992 a Cremona, dove vive e insegna in una scuola secondaria di secondo grado. Ha studiato Filosofia all’Università Cattolica di Milano prima e all’Università di Torino poi. Nel corso della sua vita, oltre che alla filosofia, si è appassionata alla lettura, alla scrittura e alla storia. Le interessa il rapporto tra il pensiero e il linguaggio, ma ha studiato anche la filosofia esistenzialista e postmoderna. Per lavoro ha approfondito i temi della didattica, dei processi di apprendimento e della salute mentale. È mamma di un bambino e di una bambina. Di notte scrive poesie.
NOTE
[Photo credit Rob Mulally via Unsplash]