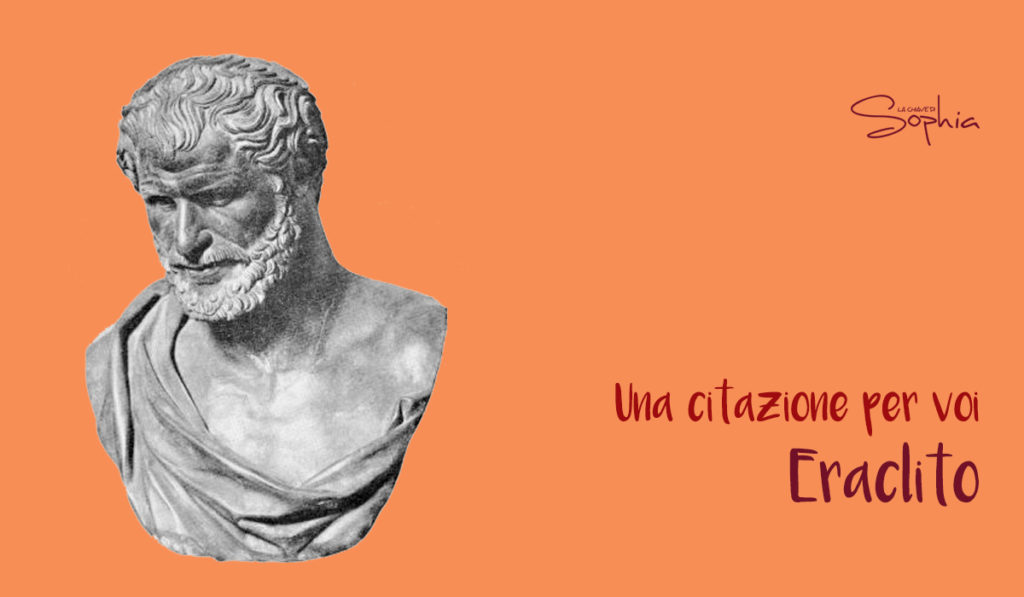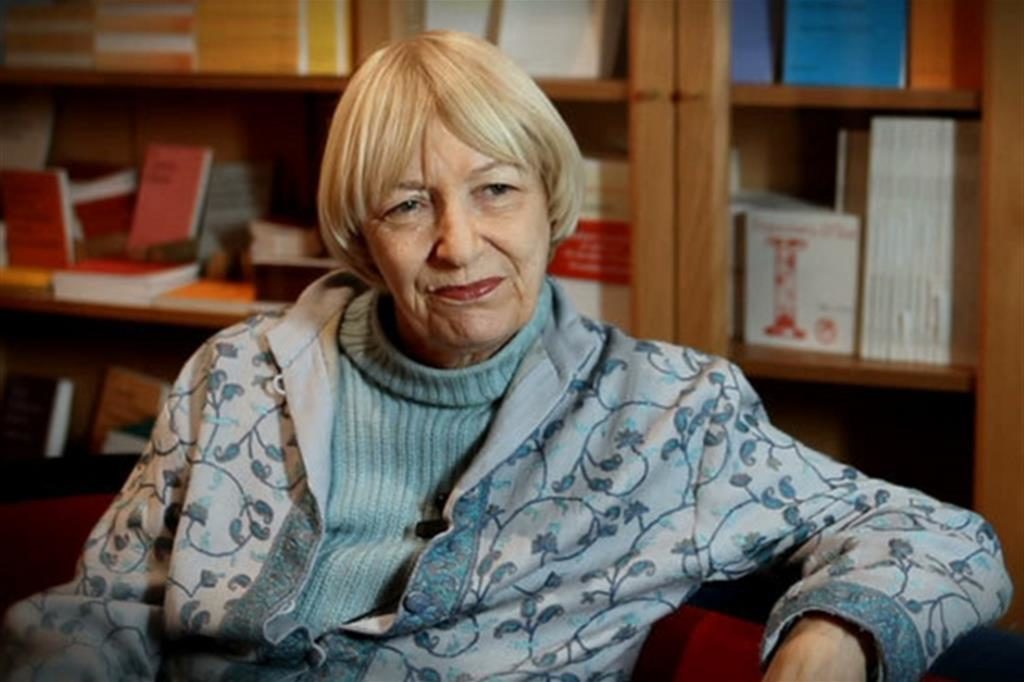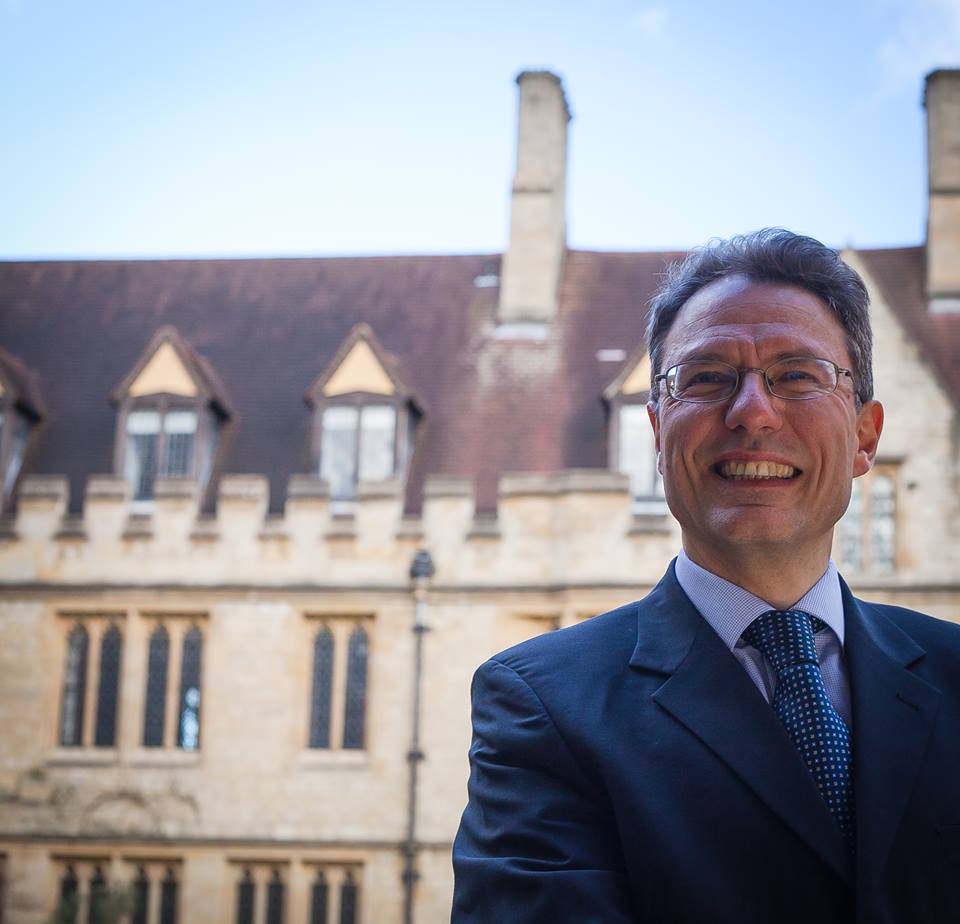La generazione Z – che non ha memoria di un tempo senza Internet ed è stata definita dalla psicologa Jean Marie Twenge come iGen, generazione iPhone – è la prima ad essersi approcciata ai social media durante un periodo cruciale per la costruzione dell’identità: l’adolescenza1. Questa rinascita sociale, in cui l’individuo diventa altro da sé, per usare una rappresentazione cara ad Hegel, è fatta di incontri sociali, di accettazioni, identificazioni, rifiuti. Imparare, comunicare, cercare approvazione, sono attività caratterizzanti questa fase cruciale di sviluppo, e sono ormai quasi sempre mediate dai social network: un cambiamento dalla portata rivoluzionaria2.
Per la iGen, quindi, la rinascita dell’adolescenza non è solo sociale, ma è social, perché è Internet il luogo di aggregazione e di incontro, il luogo di confronto e di formazione in cui si diventa adulti. Costruire su Instagram o su TikTok la propria identità significa scegliere cosa mostrare agli altri di sé e cosa no, e magari cambiare veste a seconda del profilo utilizzato. L’identità digitale per un adolescente è una sorta di marchio, il suo brand, e la bravura consiste proprio nella selezione di quegli aspetti che risulteranno essere socialmente più accettabili e più apprezzati.
La facilitazione di questa costruzione virtuale passa senz’altro per l’assenza del corpo, spesso ingombrante in una fase di transizione, che fa sentire protetti in un’espressione di sé mediata dallo schermo, e può dare l’impressione di essere sempre più simili al proprio sé ideale che a quello reale3.
Il confronto sociale all’interno del gruppo dei pari, che stimola la creatività, la progettualità, e la stessa creazione della personalità, in questa fase passa attraverso modelli di riferimento. Un tempo fratelli più grandi, compagni di scuola popolari, leader carismatici, spesso trasgressivi, rappresentavano gli ideali di riferimento con cui identificarsi, da imitare, per ottenere bellezza, fama, successo. Spesso questo processo di emulazione poteva essere tale da offuscare la capacità di giudizio e da produrre o subire livelli di conformismo importanti, anche rispetto a comportamenti irresponsabili o devianti. Oggi quei modelli si trovano online: influencer, personaggi famosi che si sono arricchiti proprio grazie alla loro immagine e devono alla rete la loro notorietà, idoli che ostentano vite lussuose e divertenti; ma anche semplici compagni di scuola, che magari sono diventati popolari sui social, hanno molti follower (spesso decine di migliaia) e vantano il pubblico apprezzamento delle loro vite digitali.
In questa vasta gamma di identità disponibili, non più vincolate alla classe sociale, al genere, al gruppo, si trova un grande conforto nelle vite digitali altrui, come se si potesse recensire la vita con un numero di stelle pari al successo che si riesce ad ottenere. Queste agenzie di socializzazione digitale non forniscono leader, ma solo influencer di varia natura, che hanno un ruolo profondamente diverso da quello dei leader: non si deve loro nessuna obbedienza, non c’è nessuna causa comune per cui lottare e la lontananza elimina la possibilità di dissenso, confronto, frizione e scontro, o meglio, la relega alla sfera digitale, mediata dagli schermi, e quindi meno reale.
Attraverso legami digitali non sempre si costruiscono vincoli forti, supportati dalla condivisione di esperienze reali, da un confronto su problematiche vere, agite, che accadono nel mondo. Questo rischia di creare lacune nello sviluppo delle competenze sociali indispensabili per costruirsi una rete (un network) di fiducia e di supporto, confinando gli adolescenti nel proprio rifugio digitale4. Per questi motivi si rende necessaria una presa di coscienza, e forse di posizione, relativamente all’enorme cambiamento culturale che sta investendo la prima generazione di nativi digitali, che corrono il concreto rischio di smarrirsi nella giungla sociale (e social), priva di punti di riferimento relazionali, specialmente in una fase così delicata per la definizione della propria identità, in cui si necessita di figure reali che supportino la formulazione di una risposta fondamentale ad una domanda complessa: chi sono io?
NOTE
1. Cfr. J. M. Twenge, iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy anche Completely Unprepared for Adulthood, Simon & Schuster, New York, 2017, pp. IV-XII.
2. Cfr. D. Miller, Daniel, Social Media and Social Relationships, in “Social Media in an English Village” vol. 2, UCL Press, 2016, pp. 92–121.
3. Cfr. C. R. Rogeno, Client Centered Therapy Its Current Practise, Implications, and Theory, Houghton Mifflin, 1951, pp.40-43.
4. Z. Bauman, E. Mauro, Babel, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015, p.89.
[Photo credit George Pagan III via Unsplash.com]
Laura Muzzetto
Nata a Cagliari nel 1985, si è laureata in Sociologia a Pisa nel 2011 e lì ha conseguito il Dottorato in Filosofia del Diritto. Dopo un lungo soggiorno toscano tra Pisa e Firenze è tornata nella sua città dove insegna Scienze Umane e Filosofia in un istituto superiore. Del suo lavoro le piace poter coniugare l’amore per ciò che ha studiato alle sue capacità relazionali e ciò che cerca di trasmettere alle giovani menti che incontra è una curiosità critica per le cose del mondo. Adora i gatti ma anche le persone. Le piace curiosare nei vecchi armadi alla ricerca di vestiti da far rivivere, e quando vuole respirare tranquillità va al mare. Abita con il suo compagno di vita e di avventure, la loro bambina e due gatti.