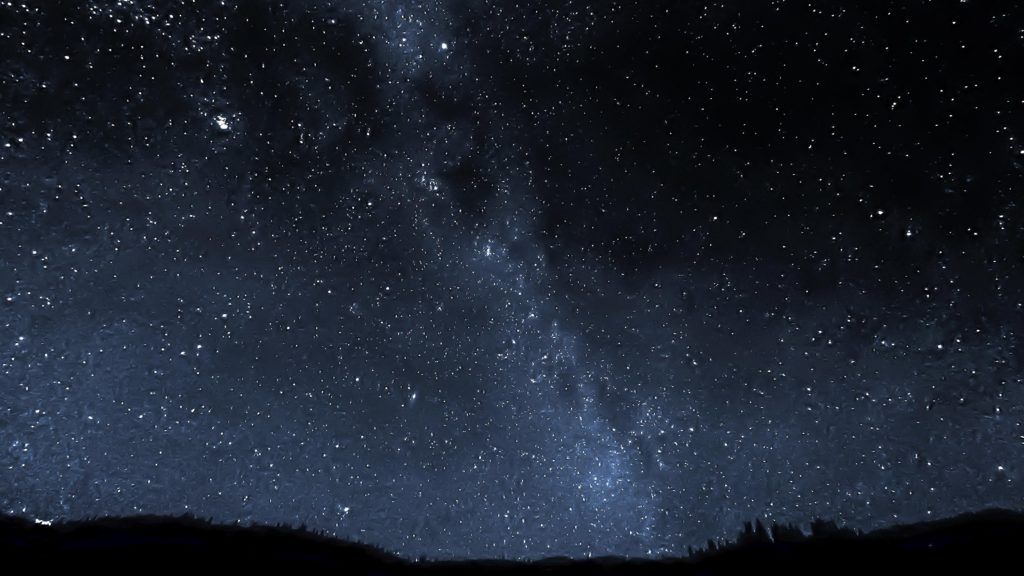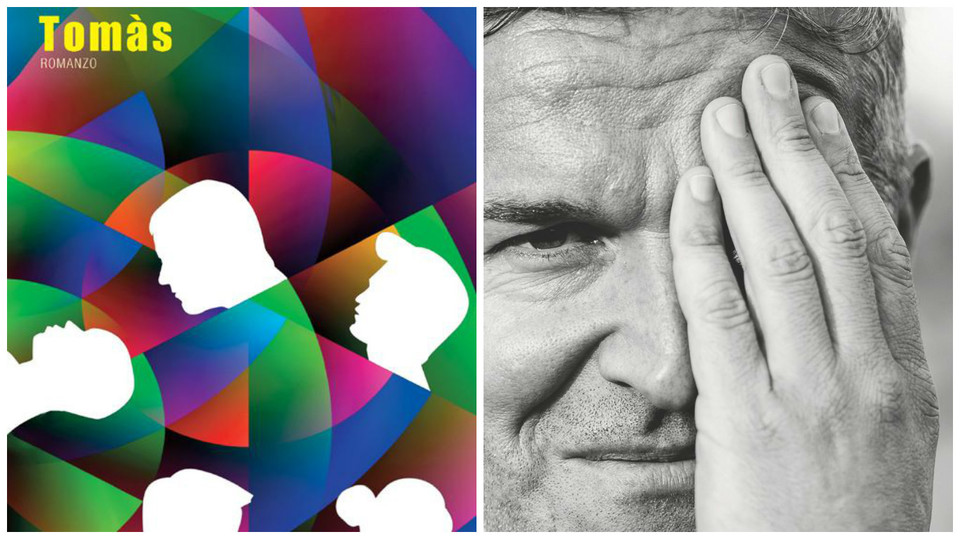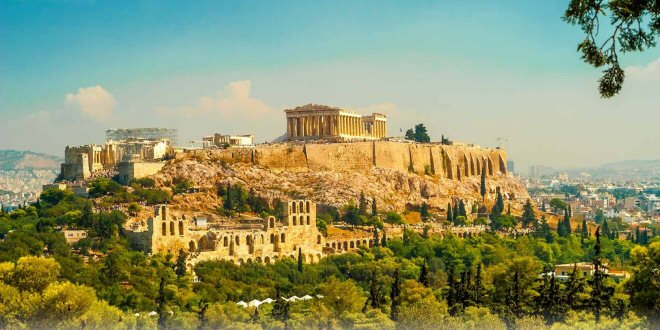I colloqui tra insegnanti e genitori sono un appuntamento accademico consolidato, un adempimento fisso e istitutivo per chi ha figli in età scolare. Al di là dell’obbligatorietà degli incontri, in cui i docenti possono informare i genitori sull’andamento scolastico e la maturazione dell’alunno o, al contrario, la famiglia ha modo di condividere dubbi, difficoltà ma anche iniziative a favore della crescita del figlio, è innegabile che i colloqui portino con sé un importante carico emotivo sia che il figlio sia uno studente modello o una causa persa allo studio.
Secondo il costruttivismo sociale la realtà, ovvero l’insieme dei fenomeni che noi riconosciamo come indipendenti dalla nostra volontà, non esiste in quanto tale ma è una costruzione sociale. Noi diamo per scontati il quotidiano, l’ambiente che ci circonda e le sue regole di funzionamento, e lo facciamo perché ne abbiamo assoluto bisogno. Si ha bisogno di non preoccuparsi della realtà ordinaria, altrimenti sarebbe impossibile vivere, compressi dall’ansia di non sapere cosa succederà, che effetti avranno le nostre azioni, da che pericoli ci si deve difendere.
Berger e Luckman, spiegano che «il mondo della vita quotidiana non è solo dato per scontato come realtà dell’uomo comune nella condotta soggettivamente significativa della sua vita. È un mondo che si origina nel suo pensiero e nella sua azione, e che grazie a questi mantiene la sua realtà» (P. L. Berger, T. Luckman, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, 1996, p. 42). Non solo, la vita quotidiana è un mondo intersoggettivo nel quale e sul quale agiamo con i nostri simili.
Il mezzo più potente e immediato per mantenere la parvenza di ordine e oggettualità della realtà è infatti il linguaggio. Scrivono gli autori: «il linguaggio usato nella vita quotidiana fornisce continuamente le necessarie oggettivazioni e postula l’ordine all’interno del quale queste hanno un senso e in cui la vita quotidiana ha un significato. Il linguaggio segna le coordinate della vita nella società e riempie quella vita di oggetti significativi» (ivi, p.50). Ciò vuol dire che attraverso le interazioni sociali quotidiane, anche le più banali, la donna e l’uomo comuni, non cercano tanto un’informazione in sé, quanto la conferma della realtà circostante. Tradotto: entrando al bar o fermandoci a fare il pieno dell’auto, durante lo scambio di convenevoli con i rispettivi gestori, non si vogliono sapere delle cose specifiche (come per esempio lo stato di salute dell’interlocutore, anziché l’aumento del prezzo del gasolio) ma che ci venga confermato che il mondo come lo intendiamo è tale anche per la persona con cui stiamo parlando. La donna e l’uomo comuni nelle interazioni sociali cercano conferme, non nozioni.
Questo vale anche in un’interazione sociale più formale, quali sono i colloqui tra insegnanti e genitori. Il genitore che si appresta a partecipare al colloquio, situazione in cui il linguaggio è lo strumento principale di azione, non cerca solo delle informazioni come i voti o le eventuali note, cerca conferme. Si attende che l’insegnante gli rimandi l’immagine che egli ha del proprio figlio, positiva o negativa che sia. Se questo non avviene, accade quello che Berger e Luckmann definiscono come uno choc culturale.
Perché questo choc può rappresentare un problema al giorno d’oggi, lo spiega la psicologa clinica Laura Pigozzi. Secondo Pigozzi stiamo assistendo ad un investimento (affettivo, emotivo e psicologico) esagerato da parte dei genitori sui figli. I motivi sono molteplici e non c’è ora lo spazio per approfondirli. Pigozzi definisce come «plusmaterno» questa tendenza della dimensione famigliare a fagocitare qualsiasi altra dimensione esistenziale e sociale1. Questo comportamento provoca asfissia nei figli e ansia e frustrazione nei genitori che si scontrano con la non corrispondenza delle due immagini: quelle della realtà famigliare e quella pubblica della scuola. A lungo andare la frustrazione dei genitori, causata appunto dalla difformità di natura egocentrica tra atteso ed esistente, può sfociare in rifiuto (anche violento) della famiglia nei confronti del mondo scolastico e pubblico in generale; basti pensare, ad esempio, all’aumento delle aggressioni fisiche a danno dei docenti. I figli invece, oppressi dalla descrizione totalizzante della realtà dei genitori, rischiano di non diventare mai adulti capaci di descrivere, e quindi creare, secondo il costruttivismo, una propria realtà identitaria e sociale autonoma, diventando dei pessimi cittadini inadatti a partecipare attivamente alla vita della collettività2.
NOTE
1. Cfr. L. Pigozzi, Il plusmaterno. La solitudine delle madri in un’epoca che chiede loro troppo, Poiesis-Alberobello, 2018.
2. Cfr. L. Pigozzi, Troppa famiglia fa male. Come la dipendenza materna crea adulti bambini (e pessimi cittadini), Rizzoli, 2024.
[Photo credit Annika Gordon via Unsplash.com]