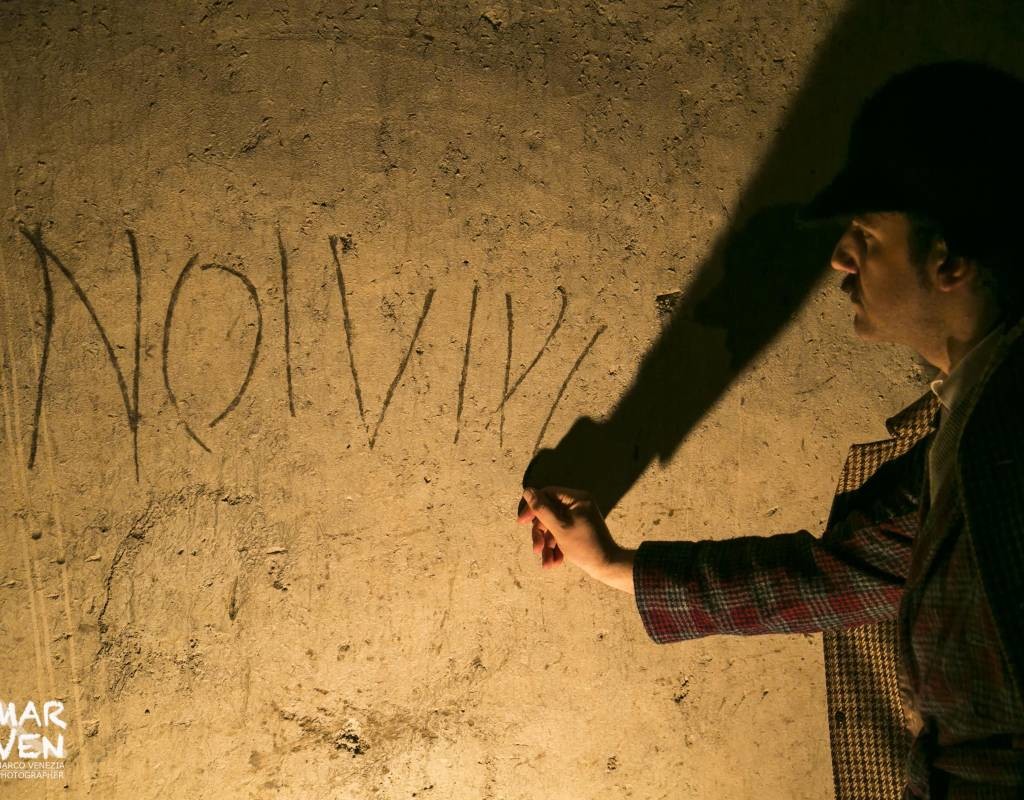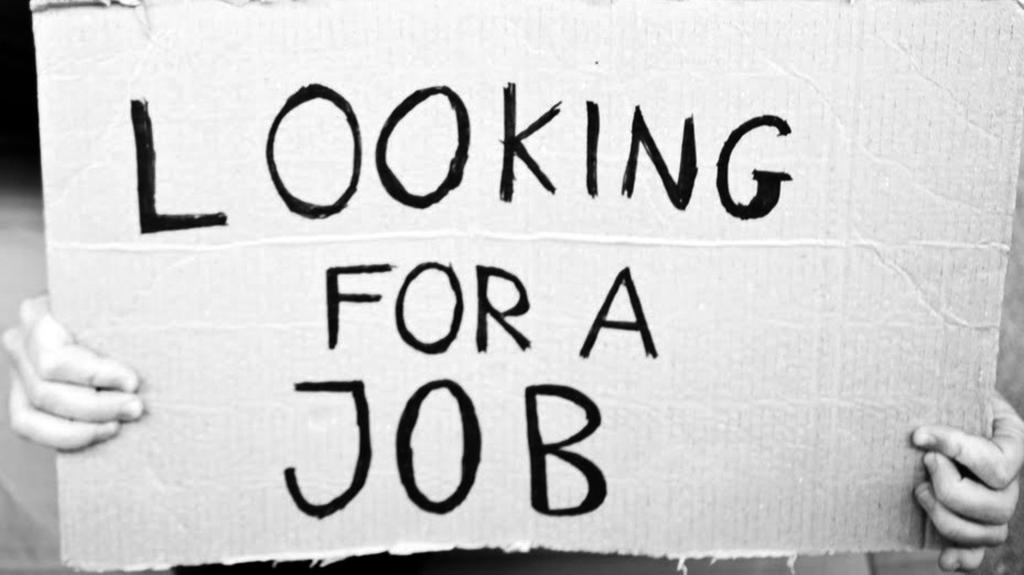In una notte di novembre dello scorso anno, Ramy Elgaml, inseguito dai carabinieri per averne forzato l’alt, muore per le vie di Milano, schiantandosi contro un muretto a bordo di uno scooter guidato dall’amico Fares Bouzidi. Aveva solo diciannove anni. Da subito sorsero dubbi sui motivi della fuga e sulle modalità dell’inseguimento. Alla ricerca di spiegazioni si aggiunsero sospetti tentativi di depistaggio e versioni contrastanti tra testimoni e forze dell’ordine. Doveroso, a questo punto, citare Franco Gabrielli, ex capo della polizia e oggi consulente per la sicurezza del Comune di Milano: «Quella non è la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, perché c’è pur sempre una targa, un veicolo… Esiste il principio di proporzionalità delle azioni… Se il tema è fermare una persona che sta scappando, non posso metterla in una condizione di pericolo»1.
Ramy era figlio di immigrati egiziani, quota di seconda generazione nelle statistiche migratorie. Nella cronaca e nel linguaggio comune da «giovane ragazzo» diventa spesso «giovane straniero». Quanto il linguaggio, secondo Ferdinand de Saussure, sia un sistema di segni arbitrari che organizza e struttura il nostro modo di vedere il mondo la dice lunga sulla percezione sociale degli eventi (cfr. F. de Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza, 1916). La sociologia studia da tempo le condizioni delle seconde generazioni, ingabbiate tra cultura d’origine e culture ospitanti. Anche in Italia, studiosi come Maurizio Ambrosini e Stefano Allievi hanno evidenziato come il destino delle seconde generazioni sia legato alle politiche di inclusione, all’accesso all’istruzione e al lavoro, nonché al riconoscimento identitario da parte della società. Nel frattempo, la comunità di Ramy insorge accusando i carabinieri coinvolti di profilazione razziale, ovvero ciò che la Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza definisce come: «l’uso, da parte delle forze dell’ordine, quando procedono a operazioni di controllo, sorveglianza o indagine, di motivi quali la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole» (ECRI, Consiglio d’Europa, 29 giugno 2007). Ancora, in un rapporto del 2024: «L’ECRI segnala numerose testimonianze di profilazione razziale, in particolare nei confronti di Rom e persone di origine africana» (ECRI, Rapporto sull’Italia, Consiglio d’Europa, 22 ottobre 2024).
Abdelmalek Sayad, sociologo algerino, nel suo testo La doppia assenza analizza la condizione dei migranti algerini e dei loro figli agli occhi della popolazione ospitante francese. Parte dal definire la presenza dell’immigrato come segnata dall’incompletezza: una presenza fuori posto, fuori dallo spazio e dalla morale, intrinsecamente delinquente se pensata con le categorie del pensiero di Stato. Sarebbe quindi lo Stato, per sua stessa natura, a discriminare e dividere i nazionali dagli altri. La presenza in seno alla nazione di non-nazionali perturba l’intero ordine nazionale, la sua perfezione mitica (cfr. A. Sayad, La doppia assenza, Raffaello Cortina, 2002, p. 369). La naturalizzazione del concetto di Stato rende legittimo tutto ciò che è dentro e illegittimo tutto ciò che vi entra dall’esterno, come gli stessi immigrati. Inconsciamente, quindi, il fatto di essere immigrato non rappresenta un elemento neutro nel sistema delle valutazioni e dei giudizi di chi lo vive. Tutto ciò che il pensiero di Stato definisce è funzionale al mantenimento dell’ordine sociale e della sicurezza dei suoi cittadini (cfr. ivi, p. 370). L’essere immigrato, non previsto nell’ordine delle cose, diviene per Sayad un reato latente, camuffato, di cui il soggetto non ha alcuna responsabilità (cfr. ivi, p. 372). Da qui la nozione di doppia pena, che esiste intrinsecamente nella mente dei «nazionali». Tutto avviene come se l’immigrazione fosse intrinsecamente delinquente, se pensata con le nostre categorie di pensiero, che coincidono con le categorie nazionali (cfr. ivi, p. 373). Ma il culmine della devianza nei confronti di ciò che si intende nazionale sembra essere toccato dai figli degli immigrati, proprio come Ramy. Non sono stranieri dal punto di vista culturale, scrive Sayad, ma agli occhi di alcuni sono senza dubbio cattivi, soggetti poco chiari, equivoci, che confondono i valori simbolici e la gerarchia della società ospitante. Attentano al significato diacritico tra nazionali e non-nazionali del pensiero di Stato, innescando la paura nei loro confronti, che spesso sfocia in angoscia collettiva (cfr. ivi, p. 382). Da questo momento, il sospetto peserà sempre sugli stessi individui, appartenenti alle oramai definite classi pericolose (cfr. ivi, p. 383).
Se la condizione algerina può essere ritenuta esemplare per tutte le altre realtà migratorie, come Sayad stesso afferma (cfr. ivi, p. 89), allora Ramy potrebbe aver pagato con la sua stessa vita una doppia colpa. La colpa di trovarsi fuori posto si sarebbe sommata all’oggettiva colpa della fuga. Il tempo ci dirà se, come il delitto del Circeo per i movimenti femministi, la morte del giovane Ramy possa risvegliare le coscienze sul bisogno di una migliore politica di integrazione oltreché di un nuovo paradigma di accoglienza, in un Paese nel quale, citando don Mattia Ferrari: «la solidarietà sembra essere diventata sovversione»2.
NOTE
1. Dichiarazione riportata nell’intervista su Radio 24 del 9 gennaio 2025.
2. Dichiarazione riportata nell’intervista a “Che Tempo Che Fa” del 2 febbraio 2025.
[Photo credit Mitchel Lensink via Unsplash.com]