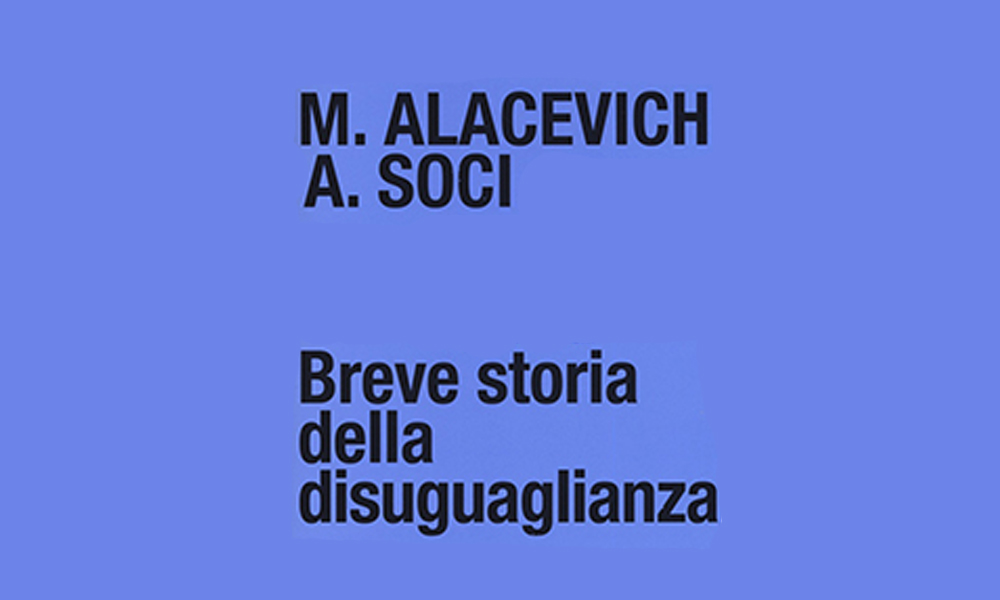La religione è uno degli aspetti più ricorrenti nell’umanità: ogni civiltà, in ricerca di risposte al senso dell’esistenza, si è voltata verso delle narrazioni per acquietare lo spaesamento. Nonostante ciò, nella nostra società occidentale trova sempre meno spazio a seguito delle continue conquiste scientifiche e razionali. La domanda, in tali circostanze, sembra ovvia: ha ancora senso parlare di religione nell’Occidente non-religioso? Per rispondere, seguiremo Dietrich Bonhoeffer.
Arrestato nell’aprile 1943 in quanto partecipante a una congiura contro Hitler, Bonhoeffer, nelle sue lettere scritte dal carcere di Tegel, non ha mai smesso di sottolineare l’importanza della responsabilità religiosa entro un contesto secolarizzato. Laddove ormai la religione si è ritirata ai limiti della vita, ossia la morte e la malattia, il teologo sottolinea come debba reinventarsi per fare fronte al mondo diventato adulto. Nelle sue lettere ribadisce, infatti, il ruolo della Chiesa:
«La Chiesa non sta lì dove vengono meno le capacità umane, ai limiti, ma sta al centro del villaggio» (D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, San Paolo Edizioni, Milano 2015, p. 423).
Il problema di oggi, però, è chi frequenta il centro del villaggio: non dei credenti, che riconoscono il ruolo della Chiesa, ma uomini distanti dalla fede. Eppure, Bonhoeffer si rivolge a loro: privi di preconcetti nei riguardi di Dio, vivono il privilegio di non spingerlo ai limiti dell’esistenza. Se, infatti, dovesse arrivare il giorno in cui si dimostrerà l’inesistenza di un “a priori religioso”, come sarà possibile parlare ai cristiani che perderanno anche l’ultimo interesse per le questioni marginali? I non-religiosi diventano il focus su cui porre l’attenzione, concentrandosi sulla loro quotidianità. In questa direzione, Bonhoeffer pone enfasi sulla figura di Gesù: in quanto incarnazione di Dio, ha mostrato che la mondanità è essenziale per gustare tutta la polifonia della vita. Soffermandosi sul farsi carne, esiste allora un punto di contatto tra Gesù e gli atei, riscontrabile nella condizione umana:
«La maggiore età del mondo allora non è più occasione di polemica e apologetica, ma viene realmente compresa meglio di quanto non si comprenda essa stessa, e cioè a partire dall’evangelo, da Cristo» (ivi, p. 467).
Entro questa condizione, Gesù aiutava sempre gli altri con l’idea di creare una fratellanza generalizzata per alleggerire le gravosità della vita. Non è un caso che Bonhoeffer lo innalzi ad archetipo dell’essere-per-gli-altri: fare del bene al prossimo per testimoniare la grandezza umana, simboleggiata dalla concordia costruibile tra individui. Solo supportandoci reciprocamente è, allora, possibile creare l’umanità nel vero senso della parola poiché nella banalità delle azioni quotidiane, svolte a fini di bene, si nasconde ciò che c’è di più importante. Il ruolo del cristiano riceve un nuovo senso:
«Essere cristiano non significare essere religioso in un determinato modo, fare qualcosa di sé stessi (un peccatore, un penitente o un santo) in base ad una certa metodica, ma significa essere uomini; Cristo crea in noi non un tipo d’uomo, ma un uomo» (ivi, p. 505).
Accanto alla preservazione dell’umanità, dobbiamo però esserne degni. L’episodio del Getsemani è esemplare a tal riguardo: dobbiamo essere disposti a non abbandonare Gesù, simboleggiante l’umanità, nei momenti difficili. Anziché comportarci come gli apostoli che si addormentano durante la veglia del loro maestro che teme la sua fine, dobbiamo essergli il più vicino possibile. Affinché ri-ottenga la sua centralità nel villaggio presso i non-religiosi, allora, la Chiesa dovrà dare l’esempio tanto della preservazione quanto della dignità:
«La Chiesa dovrà opporsi ai vizi dell’hybris, dell’adorazione della forza, dell’invidia e dell’illusionismo, quali radici di tutti i mali. Essa dovrà parlare di misura, autenticità, fiducia, fedeltà, costanza, pazienza, disciplina, umiltà, sobrietà, modestia» (ivi, p. 532).
Bonhoeffer ha vissuto appieno questi ideali: in uno dei momenti di maggiore bisogno dell’umanità, ha deciso di non abbandonarla ma di agire. Opponendosi al nazismo, antitesi della mondanità in quanto disposto a sacrificare gli esseri umani, ha partecipato alla congiura in nome dell’essere-per-altri. Trasferito nel lager di Flossenbürg, venne condannato all’impiccagione il 9 aprile del 1945.
Comprese le vicende di Bonhoeffer, torniamo alla domanda iniziale: la religione per l’Occidente ha ancora senso, solo che richiede opportuni riguardi circa i cambiamenti avvenuti in modo da garantirne la sopravvivenza. Bonhoeffer è un esempio degno di nota a tali fini: adattando il cristianesimo a un mondo ormai cambiato, non ha mai smesso di incarnarlo, fino a sacrificarsi contro la degenerazione nazista. Per i nostri tempi, una tale degenerazione non albeggia all’orizzonte ma occorre ugualmente riguardarsi: se il sonno della ragione genera mostri, occorre evitare che essa si addormenti. E ciò è possibile agendo in modo religioso entro un contesto non-religioso, esattamente come Bonhoeffer.
NOTE
[Photo credit Scott Rodgerson via Unsplash]