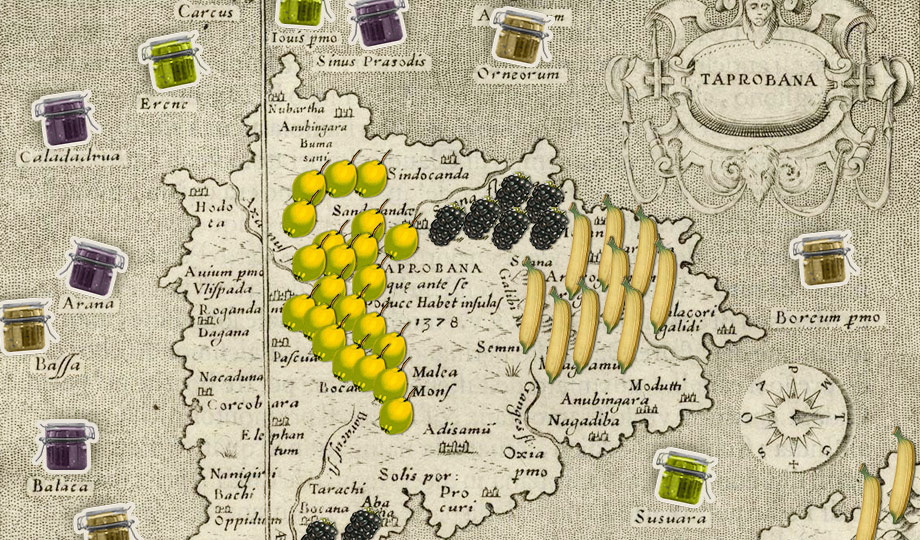Stavo dialogando con una ragazza del posto nei pressi di Tokyo, quando le confessai la mia incapacità di capire cosa volesse dire Wabi sabi. Senza molti giri di parole, mi disse che le ragioni sono da ricercare nel fatto che il Wabi sabi non ha una definizione: l’espressione sfugge infatti a qualsiasi intento definitorio da parte dello sguardo occidentale che, assetato di conoscenza, disseziona la realtà, analizzandola a partire da ragionamenti logico-razionali che pretendano di esaurire tutti i significati del reale sottoponendoli alle grinfie della definizione. La ragione qui non c’entra nulla, mi disse, perché il Wabi sabi mobilita una modalità di percezione che coglie i significati a partire da una “connessione” originaria e intuitiva con la natura, motivo per cui esso non si conosce, ma lo si sente, ad esempio, quando si ode il frinire dei grilli. Sono così andata alla ricerca del Wabi sabi in quei posti dove la ragazza mi aveva consigliato di andare: i giardini zen di Kyoto.
Mi sono recata a visitare il tempio buddista Ryōan-ji, che presenta uno dei più celebri giardini karesansui, un giardino “secco”, semplice, a forma di rettangolo in cui sono rinchiuse quindici pietre di grandezza differente e disposte in cinque gruppi. Le pietre sono state collocate in modo tale che, da qualsiasi punto le si guardi, non si possano vedere tutte e quindici contemporaneamente. Una prima interpretazione di questa insolita disposizione considera il giardino come una “palestra” per la mente, che deve indurre l’uomo a una profonda meditazione su di sé. L’impossibilità di vedere tutte le pietre corrisponde all’impossibilità di conoscere la realtà nella sua interezza, e la meditazione generata dalla contemplazione del giardino conduce l’uomo all’accettazione dei propri limiti e alla gioia derivante dalla volontà di non superarli. Lì ho capito, almeno vagamente, cosa fosse il Wabi Sabi.
Una forma di percezione del reale, in cui la natura entra in gioco divenendo veicolo di significati che sorpassano la comprensione umana. Non è un caso che negli anni Novanta il termine entri nel gergo occidentale per descrivere l’accettazione di uno stato in continua imperfezione dei software. Nella cultura giapponese il termine indica piuttosto una visione estetica che rimanda all’accettazione della transitorietà di tutte le cose, della loro natura impermanente e caduca, della loro “semplicità imperfetta”, povera, appassita. Si può dire che tutto ciò che suscita melanconia e serenità è Wabi sabi. Tutto quello che si poteva osservare nel giardino del tempio erano infatti le quindici pietre. Nessuna decorazione, nessun ornamento per opera della mano umana.
Il Wabi sabi non è. Non è una cosa da possedere, ma qualcosa che si costruisce come “evento” che inganna la sua essenza attraverso la forma sostantivata. È un “tra” che sta in mezzo alla natura e all’uomo, senza mai lasciarsi afferrare. E proprio per questo, l’unico medium in grado di cogliere il messaggio veicolato dalla natura è la poesia, la quale non afferra le cose pretendendo di definirle, ma posando lo sguardo sulla semplicità quasi “banale” della natura, si limita a osservarla. «Il castagno vicino alla grondaia, in magnifica fioritura, passa inosservato, dall’uomo di questo mondo» (M. Basho, Narrow Road to the deep North, Penguin, 1966, p. 108) scriveva Basho, cogliendo in tutta la laconicità dell’haiku la potenza pervasiva della bellezza naturale che non si lascia facilmente catturare dalla mente umana. Il Wabi sabi impone un distacco dall’ego e dal mondo materiale, come unica condizione che dischiude la possibilità di un’esperienza estetica che sia al tempo stesso veicolo di significati religiosi.
Forse questo getta luce sulle ragioni per cui l’esperienza del Wabi sabi non sia facilmente accessibile. L’aspirazione squisitamente occidentale di definire ogni cosa genera una distanza tra chi siamo e ciò che vogliamo conoscere. L’uomo ha cominciato a osservare la natura non con lo scopo esclusivo di contemplarla, ma per cercare di capire come sia strutturata e quali vantaggi possa offrire per se stesso. Per poter definire qualcosa occorre prendere le distanze dall’oggetto da analizzare, nella convinzione che più conosciamo qualcosa, più la possediamo. Questo genera una natura alienata, una natura che si è staccata, anzi che abbiamo deciso di staccare dall’originaria unione che ci legava a essa. Sempre più conosciuta, ma sempre più lontana, la natura ha smesso di essere fonte inesauribile di significati per diventare oggetto del nostro dominio. Ne conosciamo le leggi, le particelle, i moti, ma abbiamo del tutto trascurato la sua vera essenza. Forse allora, quando veramente avremo smesso di dominarla, potremmo percepire il Wabi sabi.
NOTE
Photocredit Galen Crout via Unsplash
Veronica Fioranzato
Ha preso la laurea triennale presso l’Università degli studi di Padova e ora sta conseguendo la laurea specialistica in Scienze filosofiche all’Università di Verona con una tesi sulla concezione pratica della filosofia nel tardo illuminismo tedesco. Da sempre studentessa-lavoratrice, a marzo si è licenziata per andare a studiare cinque mesi alla Rikkyo University di Tokyo, in cui ha approfondito i suoi studi sul pensiero orientale.