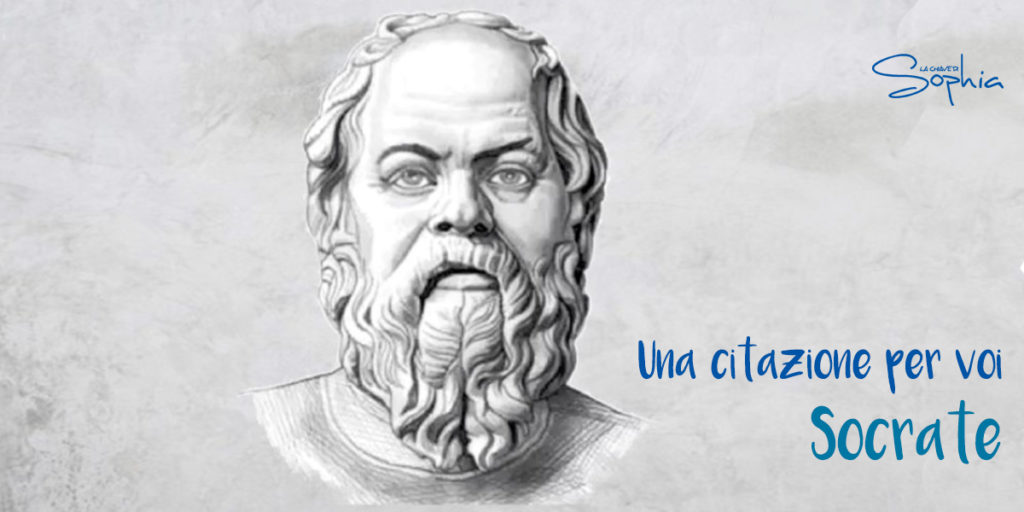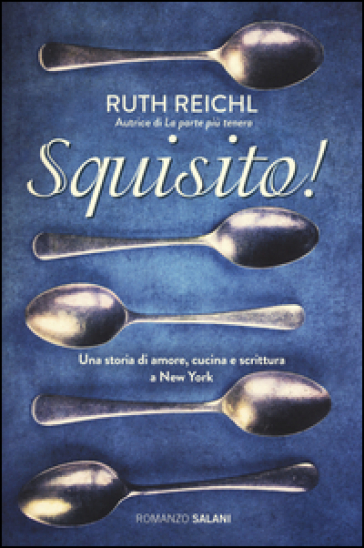Noi siamo come abituati a pensare che le regioni del concreto e quelle dell’astratto non si tocchino; che a parlare astrattamente si dimentichi la realtà, mentre a farlo concretamente si abbia – sulla realtà – presa più efficace, sicura, muscolosa. Così, si finisce per pronunciare la parola astratto quasi con una smorfia sul viso, guardinghi, e di chi parla per astrazioni ci si fida dopo attenta valutazione.
Noi dunque, noi frequentatori della filosofia, saremmo anche frequentatori delle eteree lande dei cumulonembi, delle nubi dell’astrattezza, preoccupati, impauriti dalla realtà del concreto. E, per estensione, la stessa storia della filosofia avrebbe visto passare avanti a sé filosofi troppo astratti, albergatori del cielo della verità, e filosofi più vicini al concreto, ben provvisti di robusto senso del reale. Hegel da una parte, Marx dall’altra.
Ciò che vorremmo è dissolvere la contesa – e con essa il problema, ovvero tentare di mostrare come concreto e astratto siano uno, come in realtà siano lo stesso. E lo faremo così, retrocedendo rispetto ai termini della disputa per guardare all’etimo della parola filosofia. Ora, filosofia è nome greco, ed è la composizione − la felice composizione − di altri due nomi greci: sophia e philia. Cominciamo con il primo.
Philia, solitamente è tradotto con amore. Ebbene, philia non indica esattamente l’amore, e ciò lo testimonia il vastissimo ventaglio lessicale con il quale la lingua greca ricopre la semantica dell’amore, di cui il sostantivo eros è solo l’esempio più noto. Philia denota piuttosto l’affinità, la cura, la vicinanza d’animo – non l’amicizia, qualcosa di più profondo, di più sottile. Philoi sono i compagni di Achille, l’Achille irato dell’Iliade che solo ai compagni concedeva di entrare nella sua tenda; Platone, nella Repubblica, chiama philoe le cagnette, e lo sono per le attenzioni e le cure e i riguardi che prestano ai loro cuccioli. Non amore, neanche amicizia, come detto – affinità, piuttosto, cura: questo è philia.
Sophia, invece, è il sapere. Sophos, il sapiente, è tale perché detiene il sophos, il sapere – appunto. Ma in sophia risuona il sostantivo phos: luce. Dunque, il sapere che è sophia non è la certezza che le cose siano così e non colà, che marzo è primavera e dicembre inverno; sophia è il sapere che illumina – è il sapere della luce, che, come diceva Vico, «in tal densa notte di tenebre» «apparisce» e «non tramonta».
Ritorniamo ora al sostantivo composto, filosofia, e raffiniamone l’analisi: filosofia non è l’amore per il sapere; filosofia è l’affinità con un sapere, il sapere che illumina; è l’affinità che nasce e matura e vive nel prendersi cura del sapere, che lega indissolubilmente l’uno all’altro, sapere e cura del sapere, al costo di gioie e patimenti – come la cagna con i suoi cuccioli.
Il nesso che lega la filosofia alla luce è inscindibile, è connaturato alla peculiarità del sapere che rende la filosofia tale: il sapere che illumina. E sciolto l’etimo del sostantivo filosofia, si capisce anche perché un poeta, e filosofo, come Dante nell’ultima Cantica della Commedia invochi Apollo, dio della luce, e non le Muse. Dante abbisogna della luce di Apollo, così che la sua memoria possa restare forte e trattenere la stampa impressale dalla conoscenza più alta, la visione di Dio.
Proseguiamo. Foucault ha mostrato che il termine “conversione” nasce al di fuori del contesto religioso entro il quale tendiamo oggi a relegarlo. È Platone ad impiegarlo nel suo Alcibiade I, e poi con lui le scuole ellenistiche, quelle alessandrine, e giù giù fino al cristianesimo medievale. In Platone “conversione” è l’atto del cambiamento radicale, è il dorso della mano che si volge in palmo, è la curva del tornante che ripiega nella montagna e lascia dietro sé, invisibile, la coda della strada. “Conversione” è il salto da uno stato ad un altro, l’irrevocabilità di un gesto che si assume totalmente. Il convertito alla causa del veganesimo, ad esempio, assume su di sé il sapere che ora patrocina: ora egli difende una visione delle cose che prima non era la sua.
Lo stesso vale per il convertito alla causa della filosofia, e cioè a quel sapere che delle cause va in cerca. Il filosofo è un convertito. Facciamo un esempio.
Nel Gorgia, Platone fa dire al suo Socrate che ognuno è tale e quale al sapere che apprende. Cosa dicono le parole di Socrate? Dicono che il sapere converte. Cioè dicono che, banalmente, l’ingegnere pensa da ingegnere: calcolando; il commerciante da commerciante: cercando profitto; il sofista da sofista: gonfiandosi di paroloni e formule vacue senza proferire alcuna verità. Come pensa il filosofo?
Filosofo è chi già abita la teoria. E perciò è già immerso nella prassi, e in particolare quella prassi che cerca lo sfondo di senso che ci circonda. Il suo vivere è convertito a partire dalla teoria che lo illumina. Non è un caso che Spinoza abbia intitolato il suo libro di metafisica, Etica. È nell’ethos, nell’abito, nel comportamento che l’astratto getta la sua ombra, e lì risiede legato in intima unione col concreto.
Un’ultima nota: Spinoza sapeva bene che quest’unione è difficile da vedere, ed altrettanto difficile da incarnare. Ma non desisteva. Lui che nasconde dietro a quel sorriso grandioso la protezione migliore al dolore, alla vita: la pace interiore, riflesso del collidere di teoria e prassi. Questo apice si chiama virtù, strada tanto ardua quanto felice è la meta, poiché «tutte le cose sublimi sono tanto difficili quanto rare».
Giovanni Fava
Giovanni Fava, 1996. Studente di Filosofia a Trento. Amo libri e passeggiate in montagna.
[Photo Credit: Johannes Plenio via Unsplash.com]