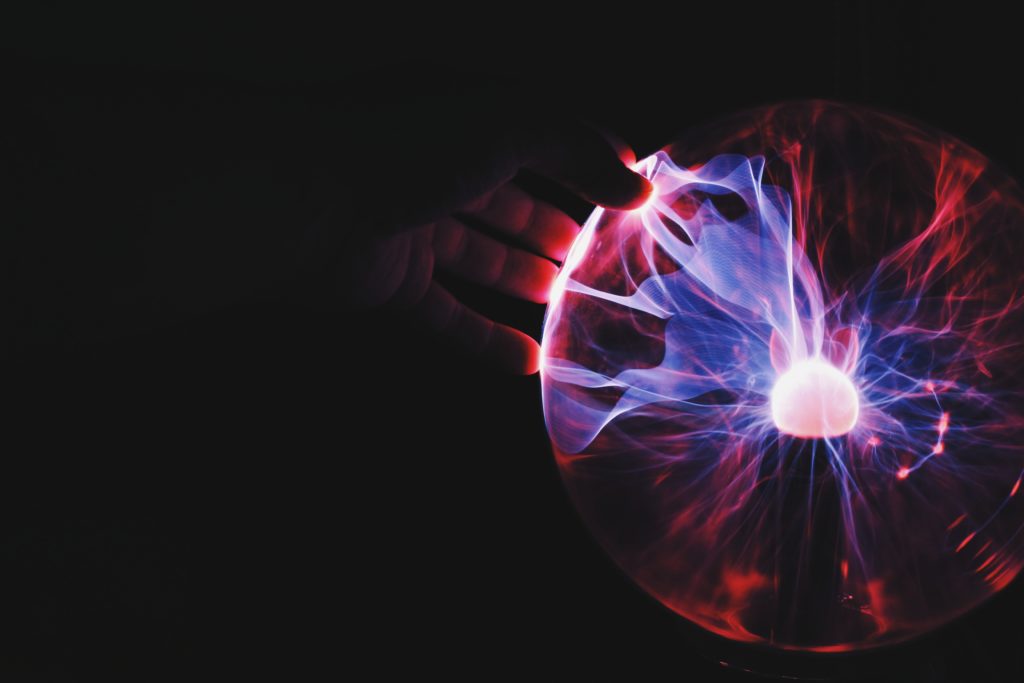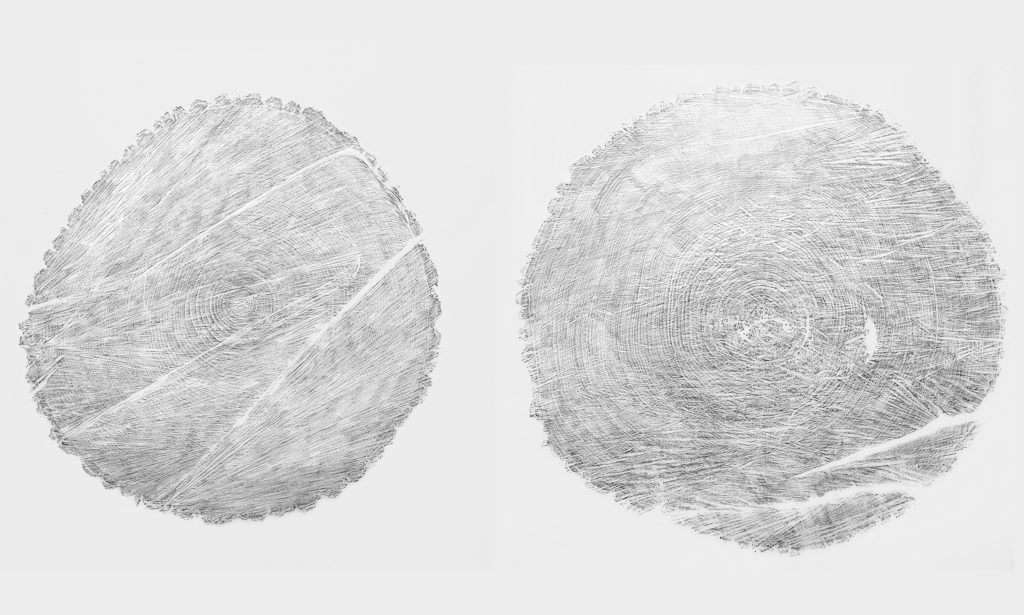Che cos’è l’affetto se non un moto che ci permette di lavorare su noi stessi e sugli altri? Cosa ne rimarrebbe della vita se non fossimo avvolti ed attraversati dai moti affettivi? Le nostre azioni sono interamente generate da quel “qualcosa” dentro di noi che ci spinge a comportarci in un modo piuttosto che in un altro, a manifestare i nostri sentimenti o meno a chi ci circonda.
Un filosofo che ha affrontato approfonditamente la questione dei moti affettivi dell’animo è Baruch Spinoza.
Egli, nella sua Ethica, affronta la questione relativa alla natura e all’origine degli affetti, dedicandovi l’intera Parte Terza dell’opera. Per “affetto” l’autore intende
«le affezioni del corpo con le quali la potenza di agire dello stesso corpo è aumentata o diminuita, favorita o ostacolata, e, simultaneamente, le idee di queste affezioni».
Egli prosegue inoltre affermando che,
«se dunque possiamo essere causa adeguata di qualcuna di queste affezioni, allora per Affetto intendo una azione, altrimenti una passione».
Noi infatti possiamo essere considerati attivi se al di fuori di noi, oppure in noi, accade qualcosa per cui possiamo essere causa adeguata, in quanto per mezzo della nostra natura ci è permesso comprenderlo; in caso contrario, se siamo soltanto una causa parziale, ci troviamo in condizione di passività. È tuttavia in funzione di ciò verso cui dimostriamo un atteggiamento passivo, che l’individuo deve sforzarsi di preservare il suo essere. L’essenza di ciascuna identità è quella di proteggersi dalle possibili influenze esterne, e ciò è possibile solo mediante la potenza d’agire che ritrova in se stessa. Spinoza utilizza il termine “potenza” per indicare l’energia intrinseca ed essenziale che permette ad ogni ente di autoconservarsi. Egli precisa inoltre che questo costante slancio vitale, mediante il quale ogni cosa si preserva da una distruzione da cause esterne, non è alcunché di limitato e finito: se fosse caratterizzato da un tempo limitato, infatti, ciò implicherebbe che la cosa stessa dovrebbe essere distrutta. Ciò, tuttavia, appare assurdo e contraddittorio se si segue il principio per cui lo sforzo con il quale l’ente si mantiene in vita risulta essere costante e continuo: la cosa continuerà ad esistere per mezzo della sua stessa potenza d’essere e perciò secondo un tempo indefinito.
Questo sforzo incontrastabile può assumere due valenze differenti a seconda che si riferisca alla sola mente, oppure simultaneamente alla mente e al corpo: nel primo caso, questo prende il nome di Volontà; nel secondo, quello di Appetito; in quest’ultima circostanza, il filosofo precisa che se ci si vuol riferire alla dimensione della consapevolezza appetitiva propriamente umana, allora la spinta in questione viene indicata con il termine “cupidità”. È interessante evidenziare come l’aspetto corporeo e quello propriamente mentale si intreccino fino a diventare una cosa sola, tanto che tutto ciò che dall’esterno o dall’interno favorisce l’incremento della potenza d’agire del corpo, allo stesso tempo incrementa anche la potenza di pensare della mente; viceversa, ciò che limita la potenza d’agire del corpo, diminuisce anche la potenza mentale. In questo caso accade che se la mente passa da una minore a una maggiore perfezione, allora l’affetto in questione sarà quello della Gioia; al contrario, se passerà da un maggiore a un minore stato di perfezione, allora sarà soggetta alla Tristezza. A questo punto dell’analisi, Spinoza ci fornisce la definizione dell’Amore, inteso come “Gioia concomitante con l’idea di una causa esterna”: secondo il valore della parola Gioia (appositamente utilizzato dal filosofo per indicare l’affezione che ci rende soggetti agenti e non pazienti), l’amore viene inteso prima di tutto come quell’affezione che incrementa in noi la potenza d’agire; siamo soggetti vitali, attivi, non schiavi di una passione che sfugge dal nostro controllo. Tale amore non è connaturato in noi, ma viene originato da un corpo esterno che, in quanto promotore di Gioia, viene anche da noi amato. Se, invece, risultasse causarci un effetto depressivo ed essere fonte di tristezza, allora non potremmo che odiarlo.
Nella suddetta Parte, e in particolare leggendo la Proposizione XXI, ho riscontrato che Spinoza descrive nell’amore la stessa compartecipazione emotiva che Hildebrand analizza nell’intentio benevolentiae. Il passo è il seguente:
Proposizione XXI: «Chi immagina che ciò che ama sia affetto da Gioia o Tristezza, sarà anch’egli affetto da Gioia o Tristezza; e l’uno e l’altro di questi affetti sarà maggiore o minore nell’amante a seconda che l’uno o l’altro sia maggiore o minore nella cosa amata».
Quanto più l’affetto della Gioia è presente nella cosa amata, tanto più questa medesima immagine di Gioia produce nella mente dell’amante un incremento della sua potenza d’agire e perciò un incremento della gioia stessa. Inoltre, trattando la Tristezza, se una cosa è soggetta a distruzione, il sentimento che incomberà su di essa sarà pertanto passivo e depressivo; colui che ama, in questa circostanza, in quanto immagina l’oggetto del suo amore afflitto da questo affetto, proverà su di sé la medesima sensazione di Tristezza con un’intensità tale quale è quella esperita dalla cosa amata.
Sara Roggi
Follow @Sara_freak_92
[Immagini tratte da Google Immagini]