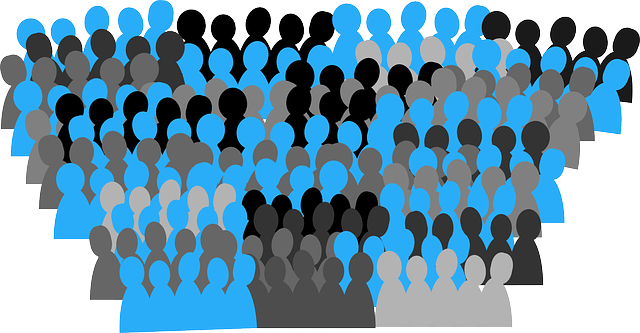Esiste un ormone nel corpo umano definito “ormone dell’amore”. Si tratta dell’ossitocina, un ammasso di amminoacidi che permette di amplificare le esperienze emozionali che viviamo, riempendole di entusiasmo e trepidazione.
In realtà sarebbe più corretto definire questa componente dell’individuo, come “ormone dell’innamoramento”, perché è proprio questa fase dei rapporti interpersonali, che suscita fervore e passione. Si tratta di un periodo che può manifestarsi più volte nell’esistenza di una persona, ma che può durare pochi mesi o, nelle situazioni che hanno uno sviluppo più lento, fino a tre anni. La differenza tra innamorarsi e amare risiede, dunque, in questo: lasciarsi travolgere dall’istinto e, al contrario, decidere di stare accanto ad una persona. Due fasi spesso accomunate, ma in realtà opposte, che presuppongono due tipi diversi di predisposizione, che possono susseguirsi, ma mai sostituirsi.
Ci troviamo nell’epoca in cui esse vengono confuse, spesso abbandonando la nave poco prima che ci si possa ritrovare nello stadio della responsabilità, della scelta, dell’amore. Il confronto – talvolta scontro – che Hegel poneva alla base della crescita dell’Io attraverso l’altro, viene considerato come superfluo, come un qualcosa di nefasto da tenere debitamente lontano. Ci si rifugia in considerazioni, quali: “la vita è già difficile, perché dover lottare anche per amore?” Quasi come se l’amore fosse un residuo, una sorta di tertium non datur dopo il lavoro e gli impegni personali; chi me la fa fare?
La risposta la si potrebbe trovare ne L’amore ai tempi del colera, in Jane Eyre, o più semplicemente parlando con i propri nonni o i propri genitori. Tuttavia il confronto ha lasciato spazio all’individualismo, in base al quale ognuno sa badare a sé e nessuno ha bisogno di nessuno. La conseguenza non è un mondo più perfettibile, bensì una vera e propria castrazione di emozioni. Ci siamo resi fautori di strumenti e di istituti che – a guardare indietro – viene da chiedersi come si potesse vivere senza. Si pensi al divorzio, all’aborto, alla possibilità di cambiare città in pochissimo tempo; forse, però, ci siamo al contempo dimenticati della parte “positiva” della vita, laddove il termine in questione fa riferimento alla sua naturale etimologia e che – dal latino ponĕre, ci regala il significato di “porre”, “fare”, “aggiungere”. Ci siamo dimenticati di come si ama. Sono forse le priorità ad essere cambiate?
Galimberti, eccelso pensatore e scrittore, parla di questa come dell’ “epoca della revocabilità”; un’epoca in cui si «sviluppa un concetto di libertà come assoluta revocabilità di tutte le scelte, che non implicano più impegni e conseguenze perché tutto, dalla scelta di un amico a quella di un amante, dalla scelta di una gravidanza o di una carriera, può essere suscettibile di una cancellazione immediata, non appena si offrono opportunità all’apparenza più gratificanti.» Ed allora risulta più proficuo vivere il momento, cullarsi nel “qui ed ora”.
Nulla quaestio se, nel rapportarsi in tal modo ad un’altra persona, si comunica in modo diretto e trasparente questo mood prescelto di vita. Ma cosa succede se si ingenerano aspettative, se offuscati, magari da quell’ossitocina che spesso annebbia le menti, non si rende edotto l’altro, del proprio non essere capaci di amare, cioè di “desiderare in modo totale” (dal sanscrito “kama”)?
Il mondo che stiamo costruendo risulta sempre più caratterizzato da un’egosintonia dell’anaffettività, in cui ognuno trova quiete solo nel rapporto con sé stesso, nel prefiggersi continui obiettivi di formazione o di lavoro, tralasciando il lato della medaglia che attiene all’investimento nei rapporti umani. La creazione di un “nido” viene vista come anacronistica, quasi come un affronto alle tante battaglie femministe – a partire dal 1800 con il movimento delle Suffragette – verso la conquista del diritto di voto, di condizioni migliori nei luoghi di lavoro, dell’accesso all’università, dell’uguaglianza uomo – donna. Ma oggigiorno siamo molto distanti da quello che, successivamente, anche nel 1900, Simone de Beauvoir sosteneva e creava, in una Francia colpita dalla seconda guerra mondiale, iniziando dalle menti dei suoi studenti, da un mondo accademico che – nonostante le morti e la disperazione – aveva sete di rinnovamento. Una libération des femmes che chiedeva di aggiungere, di ottenere, di possedere un valore concreto all’interno di una società ancora troppo maschilista e patriarcale per poterne accettare le regole.
Oggi si chiede di poter togliere, abdicare, venir meno. L’ideale è stato per lo più sostituito da un programma giornaliero personale, che non contempla l’altro. In questo contesto, delineare un sentimento in fattezze non evanescenti, diviene un’impresa ardua, che confligge col disperato bisogno di essere protagonisti, di rivestire sempre il ruolo di “figli”, in un mondo con sempre meno genitori.
Chiara Savazzi
Classe ’93. Laureata in giurisprudenza a Bologna, è dottoranda di ricerca in diritto penale a Catanzaro, dove si occupa principalmente di neuroscienze e imputabilità. Ha un master in diritto di famiglia ed è Coordinatrice Genitoriale, perchè crede che le parole – ancor prima dei tribunali – possano molto. Pubblica su svariate riviste giuridiche e non (Pacini Giuridica, Sole 24 Ore, Il Mulino, ecc), su opere collettanee e su libri di diritto. È specializzanda in criminologia investigativa.
Il suo amore per la scrittura nasce a sei anni e mezzo con la prima poesia “Il sole ride” e, da allora, scrive sempre i suoi contributi a mano, prima di ricopiarli al computer.
Il suo cuore è costantemente diviso: fra due città; fra cane e gatto; fra diritto e letteratura. Ama: i viaggi in solitaria, le persone leali, i mercatini vintage.
[Immagine tratta da Unsplash.com]