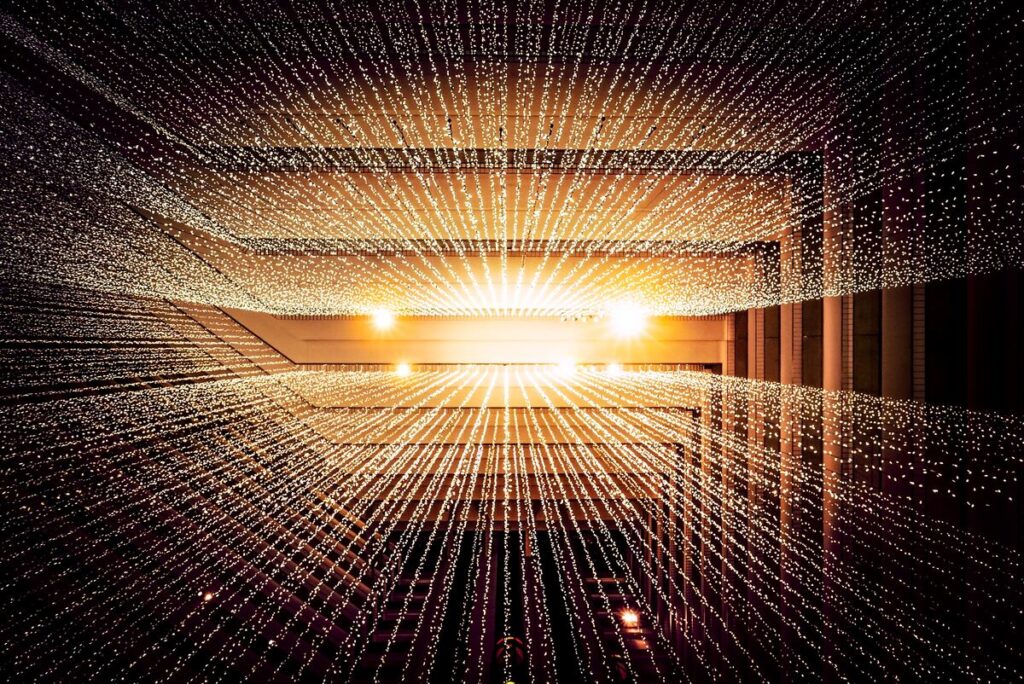Questo pezzo è stato scritto nel giorno del primo anniversario degli attacchi terroristici del 22 marzo 2016 all’aeroporto di Zaventem e alla stazione metro di Maalbeek.
Oggi è il 22 marzo 2017. Primo anniversario degli attacchi terroristici all’aeroporto Zaventem di Bruxelles e alla metropolitana di Maalbeek. A marzo 2016, Bruxelles era già una città militarizzata: dopo gli attacchi di Parigi di novembre 2015, era emerso che la cellula di terroristi veniva da Bruxelles, dal quartiere di Molenbeek. Da lì era partita la ricerca serrata di Salah Abdeslam, che ci aveva imposto una settimana di città blindata.
Questa mattina, ad un anno di distanza, camminando verso il lavoro ho ripercorso mentalmente quella giornata. L’ho fatto una infinità di volte nell’ultimo anno, stile Sliding Doors, ma oggi aveva un sapore diverso. La mattina del 22 marzo 2016 mi ero svegliata più tardi del solito: alle 8.30 ero ancora a casa ed ascoltavo il telegiornale. La giornalista parla di un esplosione all’aeroporto di Zaventem. Non si sapeva ancora a cosa fosse dovuta, la notizia era troppo fresca. Inutile giungere a conclusioni troppo affrettate.
Esco di casa. Anche se penso che forse non sia una buona idea prendere la metro, almeno finché non si ha la certezza del motivo dell’esplosione all’aeroporto, mi faccio convincere dal fatto che se ci fosse stato alcun pericolo, l’avrebbero chiusa. Quando la metro arriva a Schuman, una fermata prima di Maalbeek e tre prima del mio ufficio, il mio telefono si spegne, scarico. Le porte rimangono aperte per pochi secondi, ma la quantità di pensieri che passa per la mia testa è notevole. Non volevo prendere la metro dal principio, c’è stata un esplosione di cui ancora non sappiamo nulla, sono senza telefono e se qualcosa mai dovesse succedere non posso nemmeno comunicare. Così in qualche secondo decido di scendere.
Guardo le persone che lascio dentro e quelle che salgono: mi chiedo perché nessuno pensa che salire in metro non sia una buona idea e mi rispondo che mi sto facendo prendere dalla paura. Inizio a camminare verso Maalbeek: la strada che porta al mio ufficio è una lunga strada trafficata e dritta, sulla quale si trovano le stazioni metro successive.
È difficile calcolare le tempistiche quando si tratta di secondi di scarto, ma saranno circa le 9:10 quando passo davanti all’entrata di Maalbeek. La bomba esploderà alle 9:11. Non appena supero Maalbeek inizio a vedere ambulanze e macchine della polizia venirmi incontro e penso che stiano andando all’aeroporto. Continuo a camminare. Ripensandoci a posteriori, mi chiedo come mai non mi sia mai girata. Se mi fossi girata avrei visto, e la mia mattina sarebbe stata differente. Alla fermata dopo, Art-Loi, vedo la gente che esce urlando, correndo e piangendo. Penso che sia un’evacuazione precauzionale, forse un pacco sospetto. Il militare di pattuglia alla stazione urla qualcosa e indica alla gente di correre e allontanarsi. A quel punto inizio a correre anche io. Non so quanto forte sia l’esplosione di una bomba, ma se stanno evacuando di certo è meglio andarsene il più velocemente possibile. In quei momenti, esattamente come durante i sette giorni di ricerca serrata di Salah, ti senti totalmente vulnerabile, nuda, sai che stai scappando da qualcosa, contro cui nessuno può proteggerti, nemmeno un militare con un mitra. In ufficio, eravamo solo in tre, nessuno ancora sapeva della metro, così spiego cosa ho visto e nel frattempo le notizie iniziano ad emergere. I miei colleghi sembrano più scioccati di me, qualcuno piange, anche loro erano passati per Maalbeek, come ogni giorno. Per tutto il giorno, penso che quella era sicuramente la mia metro: solo qualche giorno dopo scoprirò dalle foto diffuse del vagone che non lo era. Non mi sono salvata; non ne sarei uscita in ogni caso con ferite fisiche.
Eppure ci sono andata così vicino che non sono rimasta totalmente immune dalla giornata. Nei giorni successivi, mi sembra di non riuscire a realizzare bene cosa sia successo. Per i mesi successivi accuserò un generale senso di vuoto e insofferenza, ma senza realmente fare un collegamento con gli attacchi: in fondo non ho vissuto né visto molto e penso piuttosto allo stress del lavoro. Solo dall’incontro con una psicoterapeuta predisposta dalla compagnia per tutti i dipendenti, realizzo che non era altro che la conseguenza di quella mattinata. A partire da questo momento, sarà poi molto più semplice dare il giusto peso a quelle sensazioni.
Ho capito così il vero significato della resilienza1 e come anche da un’esperienza traumatica si può trarre qualcosa di positivo: mai come in questi attimi, una persona è sola, nuda a fare i conti con il proprio essere. Un’occasione rara, per essere onesti con se stessi: nessuno ti chiede il permesso, una mattina ti svegli, e ti ci ritrovi lì, dove starai per i mesi successivi, volente o nolente. Tanto vale saperla sfruttare una tale opportunità.
Francesca Capano
NOTE
1. F. Capano, La resilienza uno strumento contro il terrorismo, La Chiave di Sophia
[Photo credit: Geert Vanden Wijngaert / AP]