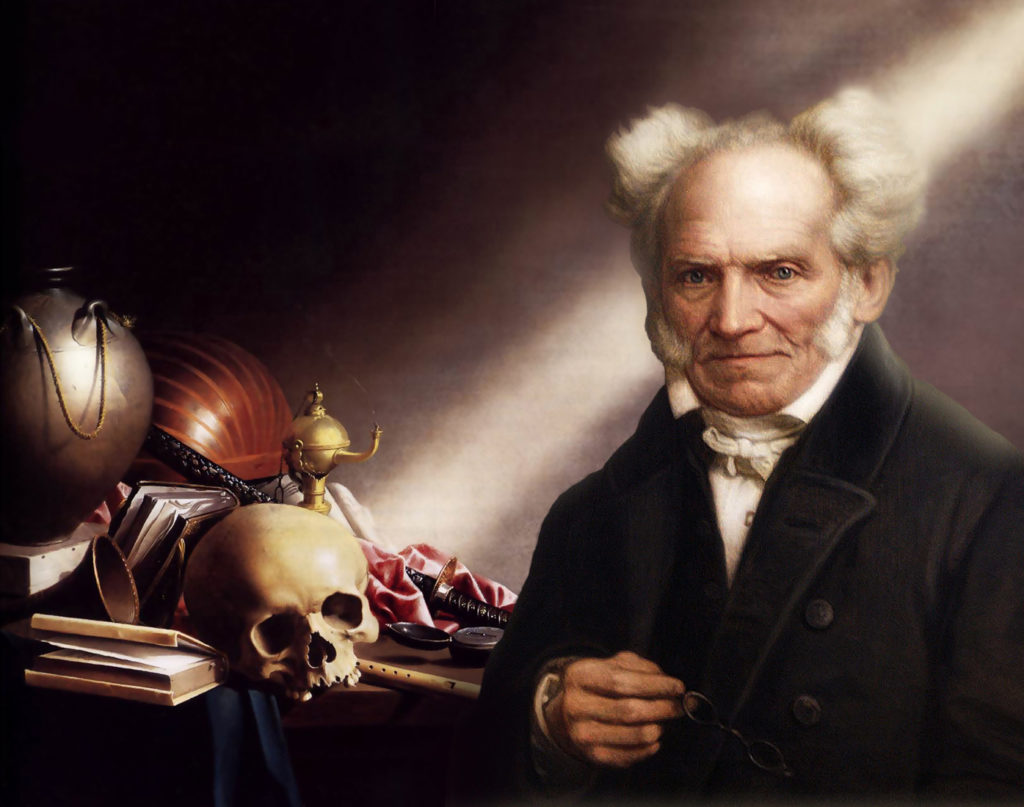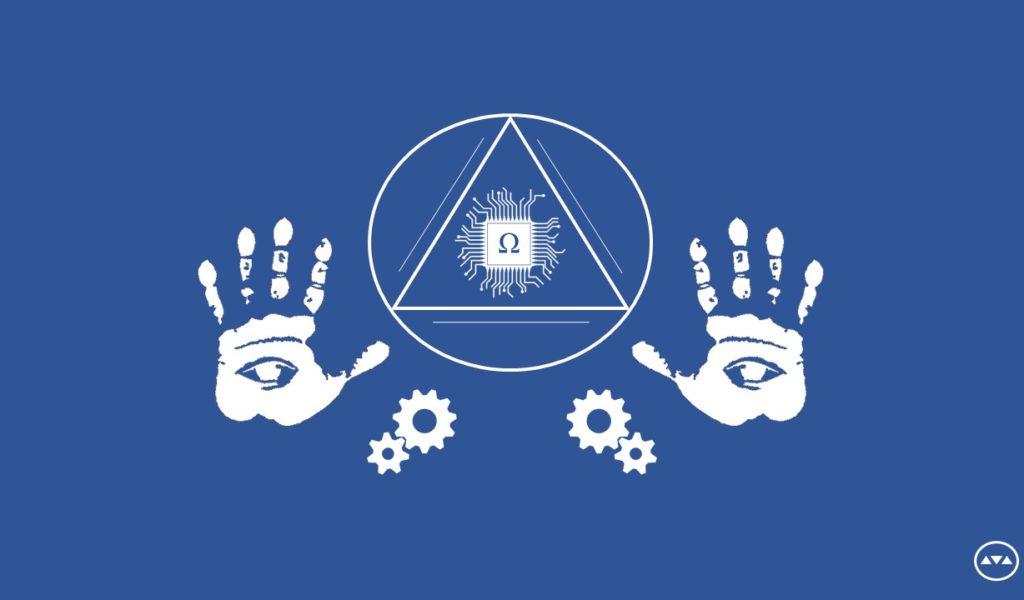Ci si potrebbe chiedere perché a scuola si studino tutti i Nobel per la letteratura italiani – Montale (Nobel nel 1975), Pirandello (nel 1934), Carducci (nel 1906) e Quasimodo (nel 1959) – tranne due: Dario Fo (nel 1997) e Grazia Deledda (nel 1926). Per il primo la risposta è abbastanza semplice: Fo è vissuto troppo recentemente perché i programmi scolastici di letteratura arrivino a lambirlo. Ma che dire di Deledda, deceduta nel 1936 ovvero lo stesso anno di Pirandello? Qualcuno a volte mi accusa di voler essere femminista a tutti i costi, ma a me la faccenda puzza un po’ tanto di maschilismo.
Non è questa la sede per approfondire il tema, ma è il motivo per cui ho deciso di andare in libreria e comprare uno dei romanzi più noti (all’epoca) dell’autrice, Canne al vento. Sono arrivata a Deledda tramite un altro personaggio femminile italiano di mastodontica portata, Eleonora Duse, attrice geniale di fama internazionale il cui nome ormai passa tra i banchi di scuola con l’appellativo di “l’amante di Gabriele D’Annunzio”: come se il suo nome da solo non fosse abbastanza, come se non sia stata lei (o per lo meno anche lei) ad aver dato a D’Annunzio tutta quella fama recitando come protagonista nei suoi drammi. Mentre non mi resta che augurarci una rivalutazione della donna e attrice Eleonora Duse nel 2024, centenario della morte, torniamo dunque a Grazia Deledda, il cui romanzo Cenere del 1904 fu scelto proprio dall’attrice come sceneggiatura per l’unico film in cui abbia mai recitato, nel 1916. Olì, protagonista della storia che ha luogo in Sardegna, è una donna delusa dall’amore, tradita dall’uomo amato, che partorisce in solitudine un figlio che è costretta a lasciare da bambino.
Anche in Canne al vento, pubblicato nel 1913, i personaggi sono dei miserabili della sorte, né buoni né cattivi ma costantemente in balìa di una forza più grande di loro, proprio come delle canne mosse dal vento. Questa immagine torna più volte all’interno dell’opera, il cui protagonista è Efix, servo fedele delle tre dame Pintor cadute in disgrazia, nella cornice di un paesello rurale sardo la cui pesante immobilità è scossa dall’arrivo di Giacinto, giovane nipote delle nobildonne. La precarietà dell’esistenza umana, il tentativo vano di resistere alla sorte, il sentirsi soccombere a un destino ineluttabile: questi i temi che sottotracciano il romanzo, capitolo dopo capitolo, e di cui si fanno portatori tutti i personaggi ma più di tutti forse proprio Giacinto, che continua a perdere al gioco senza riuscire a smettere, nella speranza – vana – che la sorte prima o poi giri in suo favore. Come se non fosse chiaro, tra le ultime pagine del romanzo viene riassunto il messaggio dell’autrice:
«Non è una gran cattiva sorte la nostra? […] Perché questo, Efix, dimmi, tu che hai girato il mondo: è da per tutto così? Perché la sorte ci stronca così, come canne?»
«Sì,» egli disse allora, «siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia. Ecco perché! Siamo canne, e la sorte è il vento».
«Sì, va bene: ma perché questa sorte?»
«E il vento, perché? Dio solo lo sa».
«Sia fatta allora la sua volontà», ella disse chinando la testa sul petto […]1
L’immagine della canna piegata dal vento in verità stuzzica da secoli e forse millenni la fantasia umana. È attribuita a Esopo una favola in cui una canna e un ulivo discutono la reciproca forza, con l’albero che si fa vanto della resistenza del suo tronco; con il passaggio di una forte tempesta, tuttavia, secondo la storia la canna continua a piegarsi sotto le sferzate del vento mentre l’ulivo resiste, resiste, resiste fino a spezzarsi. Scemata la tempesta e passato il vento, invece, per quanto forte sia stato, la canna si risolleva.
Come non pensare poi al filosofo francese Blaise Pascal, per il quale l’individuo non è altro che «una canna pensante»? Lo scrive in un famoso frammento dei suoi Pensieri (1670) con l’intenzione di esaltare invece l’umano nel paragonarlo a una canna. Come per i personaggi di Deledda, non c’è un reale giudizio etico – non importa che l’individuo sia buono o cattivo – ma la semplice constatazione che, per quanto fragile sotto i colpi del vento (è l’Universo per Pascal a schiacciarlo), trova proprio nel suo accorgersi di essere colpito tutta la dignità dell’essere umano:
«Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. È in virtù di esso che dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio della morale»2.
Una conclusione piena di speranza per tutti coloro che, prima o poi nella vita, arrivano a sentirsi come i protagonisti di Grazia Deledda.
NOTE:
1. G. Deledda, Canne al vento, Garzanti, Milano 2022, p. 195
[Photo credit: unsplash.com]