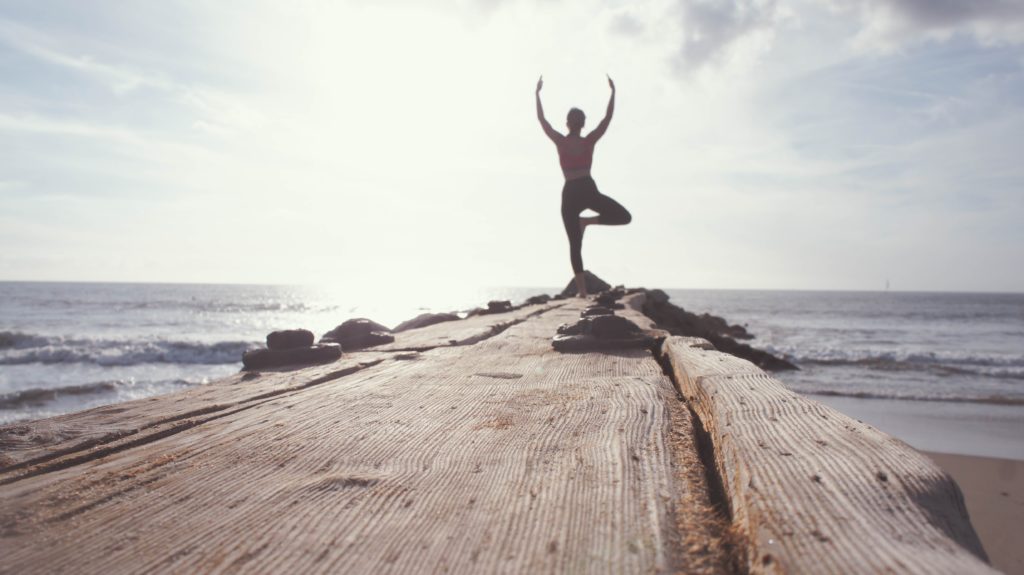Laddove c’è umanità, c’è sofferenza e laddove c’è vita, c’è dolore; e ciò è reso possibile dalla coscienza della morte. Non si può che essere sicuri di questo dato di fatto: la vita umana è null’altro che una malattia per la morte cronica, con brevi stadi (in cui s’entra con timore e tremore) d’acutezza.
Certamente vi sono diversi gradi di patimento: un giorno può essere più lieto del precedente, o del corrispettivo dell’anno prima, ma l’amaritudo – costantemente presente nella vita nella sua forma propria di esistenziale – non aumenta né diminuisce nel volgere del tempo. E dico ciò pieno di contrizione, ma d’altronde ho troppa fede per aver fiducia in un annullamento – o in una diminuzione – del pondus mæroris che attanaglia la vita umana, così come ho troppa speranza per credere che questa verità, che vado proclamando, possa subir smentite.
Vorrei chiarire: qui non si sta – in nessuna maniera – recuperando Schopenhauer: io non credo nell’esistenza di un dolore-metafisico-in-quanto-tale, che attanaglia ciecamente e spietatamente qualunque cosa, animata o morta che sia. Io credo alla vita, e la descrivo; non cerco le fondazioni del patire né nel cielo – pur credendo in Dio –, né sottoterra o dietro il Velo di Maya – perché non credo in Satana o in altre forze di pura malvagità –; mi limito a guardare l’uomo nel suo umanizzarsi, ma se negassi che tale umanizzazione progressiva è un processo doloroso, sarei cieco e sordo.
Vivere è soffrire, pur non essendo un obbligo; esistere è piangere, benché nulla ci vieti di ridere, ma il patimento è dovuto al factum essendi homines, non alla presenza di una qualche (dis)ragione che vincola metafisicamente. Il patimento non è cosmico e la natura non soffre – mai! La danza di pianeti e stelle nel firmamento celeste non subisce certo ritardi per afflizione di sorta, né la pioggia smette di cadere per lutto.
È il nostro essere uomini che costringe a dolere: se fossimo animali, piante, enti o concetti, non ci accorgeremmo della nostra condizione torturale; sono la scienza e la coscienza della morte che ci vincolano alla necessità del factum patendi.
Questa dunque la grande differenza tra noi uomini e gli altri-enti: noi siamo coscienti della morte, in qualunque forma si palesi, in qualunque modo sorga nella vita e, attraverso essa, ci accompagni lungo i momenti dell’esistere su questa terra. E non c’è consolazione alcuna alla necessità dell’amaritudo: l’orizzonte della morte ne è fortino, fossato e torre.
Dalla morte nulla si salva: non amore, non amicizia, non parentele, non talento: tutto perverrà alla morte, senza gloria, senza speranza, e noi uomini – consapevoli di ciò – non possiamo che affligerci.
Parlando con il coro delle Corinzie, Medea, al culmine della sua follia, grida: “Ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς͵ νῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν͵ φίλαι͵ γενησόμεσθα κεἰς ὁδὸν βεβήκαμεν” … rileggo questi versi, sorrido; provo misericordia per questa donna convinta che il suo strazio sia dovuto a dei terreni ἐχθροί – incapace, da buona greca vergine d’ogni esistenzialismo – di capire che il dolore è una totalità di condizione, non un che di transeunte.
Gli ἐχθροί di Medea sono i medesimi di chiunque altro umano che percorra questa lacrimarum vallis che chiamano Terra: non dunque il re, o Giasone: la nemica di Medea è lei stessa nel momento in cui si fa cosciente della morte delle speranze, dell’amore, della felicità, e – ancor più – al sorgere della conseguente afflizione: Medea, nella sua inconsapevolezza, mostra per paradosso come l’actum cognoscendi umano, sia fonte d’eterna tortura.
E più di tutti, in questo mondo, soffre il filosofo, perché soffre dell’altrui sofferenza, e vede la sua, conseguentemente, centuplicata. Ma da tal patimento, il filosofo non scappa, per esso non cerca cure: egli ha una missione – testimoniare il vero – e cerca di portarla a termine accettando di patire, perché sa che il suo destino è di trasformarsi in profeta, et nemo propheta patriæ. Il filosofo insegna a tramutare il patimento in amore: e tutto diventa fuoco adamantino di sentimento perfetto, e il mondo oggetto di dilezione assoluta. E, da filosofo, in fondo al mio cuore, anch’io sogno di morire, come Kierkegaard, mormorando: “Vai dagli uomini, e dì loro che li ho amati tanto, e che la mia vita fu un eterno dolore, sconosciuto a chiunque”, perché so che, spirando, non potrei dire frase più vera.
Ma il dolore è ciò che – più pienamente – libera e salva.
Partendo dalla certezza che il dolore è vita, perché s’accompagna indissolubilmente a lei, ci accorgiamo ch’esso – più che mero tempus – è prettamente eternitas, perché esclude la morte nel suo essere proprio, ovvero nella sua misteriosità. In effetti se l’afflizione ci familiarizza con la morte, inserendola nel vivere, allora essa fa morire la morte: la morte infatti è – puramente – mistero, e il dolore la smaschera: ne consegue che il dolore uccide la morte, e dunque esso non solo è vita, ma eternizza.
Il dolore è vita eterna, ma condizione per l’eternità è la libertà. E la sofferenza è anche libertà, perché solo quando compio liberamente la Valg e la Gjentagels di determinare il mio Ego come essere-con-il-dolore, allora io accolgo in me la possibilità dell’eternità.
In altre parole, se esisto autenticamente, cioè facendomi liberamente compagno dell’amarezza, allora sono destinato all’eternità. In questo senso, in quanto voluto e ripetuto, il dolore è parimenti vita, libertà ed eternità. E io sono (eterno), o meglio vivo (in eterno) in quanto patisco.
Mæror liberabit vos.
Excrucior, ergo sum (æternus).
David Casagrande