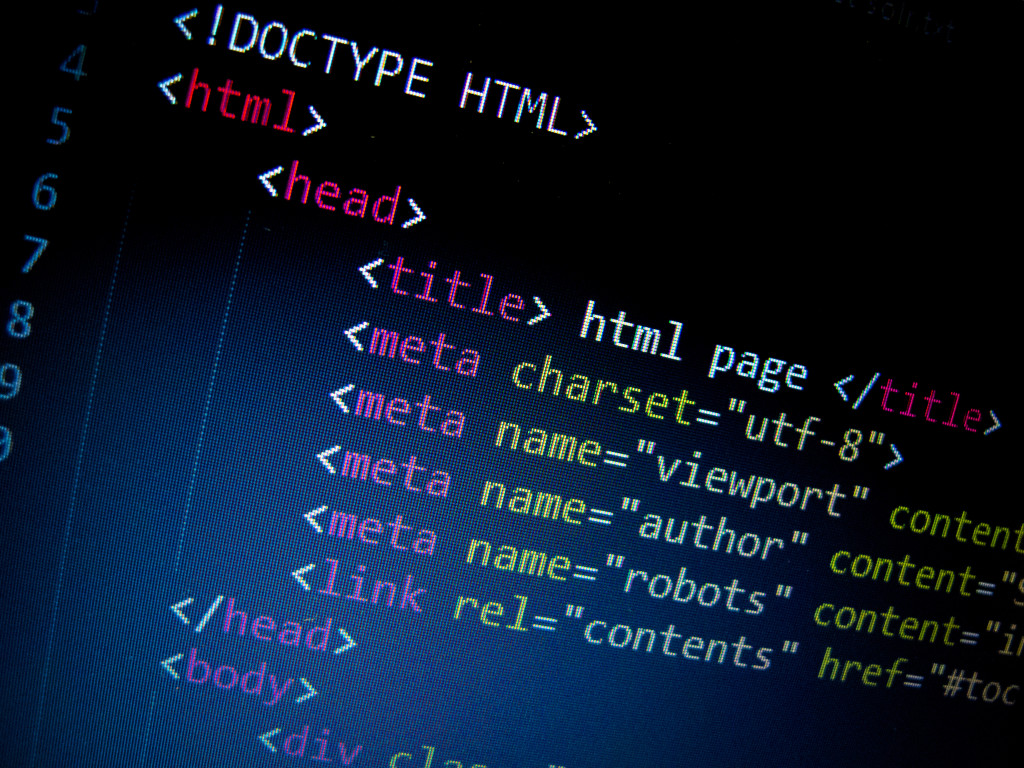La figura del samurai ha sempre esercitato un certo fascino nell’immaginario occidentale, diventando l’emblema dell’eroe immortale, silenzioso e letale come i fendenti della sua spada; un guerriero senza paura, che combatte con orgoglio e onore, ammantato di un’aura mistica.
Nel suo I Sette Samurai, il grande regista giapponese Akira Kurosawa svela un volto nuovo di questa carismatica figura, una visione cruda e disincantata del mondo dei samurai.
Questo film fu il primo di una serie di pellicole la cui trama prevede il reclutamento e l’impiego di una banda di eroi, per raggiungere un determinato scopo; basti pensare a film di Hollywood come I Cannoni di Navarone, Quella Sporca Dozzina o I Magnifici Sette, remake dichiarato e omaggio al grande maestro giapponese.
Girato nel 1954 e ambientato nel Giappone della fine del XVI secolo (epoca Sengoku), il film racconta la storia di un povero villaggio di contadini, vessato dalle continue scorribande di un gruppo di briganti che in quell’epoca devastavano le campagne giapponesi. Esasperati dalla loro tragica condizione, i contadini decidono di cercare aiuto presso alcuni Ronin, i samurai senza padrone, pregandoli di aiutarli a cacciare i briganti. Con difficoltà riusciranno ad ingaggiare sette guerrieri, disposti a fornire i loro servigi per proteggere il villaggio.
Sette guerrieri per sette diversi uomini e sette diversi modi di essere; dal carismatico e romantico Kambei, al suo allievo Katsushiro, un samurai ancora acerbo, desideroso di imparare. Da Kikuchiyo, coraggioso, matto e guascone, interpretato alla perfezione dal grande Toshiro Mifune, che con le sue improvvisazioni a tratti animalesche, regala una recitazione di una emotività commovente, passando poi da Kyuzo, ascetico e imperturbabile guerriero.
Sono semplici uomini, guerrieri di un tempo passato, un tempo fatto di gloria e grandi battaglie e che ora è solo un lontano ricordo. Sono Ronin senza padrone, senza uno scopo, alla ricerca di un nuovo posto e un nuovo ruolo nel loro mondo.
Kurosawa è abilissimo nel delinearne il ritratto; passando da toni epici ad altri decisamente più tragici e crudi, ci mostra realmente cosa significhi essere un samurai. Il senso della solidarietà permea l’intera vicenda, il sacrificio di aiutare il più debole per una tazza di riso e poco altro è centrale e presente in quasi tutte le tre ore che tengono lo spettatore incollato allo schermo. Non c’è più la gloria di combattere per un grande signore della guerra. Non ci sono più le ricchezze e i grandi castelli di pietra. C’è solo la lotta per la sopravvivenza, per la vita, che è fatta di fango, capanne e acqua.
La spada che prima era al servizio del Daimyo, ora serve il contadino, ma ad un grandissimo prezzo. Alla fine i vincitori saranno i contadini, perché appartengono alla terra e nella loro vita di perenni fatiche e patimenti, sono i nutritori di tutti; una classe sociale sempre disprezzata e maltrattata ma necessaria.
Ciò che resta al samurai è il sacrificio. Aver dato la propria vita, ancora una volta, per un’altra causa, questa volta più nobile e giusta ma impietosa nel reclamare il sangue.
In questo incomparabile ribaltamento di ruoli e regole che Kurosawa porta sullo schermo c’è un’epica nuova, una storia di un tempo quasi mitico, distante da noi, eppure ancorato alla realtà, una sorta di Iliade contadina.
Lorenzo Gardellin
[Immagine tratta da Google Immagini]