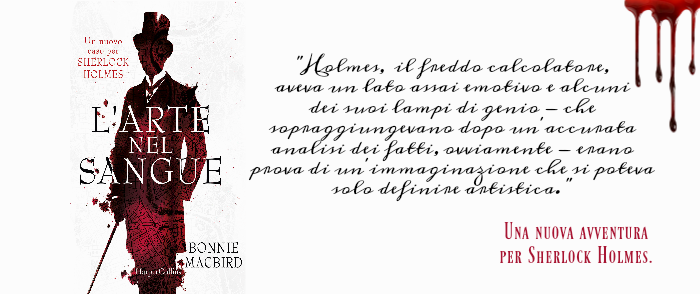Il mese appena trascorso è stato segnato da dibattiti accesi sulle dinamiche patriarcali che hanno rivelato quanto queste ultime siano radicate, ma spesso invisibili ai più. A Sanremo, i primi cinque posti della classifica sono andati a uomini, riaccendendo la discussione sulla scarsa visibilità delle donne nell’industria musicale. Pochi giorni dopo, a Treviglio, la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Silvia Colombo, ha dichiarato che una donna incinta dovrebbe lasciare il proprio incarico politico, come se maternità e lavoro fossero inconciliabili. Infine, la ministra Daniela Santanchè ha affermato di essere considerata “il male assoluto” perché è una donna libera, che porta un tacco dodici e si veste bene, dichiarazione che banalizza il patriarcato, riducendolo a una questione di scelte estetiche.
In questi episodi non sempre viene riconosciuto il riflesso di un sistema di potere che limita lo spazio delle donne, che impone loro modelli preconfezionati di accettabilità e le costringe a giustificare la propria presenza. Eppure questo sistema di potere c’è. E risulta sbagliato accusare il femminismo di voler trovare “ingiustizia” ovunque perché non si tratta di cercarla e/o inventarla, bensì di riconoscerla: il patriarcato permea ogni aspetto della vita di uomini, donne e persone non binarie.
Ci si scandalizza per le posizioni femministe, si nega il problema, ma poi, l’8 marzo, si è pronti a regalare mimose dimenticando che il cambiamento non passa dai gesti simbolici: richiede, invece, consapevolezza e impegno quotidiani che decostruiscano schemi invisibili, ma onnipresenti. Significa smontare, pezzo dopo pezzo, le logiche patriarcali che governano la nostra società e rifiutarsi di perpetuarle. In questa intervista, Martina Miccichè, scienziata politica, fotoreporter e autrice di Femminismo di periferia (Sonda Edizioni, 2024) e Realismo patriarcale (Meltemi, 2025), ci aiuta proprio in questo: leggere la realtà attraverso una lente transfemminista intersezionale, per immaginare e costruire nella quotidianità un mondo più giusto.
Andreea Elena Gabara – Grazie, Martina, per aver accettato di partecipare a quest’intervista per La Chiave di Sophia. Mi piacerebbe iniziare chiedendoti del tuo primo incontro con il femminismo. Come scrivi in Femminismo di periferia, il femminismo intersezionale difficilmente raggiunge chi vive in periferia e con te ci è riuscito. Dove e come è avvenuto questo incontro?
Martina Micciché – In una libreria, fuori dal mio quartiere. Parlando con un’amica di un altro quartiere. In università. Quelli sono stati i primi incontri, ma non erano con il femminismo intersezionale. La lotta intersezionale mi ha trovata e accolta quando mi sono incazzata per il modello centralista in cui non mi riconoscevo, in cui né io né la maggior parte delle compagne eravamo contemplate. In cui si ripeteva un’unica voce che, casualmente, non era per nulla scomoda.
AEG – Ti sei, dunque, prima scoperta femminista; quando, invece, antispecista, e quando hai compreso che le lotte di cui parli nei tuoi libri sono, in realtà, tutte intrecciate?
MM – Sono diventata antispecista un giorno per caso. Stavo facendo qualcosa che mi ha messo davanti agli occhi un video di un’associazione in cui una persona transfemminista sopravvissuta ad una violenza spiegava come viene prodotto il latte. Ero vegetariana ed ero sinceramente convinta di fare il mio, per quanto riguardava gli animali. E invece. Quello che ho visto mi ha messo di fronte al fatto che da adulta mi sfuggisse costantemente la circostanza in cui un mammifero produce latte. Non perché non lo sapessi, ma perché non facevo la connessione. Perché alterizzavo talmente tanto le soggettività non umane da non rendermi conto di quanta violenza ci fosse dietro a qualsiasi processo che ne implica l’allevamento, l’uso o il consumo. In quel momento ho smesso di essere vegetariana e sono diventata vegana e antispecista. Il transfemminismo rende chiara la consapevolezza che non è il modello liberista del “consuma meglio” a creare libertà, ma una rivoluzione collettiva e politica.
AEG – Torniamo al transfemminismo: l’8 marzo pone il focus sul convenzionale gesto simbolico di regalare una mimosa alle donne. Al di là di gesti che concretamente non cambiano la condizione femminile, che ruolo hanno gli uomini, secondo te, nel femminismo?
MM – Le persone socializzate, che si identificano uomini*, hanno un ruolo nel femminismo: banalmente se parliamo, ad esempio, di violenza maschile di genere parliamo a loro, di loro e con loro. Gli uomini* — soprattutto quelli più privilegiati per le identità loro attribuite e socialmente valorizzate — dovrebbero prima di tutto porsi in un atteggiamento di ascolto e riconoscimento delle istanze femministe, capire quanto il patriarcato li avvantaggi anche solo a partire dal fatto che, per un uomo, la liberazione transfemminista è un’opzione, per una soggettività marginalizzata no: è necessità, è vita, è libertà. La maschilità viene talmente indirizzata e compressa che pure uscirne diventa un atto liberatorio e felice di cui gli uomini stessi beneficerebbero. Esistono uomini ciseterosessuali transfemministi, che davvero stanno nella lotta con la lotta senza approfittare del vantaggio strutturale che li rende più accettabili, rilevanti e ascoltabili di tant* di noi. Sono quelli che non ridono quando l’amico fa vedere la foto della sua compagna nuda, che gli dicono che è violenza, che negli spogliatoi non accettano le battute omofobe e sessiste, che quando sentono slur razzisti non si crogiolano nella loro bianchezza ma s’incazzano, sono quelli che parlano con una coscienza transfemminista ricordando le compagne, da cui questa coscienza è loro arrivata. Sono quelli che si rendono scomodi senza soffocare il già ridotto spazio riservato a tutte le altre soggettività. Il ruolo degli uomini* c’è. Come c’è anche un problema, ovvero la preminenza data alla loro voce, che deriva direttamente dal fatto che, “se lo dice un uomo”, tutto diventa più accettabile e credibile. Il fatto che venga data priorità, o prima voce, ad un uomo chiedendogli di spiegare il transfemminismo — magari alle persone marginalizzate stesse — reitera la subordinazione, la subalternità, in un discorso che, invece, vuole distruggere le gerarchie e i domini.
(*) mi riferisco in maniera specifica a chi incarna, si incastra o si conforma bene all’idea tipo della maschilità egemone che è bianca, proprietarista, eteronormata, cisessuale, centralista, capitalista e verticista. Che non è l’unica maschilità esistente.
AEG – Le logiche patriarcali si riflettono anche nell’organizzazione sessista delle città. In che modo?
MM – Le città sono pensate per un tipo di cittadino privilegiato le cui necessità di vita sono integrate nella pianificazione, proprio perché coerenti con il modello patriarcale capitalista del consumo-produzione. A tutte le altre soggettività viene lasciato l’onere di superare tutti i vuoti, dai mezzi pubblici ai servizi necessari a garantire lo svolgimento delle necessità di tutte le soggettività che attraversano una città. Tutte, a prescindere dal volume della loro capacità di acquisto.
AEG – Da poco è uscito anche il tuo nuovo libro, Realismo patriarcale: ti va di raccontarci com’è nato?
MM – È nato leggendo Realismo capitalista di Mark Fisher e pensando che fosse geniale. Volevo aggiungere una prospettiva transfemminista intersezionale a un concetto che, di fatto, spiega perché crediamo che non ci sia alternativa al sistema terrificante in cui viviamo le nostre vite.
AEG – Il sistema ci educa alle diseguaglianze, nonostante la maggior parte affermino che “è la vita”. Come spiegare in maniera breve e accessibile che non è la vita, ma il sistema?
MM – Ci provo. Il sistema è un insieme di scelte, individuali e collettive insieme. Non è un’entità astratta basata su leggi fisiche, quanto piuttosto un modello che noi reiteriamo riproducendo idee, comportamenti, storie, processi che si infilano tutti nella socializzazione a cui sono sottoposte le persone che lo attraversano. Non è la vita, è una scelta politica pattizia che genera, in questo caso, accumuli esagerati di potere e li legittima dicendo che ci sono sempre stati, che sono giusti e che cambiare vuol dire necessariamente fare peggio. In questo si evita il rischio di un cambiamento profondo innescando paura, ma soprattutto, derubando tutt* noi della libertà di immaginare un mondo diverso, insieme.
AEG – Ti chiederei, prima di concludere, una frase di speranza: cosa speri che il femminismo intersezionale porti nella società?
MM – Rivoluzione per la liberazione totale.
AEG – Infine, dato che La Chiave di Sophia nasce con l’intento di leggere con la filosofia il quotidiano e dato che nei tuoi studi spesso menzioni filosofe e filosofi, cos’è per te la filosofia?
MM – Questa domanda mi fa un po’ sorridere perché, tendenzialmente, quando menziono i filosofi occidentali è per insultarli. Tipo Cartesio. Se lo chiedi a me, la filosofia, anzi le filosofie, sono forme di sapere e di ideazione, di interpretazione e lettura della realtà che hanno potere trasformativo. Sempre che non siano quelle terribili ideuzze bianchissime e occidentali che legittimano i verticismi di potere. In quel caso è ideologia del potere.