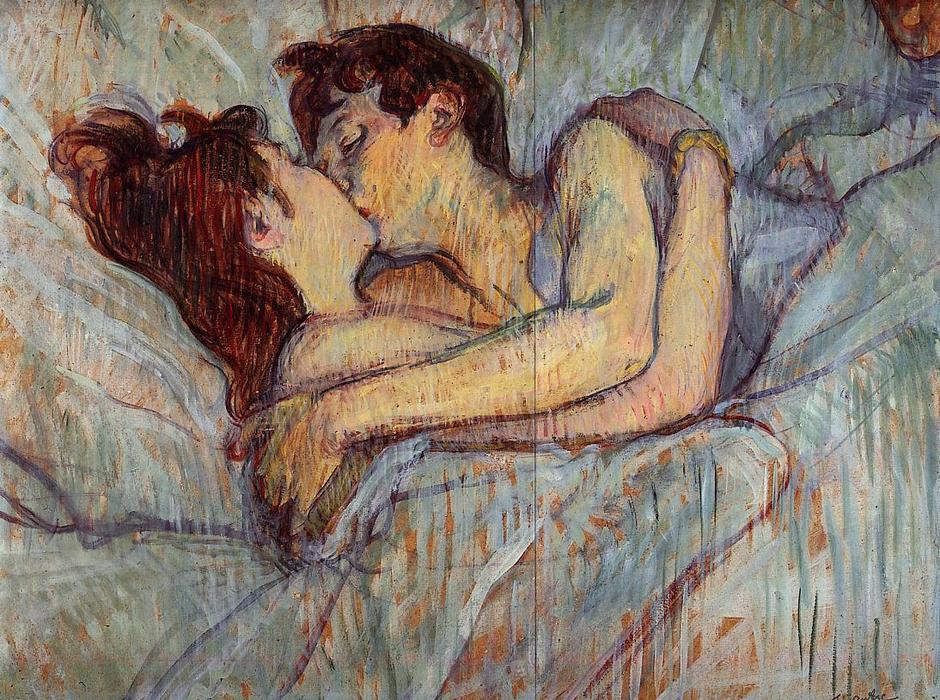Quando pensiamo all’istruzione pensiamo in primo luogo alla trasmissione di un sapere, il quale è comunemente assimilato alla trasmissione di contenuti: si forma così la convinzione che la sapienza si identifichi con l’erudizione. In più è ampiamente diffusa l’idea che, chi più sa, sia in grado di orientarsi tanto meglio nella società, nella vita e nel mondo. Di conseguenza, il ruolo della scuola sarà quello di garantire una preparazione quanto più ampia possibile dal punto di vista contenutistico, di ampliare la conoscenza. Per questi motivi la scuola adempirà tanto meglio al suo compito quanto più sfornerà degli studenti dotti.
Nel 1637 Cartesio pubblica il suo Discorso sul metodo. La prima parte di questo testo è animata dal racconto della preoccupazione dell’autore di condursi con sicurezza nella propria vita. Egli apprende le lettere e la filosofia con avidità in una scuola gesuita (i gesuiti erano conosciuti per la loro straordinaria erudizione), nella speranza di acquisire tutte le conoscenze utili per la vita. Tuttavia, al termine del ciclo di studi ci racconta di essersi trovato «imbarazzato da così tanti dubbi ed errori, che mi sembrò di non aver tratto altro profitto, cercando di istruirmi, se non di aver scoperto sempre di più la mia ignoranza» (Cartesio, Discorso sul merito, Laterza, 1972, p. 47). Così, deluso, decide di scoprire da sé come condurre la sua barca. Si risolve quindi ad abbandonare lo studio e a imparare dalla propria esperienza del «grande libro del mondo». Finché, un giorno, scrive: «Mi decisi a studiare dentro di me, e ad impiegare tutte le mie forze a scegliere il cammino da dover seguire. Cosa che mi riuscì tanto meglio, mi sembra, che se non mi fossi mai allontanato, né dal mio paese, né dai miei libri» (ivi, p. 52). Come interpretare tutto ciò?
Personalmente, condivido l’approccio cartesiano secondo cui il valore della conoscenza è eminentemente pratico: come sosteneva lo psicologo Kurt Lewin, non c’è nulla di più pratico di una buona teoria1. Dopotutto, le nostre conoscenze riguardano sempre il nostro rapporto problematico con il mondo, e le più sofisticate teorie traggono origine da questioni estremamente concrete; per questo motivo la conoscenza non è separabile dalla nostra esperienza diretta delle cose. Cartesio, che non ha alcuna esperienza del mondo, si sente disorientato alla fine del suo ciclo di studi: ha la testa piena di idee partorite da altri a cui non riesce, lui, ad attribuire alcun significato reale. Capisce quindi che il solo modo per conoscere il mondo è andarlo a vedere: chiude i libri e lì comincia la sua vita.
Si vuole con ciò sostenere che dai libri, a scuola, in realtà non impariamo nulla, che sia tutto da buttare? Certamente no: noi non siamo i primi a vivere né a pensare, e ricominciare ogni volta da zero sarebbe assai ridicolo. Tuttavia i contenuti non bastano. Questi devono essere assimilati, fatti propri, digeriti, e questo richiede tempo: non a caso Nietzsche diceva dei suoi scritti che perché fossero compresi era necessario saperli ruminare, come mucche2. Fare troppo ci porta a sovraccaricare il nostro spirito, appesantendolo, rendendolo goffo ed inetto, atto ad interpretare la propria vita secondo quella degli altri. Non si tratta quindi di sapere tanto, ma di sapere bene3.
Insomma, una conoscenza non incarnata rimane una sterile accozzaglia di parole o idee di cui letteralmente non sappiamo cosa fare, e che anzi potrebbe avere l’ulteriore difetto di renderci presuntuosi. Imparare davvero significa toccare con mano ciò che si impara, ricondurre alla propria sensibilità e alla propria esperienza quanto pensato da altri, accettandolo o rifiutandolo, ma sapendolo giustificare a sé stessi. Sapere e sapore hanno la stessa etimologia: non si può imparare davvero se non prendendo piacere nel farlo, e ciò avviene soltanto quando impariamo su di noi. La conoscenza va assimilata e questo richiede tempo, lentezza, maturazione nel terreno del nostro vissuto.
Concludiamo con un pensiero di cui nascondiamo volutamente il riferimento, ma che ci sembra oltremodo calzante: «Appoggiato al manico del mio falcetto, faccio una pausa durante il mio lavoro nel frutteto e osservo le montagne e il villaggio sottostante. Mi domando come mai i pensieri della gente siano arrivati a girare più in fretta del volgere delle stagioni»4.
NOTE
1. Pratico è da intendersi qui non nel senso di concreto, bensì come di ciò che trae il suo senso nel contesto dell’agire.
2.Cfr. F. Nietzsche, Généalogie de la morale, Gallimard, 1971, p. 17.
3. Cfr. M. de Montaigne, Sulla pedanteria, in Id. Essais, volume I, Adelphi, 1966, pp. 184-185.
4. M. Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia, Fiorentina, 2015.
Photo credit Tom Hermans via Unsplash