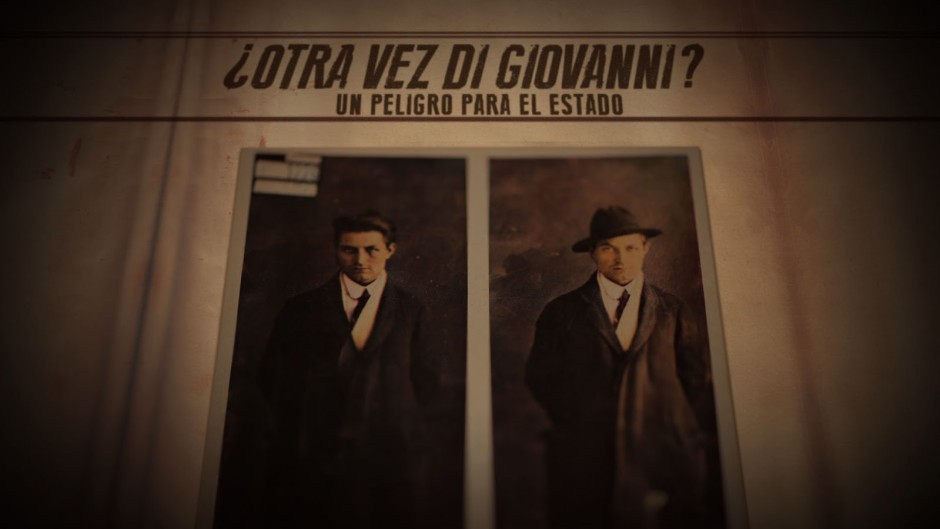A tutti noi sarà sicuramente capitato di rimanere particolarmente impressionati dalla musica di un film, presente magari in una scena particolarmente intensa. Rapiti dalla bellezza di quelle note, l’abbiamo riascoltata a casa e abbiamo notato una cosa: la musica della colonna sonora, anche se priva di parole, è perfetta per descrivere la scena. Anche senza alcun contenuto semantico o rappresentazionale1, quella musica è per noi, comunque, comprensibile e pregna di significato. In altre parole: anche senza testo, sembra che ci comunichi quello che ci comunicherebbe il testo; anche senza scena del film presente, sembra che ci comunichi quello che comunicherebbe con la scena. A questo punto, dunque, sorge una domanda più generale: il senso musicale sta forse nelle emozioni comunicate? Ha senso chiedersi se la musica pura2 funzioni in un suo modo specifico? Come dobbiamo ascoltare e che senso dobbiamo dare a una sinfonia di Beethoven, che non ha testo?
Nel 1854 il critico musicale Eduard Hanslick sostenne per primo una tesi piuttosto singolare: la musica pura, diversamente dalla poesia o dall’arte figurativa, non si riferisce per natura a nulla di reale e, per questa motivazione, è dotata di un bello musicale3 a sé stante, diverso da quello delle altre arti. Se il senso comune sostiene che questo bello musicale coincide con le emozioni che la musica ci comunica, Hanslick matura una convinzione opposta: la musica non ha nulla a che vedere con esse4. Per Hanslick non bisogna infatti confondere l’effetto con la natura dell’oggetto: non possiamo dire che il senso della musica stia nelle emozioni comunicate, così come non possiamo studiare il vino a partire dall’ubriacatura che ci provoca. Le emozioni, in conclusione, sono solo l’effetto di un bello da cercare altrove. La sua tesi poi si radicalizza: il vero fruitore musicale non dovrebbe provare alcuna emozione durante la sua esposizione alla musica, dovendosi solo concentrare sulla percezione della struttura di ciò che sta ascoltando.
Secondo Hanslick, il bello musicale sta, infatti, nella contemplazione della struttura della musica, chiamata forma. La musica è un movimento di forme, ossia una successione di eventi sonori concatenati tra loro in una struttura ordinata nel tempo. Per esempio: immaginiamo di ascoltare una canzone con una alternanza tra strofa e ritornello, quella struttura è la forma della canzone. Se nella canzone abbiamo un testo e una forma, nella musica pura abbiamo solo la forma e sia il senso che il bello musicale stanno in essa. Come conseguenza, però, il fruitore dovrà sempre conoscere la struttura di ogni musica per capirla, come se dovesse imparare una lingua ulteriore rispetto alla sua lingua madre per poter parlare il linguaggio dei suoni. Direbbe Hanslick: una sonata di Mozart o una sinfonia di Beethoven sembrano non parlare di nulla, perché, in realtà, hanno senso solo grazie alla loro forma, che va studiata e contemplata dall’ascoltatore. L’ascolto e il bello musicale, senza aver nulla a che vedere con le emozioni, si limitano alla fruizione di questa struttura.
Riteniamo che la proposta del critico musicale sia angusta. Non è possibile sostenere che esista un bello musicale a sé stante, separato dall’emotività; questo comporterebbe infatti il confinamento dell’esperienza musicale in un mondo elitario comprensibile dai soli musicisti, nonché un disconoscimento del nostro ambito emotivo nella sua totalità. Inoltre, Hanslick considera la musica come completamente separata dal contesto culturale dove sorge, mentre la musica utilizza il suono come suo medium espressivo in un modo che dipende potentemente dalla cultura di provenienza. Nella musica, pura e non, il suono viene sempre posto, metaforicamente, dentro una cornice, affinché sia da noi fruito come opera sonora. Questa cornice è fatta dalle nostre convenzioni, dalle nostre usanze, dal nostro modo di interpretare i suoni attraverso simboli, che divengono chiari nelle opere musicali: noi comprendiamo solo a partire dalla nostra forma di vita5 e la cornice che sta attorno ai suoni è per noi uno specchio, un luogo culturale dove è possibile incontrarne una conoscenza più profonda.
L’opera ci parla di qualcosa, la cornice ci parla di noi.
NOTE
1. Il contenuto semantico è il testo e quello rappresentazionale è l’immagine.
2. La musica strumentale o pura è quella senza alcun testo.
3. Il Bello Musicale è il titolo della sua opera principale.
4. Questa tesi, in parte, dipende dal fatto che Hanslick era risentito verso gli eccessivi slanci romantico-passionali dell’Europa wagneriana.
5. Su questo insistono Wittgenstein e J. Margolis.
[Photo credit Darius Masalar via Unsplash.com]