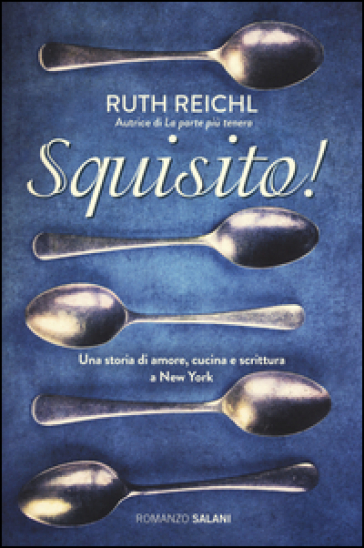L’inglesismo selvaggio è ormai un dato di fatto nella quotidianità di molti contesti lavorativi e universitari, nei quali le persone utilizzano termini e acronimi che molto spesso non sanno cosa vogliano effettivamente dire. All’interno della loro nicchia linguistica ciò appare loro come dotato di un significato e di una intrinseca coerenza. Tale fenomeno prolifera nel linguaggio comune e deve il suo successo all’alto livello di contagiosità; capita così che il termine impresso nella memoria balzi fuori al bar mentre si sta bevendo un aperitivo con gli amici, i quali rimangono sbigottiti o ancora peggio annuiscono anche se non stanno capendo assolutamente nulla di ciò che viene detto.
Spezzerò tuttavia una lancia a favore degli inglesismi, come premessa necessaria a riflettere criticamente su questa tematica. Le parole sono come organismi viventi: alcune migrano da un contesto linguistico all’altro, possono nascerne di nuove, è possibile generare parole da altre parole etc… Una lingua esiste propriamente quando c’è qualcuno a parlarla ed evolve insieme a coloro che la scrivono e la proferiscono. Spesso l’Italia è tacciata di esterofilia, ma c’è da dire che oggi nessuno metterebbe in discussione parole come computer, mouse o driver di installazione, in altri paesi tali termini non hanno passato il vaglio di una analisi critica ed è così che in Francia driver è diventato operator o in Spagna il mouse è diventato ratón. La contaminazione linguistica non è un male assoluto, può essere sensato, soprattutto in campi funzionali, mantenere il valore di quelle parole nella lingua originaria, e l’inglese è una lingua decisamente molto sintetica e immediata, quindi effettivamente riesce ad esprimere alcuni concetti in modo molto esaustivo e diretto.
Da un approccio potenzialmente corretto gli italiani sono poi incorsi nell’abuso dell’inglesismo, introducendolo in maniera acritica nel linguaggio comune, il che finisce per essere una patologia linguistica estremamente virale.
Perché chiamiamo il cartellino badge? Perché i giornali titolano killer e non assassino? Perché sono termini semplici e intuitivi, altri giustamente direbbero che è così perché vengono utilizzati di più e più le parole più si usano più si rinforzano. Personalmente credo che le ragioni vadano ricercate più in profondità e in particolare in una tempesta linguistica che abbiamo preparato noi come popolo.
Da un lato abbiamo gli italiani, un popolo che è stato unificato in tempi relativamente recenti e che per sua stessa natura ha mantenuto forti i propri legami e le proprie radici territoriali e dialettali. A questo aggiungiamo come conseguenza una scarsa predisposizione verso la lingua italiana, a tale proposito pensate alla trasmissione televisiva dal titolo Non è mai troppo tardi del maestro Manzi che negli anni sessanta insegnava l’italiano per superare il diffuso analfabetismo.
Gli italiani avendo, in generale, meno strumenti identitari nazionali hanno facilmente seguito la moda o il suono suadente di certe parole inglesi. A questo si aggiunge che, nonostante il doppiaggio in lingua italiana di film e altri prodotti audiovisivi abbia costituito una forma di difesa strutturale, la continua importazione di format televisivi nelle reti nazionali ha indubbiamente favorito la proliferazione di termini stranieri.
Dall’altro lato ci sono invece alcuni ambienti accademici che hanno avviato una crociata linguistica contro questi nuovi modi di dire, teorizzando a più riprese una vera e propria epurazione, un ritorno alle origini, giocando sulla nostalgia per i bei tempi in cui la lingua era “nostra” e ci connotava come popolo. Talvolta queste teorie sono state accompagnate da un forte sentimento nazionalistico: non dobbiamo infatti dimenticare che nell’inconscio collettivo degli italiani c’è il retaggio del fascismo, anche se spesso lo rimuoviamo acriticamente o con una condanna solo formale, che non aiuta a rielaborare quel periodo che ha investito ideologicamente il nostro Paese in modo negativo. La lingua è diventata allora un modo per rilanciare un certo sentimento di dignità nazionale che, cosa tipica del pensiero totalitario nelle sue molte formulazioni, può sussistere solo nell’identificazione di un “nemico”, molto spesso più immaginario che reale. In quest’ottica, la lotta alla proliferazione degli inglesismi si presta perfettamente a tale tipo di retorica.
Una parte del mondo accademico e in generale alcuni “presunti” intellettuali italiani, molto spesso troppo autoreferenziali, hanno tacciato l’italiano medio di limitarsi a scimmiottare gli americani, rinunciando a distinguersi dagli altri per conformarsi agli stili di vita dettati da marchi internazionali.
Gli intellettuali anziché instillare una analisi critica, e setacciare dove davvero le parole inglesi portavano un valore aggiunto in termini di funzionalità, si sono arroccati in cima alla “torre d’avorio” del sapere accademico dalla quale hanno solo saputo giudicare tutti gli altri.
A questi richiami gli italiani hanno risposto sostanzialmente infischiandosene della “purezza” della lingua nel parlare quotidiano e nel relazionarsi.
Scrive bene Wilhelm von Humboldt: «La lingua è la manifestazione fenomenica dello spirito dei popoli: la loro lingua è il loro spirito e il loro spirito è la loro lingua»1. E aggiunge: «L’uomo vive principalmente con gli oggetti, e quel che è più, poiché in lui patire e agire dipendono dalle sue rappresentazioni, egli vive con gli oggetti percepiti esclusivamente nel modo in cui glieli porge la lingua»2.
Il vero problema dell’inglesismo, linguaggio che si diffonde ogni giorno nell’uso comune, è che parliamo pensando di sapere cosa diciamo senza però riuscire nemmeno in molti casi a riportare quei concetti nella nostra lingua. In qualche modo siamo asserviti dalle stesse parole che usiamo perché non le padroneggiamo.
Anziché arroccarsi nella “torre d’avorio” gli intellettuali e la classe dirigente di questo Paese dovrebbero educare e educarsi come popolo all’analisi critica, alla chiarezza e alla limpidezza del linguaggio, senza rinchiudersi nella dimensione dell’ideologia, ed anzi recuperando un sano approccio genealogico come ci ha ben indicato Nietzsche. Pertanto dobbiamo tutti interrogarci non solo in merito a ciò che diciamo, ma soprattutto a perché lo diciamo, così da scegliere davvero consapevolmente come esprimerci.
Quindi proviamo a porci qualche domanda di consapevolezza su cosa stiamo ascoltando o dicendo quando magari affrontiamo con leggerezza termini come spread o spending review, e cerchiamo di esprimerci con parole di cui conosciamo effettivamente il significato e che non usiamo “a pappagallo” solo perché le utilizzano tutti.
Matteo Montagner
NOTE:
1. W.Von Humboldt, La diversità delle lingue, Roma-Bari, Laterza, tra. It. Di D. Di Cesare, 1991, p. 33.
2. Ivi, p. 47.