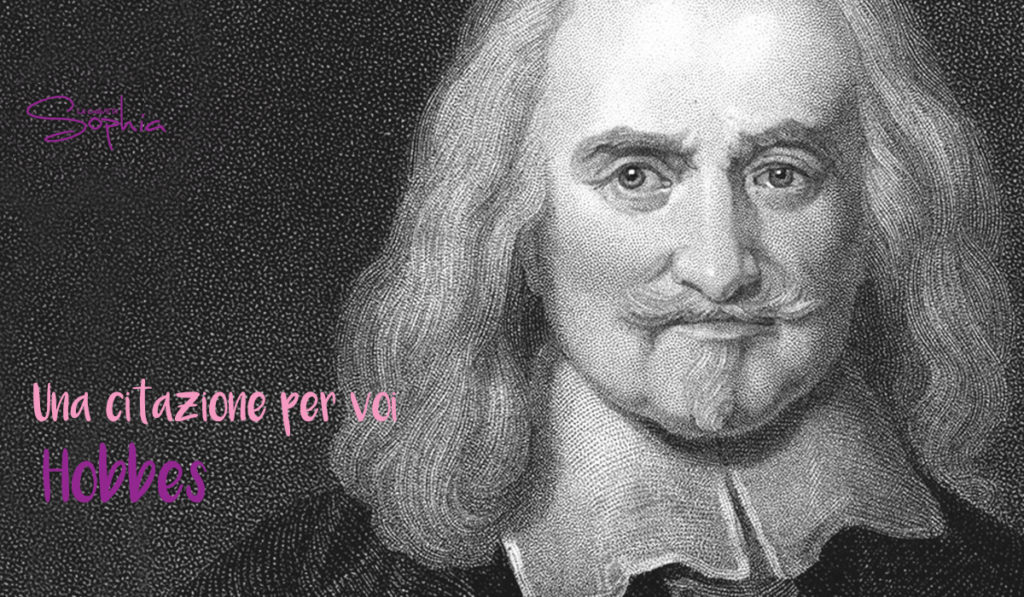Sappiamo che la morte esiste perché esiste la vita. Questa inferenza esistenziale cela e rivela infiniti significati che possono però togliere luce alla ragione di chi resta a guardare e interpretare il mondo. La morte in sé è assurda e quasi contraddittoria perché non rompe l’equilibrio del mondo. Ogni elemento della natura rimane al suo posto secondo una legge cosmica, così come continua l’esistenza altrui secondo una legge di sopravvivenza. Ma nonostante tutto l’esistente sia ordinato armoniosamente, la morte quando arriva sembra portare con sé il caos e radicare la vita in una condizione di incertezza e imprevedibilità. Assilla e incalza la mente di domande che faticano a trovare risposte pacifiche e giuste perché rende enigmatica ogni forma di verità.
La filosofia, in quanto tensione verso la verità, nasce anche come tentativo di dominare la morte sul piano della ragione, di indagarne la sostanza, di trovare rimedi razionali che possano rendere meno tragica e angosciante l’esperienza esistenziale della separazione definitiva. Un esempio del lavoro che la filosofia compie nell’elaborare fenomenicamente la morte è la celebre riflessione epicurea: «Il più terribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte noi non siamo più» (Epicuro, Opere, Einaudi, Torino, 1970, pag. 62). Queste parole possono dare del sollievo, ma quando si vive la morte di chi si ama, il nostro io è sempre chiamato in causa direttamente e allora esse sembrano perdere sostanza per chi necessita di rinascere dal lutto.
L’essere umano è per natura mortale perché fa parte della physis, ma accettare questo nostro attributo che pone finitudine al tempo del nostro essere è un compito davvero titanico perché richiede prima di tutto di metterci al cospetto con la nostra sostanza, di stare nel presente, di continuare ad alimentare la pazienza e il coraggio necessari a resistere ai fallimenti che arrivano quando esauriamo la forza di trasformare quell’abbandono in una reattiva potenza vitale. Infatti, «la morte non solo ci impedisce di vivere, limita la vita, e poi un bel giorno l’accorcia; […] ma al tempo stesso comprendiamo che senza la morte l’uomo non sarebbe uomo» (V. Jankélèvitch, Pensare la morte?, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995, p. 31). Per i greci, gli esseri umani sono coloro che sono destinati a morire. Anche nella riflessione heideggeriana la morte è un fenomeno della vita, la portiamo dentro di noi, perché l’essere è essere per la morte. È importante però distinguere la morte naturale, come decesso delle funzioni biologiche, dalla morte come fenomeno ontologico, che è in noi al momento dell’essere gettati nel mondo. La morte, dunque, per il filosofo tedesco diventa il problema filosofico per eccellenza, perché «la problematica esistenziale tende esclusivamente a chiarire la struttura ontologica di essere-per-la-fine propria dell’Esserci» (M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005, p. 299).
Quando la morte entra nella nostra esperienza di vita dà avvio a un cambiamento che per essere tollerato e dominato richiede l’elaborazione di quelle fasi cruciali del lutto stabilite dalla psicoanalisi. L’angoscia che si sente di fronte al nulla, al vuoto che sembra riempire lo spazio circostante, ammutolisce la possibilità di esprimersi, di portare fuori di sé quel dolore che sembra avere preso possesso del corpo e della mente e che ci rende impotenti. Ma il lutto ha in sé anche uno scopo vitale, perché ci offre la possibilità di percepire la vita che resta diversamente e di comprendere che «noi siamo fatti anche da tutti i nostri innumerevoli morti, da tutte le perdite che hanno scavato nella nostra anima dei vuoti, da tutte le persone significative che abbiamo incontrato e poi perduto […]. Tutto quello che è stato e che non è più, che ha marchiato la nostra vita e si è perduto nel tempo, resta in qualche modo ancora qui perché lo portiamo dentro noi stessi»1. Il dolore causato dalla perdita e dalla sparizione di chi si ama non deve rendere la memoria oblio e dimenticanza, perché se abbandoniamo anche il ricordo, la morte diventa allora l’unica cosa visibile, ma ciò che si sottrae ai nostri occhi e alle nostre mani può trovare posto nella nostra anima e lì restare custodito. D’altronde, «[…] Life means all that it ever meant. / It is the same as it ever was. / There is absolute and unbroken continuity. / What is this death but a negligible accident? / Why should I be out of mind because I am out of sight?» (H. S. Holland, Death is nothing at all, Souvenir Press, 1987).
La morte ci lascia in eredità una testimonianza.
Dedico queste mie parole a chi mi ha dato terra e radici.
NOTE
1. Intervento di Massimo Recalcati durante il Festival Il rumore del lutto.
2. «[…] la nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: / è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. / Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?» (trad. a cura dell’autore).
[Phto credit Eyaso Etsub via Unsplash.com]