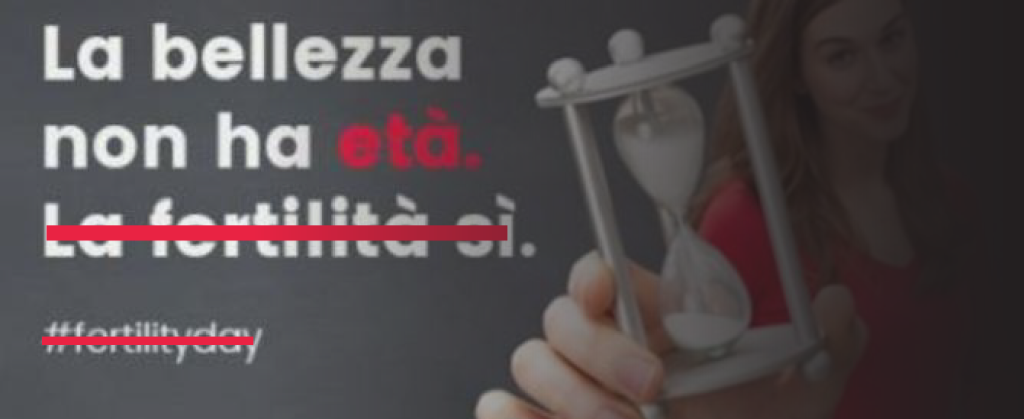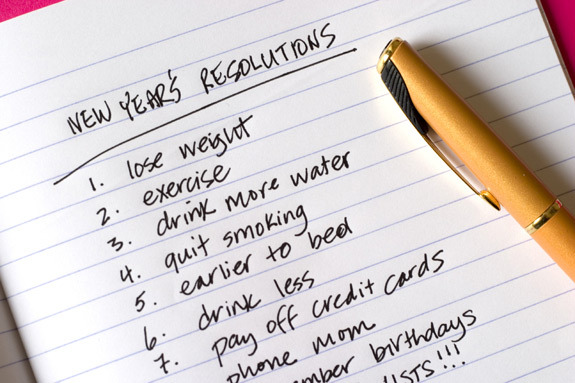Palazzo Reale di Milano ha ospitato la prima mostra personale italiana di Jimmy Nelson: un viaggio policromo nelle comunità indigene di tutto il mondo (la galleria digitale ne offre un assaggio). Fin dalle prime didascalie, Nelson dichiara che il suo scopo ultimo è quello di «ispirare gli altri ad abbracciare la bellezza dell’umanità», perché essa può «connetterci in modi profondi». Per quanto rifletta valori e standard particolari, secondo Nelson la Bellezza può infatti costituire un linguaggio compreso da tutti:
«The beauty I seek to express in my pictures goes beyond language barriers and cultural differences, reminding us of our shared humanity»1.
Con un balzo ai tempi nei quali si cercava una definizione universale delle categorie dell’arte, Nelson riporta in auge proprio quella oggi più ricusata. E colpisce nel segno: di fronte a bambine di etnia Miao o Kazaki, ad una novantottenne Inuit solcata dalle rughe, o a Q’ero del Perù schierati con i loro destrieri, non si può che ricorrere al Bello come un mantra. Il che riporta alla domanda fondamentale: è bella la combinazione sinfonica dei corpi nel gioco di luci e colori, o lo è la sensazione da essa creata?
Per essere certo di suscitare il rispetto dell’osservatore nei confronti degli indigeni, Nelson li rappresenta come re o principi. Questo aspetto attutisce lo straniamento nei confronti di un mondo altro, perché in tale tipo di ritratto un pubblico occidentale non può che ritrovare stilemi visti applicati nella tradizione dell’arte europea. In una bambina polinesiana ho visto una novella Dama con l’ermellino; le pose plastiche e gli sguardi ammiccanti degli adulti mi hanno riportata alle corti di Rubens e Velazquez. L’ultima sala presenta inoltre alcuni polittici che fanno dichiaratamente eco alle pale d’altare medievali, rivelando il carattere auratico, per dirlo con Walter Benjamin, dell’arte di Nelson: un’arte che celebra il sacro e che vuole fissare l’apparenza storica – insieme alle tradizioni e ai valori in essa incapsulati – come se fosse atemporale2.
Rispetto alla ritrattistica europea, un elemento di novità è costituito dal modo in cui la natura interagisce con la scena: non è lo sfondo, ma co-protagonista; tuttavia, non è nemmeno la natura sublime o pittoresca del romanticismo. I tre marchesiani che troneggiano sullo sperone roccioso in copertina sono il contraltare sia di Friedrich che di Constable: come tre aquile in grado di leggere i segni dall’alto, non impietriscono davanti a una natura mostruosa, né oziano nel loro eden. Nelson è tuttavia un romantico per l’aspetto più immediato che la sua opera porta con sé: il culto per le civiltà lontane.
Il suo lavoro precedente – Before they pass away – è stato accusato di promuovere il gusto per il “buon selvaggio”. Secondo Stephen Corry, direttore di Survival International, tale mostra inscenava un’umanità indigena bloccata nello spazio e nel tempo, la cui scomparsa poteva sembrare un «inevitabile risultato della storia». Similmente, Julia Lagoutte ipotizzava che la narrazione di Nelson fosse strumentale a coloro che, per interessi economici o politici, non aspettavano altro che il passing away degli indigeni. In Humanity, Nelson risponde alle critiche: non canta la scomparsa ma la bellezza, unicità e dignità dei popoli indigeni. Inoltre, non dimentica di suggerire che dal loro rapporto con la natura i Paesi sviluppati possono trarre una lezione. Tuttavia, nessun accenno alle comunità che si stanno dimostrando all’avanguardia nella gestione delle risorse. Nelson preferisce un’astratta evocazione di mezzi di sostentamento, tradizioni e credenze «intrecciati con gli ecosistemi»; come se una relazione più stretta con la natura ne scongiurasse a priori lo sfruttamento (cfr. J. Diamond, Collasso. Come le civiltà scelgono di vivere o morire, Einaudi, 2005). L’esotismo, in fin dei conti, prevale.
Corry e Lagoutte avrebbero dunque ancora da ridire, specialmente per il fatto che il fotografo continua a sorvolare sui crimini che molte di queste comunità hanno subito e soffrono tuttora. Occorre però ricordare che Nelson si considera un artista, non un attivista, né un giornalista o un antropologo: «I don’t like those qualifications. I am trying to create art as a cultural statement». Forse, semplicemente, Nelson è interessato al patrimonio culturale delle sue comunità indigene più di qualsiasi altra cosa, più della loro vita; si preoccupa più del pericolo di un appiattimento delle loro forme in quelle della globalizzazione che delle lotte per diritti e libertà. In definitiva, Nelson resta il cantore della sparizione delle comunità indigene: le sue fotografie sono tentativi di cristallizzare l’aura di qualcosa che potrebbe scivolare via – che stia morendo o cambiando, per lui non fa differenza.
Anna Bertelli
Classe 1998, si è laureata in Filosofia all’Università di Pavia e presso lo IUSS in Scienze Umane. I suoi principali interessi di ricerca ruotano intorno alle forme di disuguaglianza e al binomio vivente-ambiente. Dopo un’esperienza come filosofa in azienda e una come science communicator, attualmente ricopre un ruolo gestionale ed editoriale per lo European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Da tale prospettiva, osserva e studia da vicino il rapporto tra scienza e politica e le pratiche di Open Science.
NOTE
1. Letteralmente: «La bellezza che cerco di esprimere nelle mie immagini va oltre le barriere linguistiche e le differenze culturali, ricordandoci la nostra comune umanità» (ndr).
2. Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, 2011.
Photocredit Stéfano Girardelli via Unsplash.