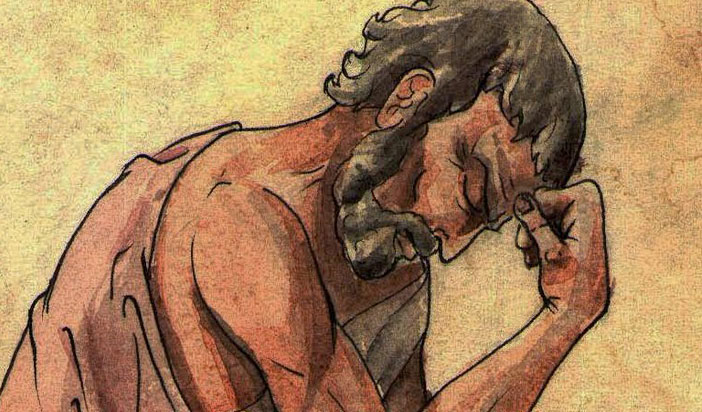«Mieulx est de ris que de larmes escripre/ Pour ce que rire est le propre de l’homme»1: questi i due versi conclusivi rivolti Ai lettori nel Gargantua et Pantagruel, ciclo di cinque romanzi scritti da François Rabelais, pubblicati con lo pseudonimo e anagramma di Alcofibras Nasier a Lione nel 1542 dall’editore François Juste. In età rinascimentale era celebre la formula aristotelica del De Anima «fra tutti gli esseri viventi, solo l’uomo conosce il riso»: dono divino, il riso era considerato un privilegio offerto soltanto all’uomo, dotato di ragione e di spirito, inaccessibile alle altre creature.
Nella storia del riso, l’epoca di Rabelais, Cervantes e Shakespeare rappresenta un decisivo turning point e il modo di concepire il riso marca in modo netto le frontiere che separano il Rinascimento dai secoli seguenti: se in età rinascimentale, infatti, il riso, punto di vista sia particolare che universale sul mondo, percepisce la realtà in modo diverso, ma non per questo meno importante, dal tono serio, a partire invece dal XVII secolo il riso è inteso come svago leggero e stigmatizzazione socialmente utile di atteggiamenti riprovevoli, non più capace di esprimere la verità sostanziale sull’uomo, rilegato tra i generi minori.
Ad esempio negli Essais Montaigne, pur dichiarando di amare i libri divertenti – forse per questo ancora uomo del XVI secolo – tuttavia annovera Rabelais, con il Decameron di Boccaccio, ai margini della grande letteratura, nell’elenco di quei libri «simplement plaisants […] dignes qu’on s’y amuse».
E rispetto alla tradizione antica e medievale, in età rinascimentale non c’è semplicemente una continuazione di quella pratica artistica del riso ma piuttosto l’apertura a una fase totalmente nuova e superiore, più radicale e più universale: nel Rinascimento il riso si svincola infatti dalla cultura popolare e dalle forme d’arte non ufficiali per fare irruzione nella letteratura. Come spiega a riguardo, nel celebre saggio su Rabelais, il critico letterario russo Michail Bachtin – che conia l’etichetta di «carnevalizzazione della letteratura» ‒ «il riso del Medioevo nel periodo rinascimentale del suo sviluppo divenne espressione di una nuova coscienza storica, libera e critica, dell’epoca»2: il riso quindi, con il suo materialismo e la sua sfrontatezza, evolve da uno stadio di esistenza quasi spontaneo a uno di consapevolezza artistica, e, in particolare nell’opera di Rabelais, avviene la sutura tra il realismo grottesco di matrice comico-popolare e la letteratura.
Oltre ad Aristotele, fonte della filosofia del riso, in epoca rinascimentale, è Ippocrate: non solo i trattati medici, quali il De morbis passim grassantibus, sul potere curativo del riso, ma anche il cosiddetto Romanzo di Ippocrate, corrispondenza apocrifa, allegata al Corpus Hippocraticum, in cui si parla della “follia” di Democrito, intesa come atteggiamento dell’uomo che ha raggiunto appieno la maturità. Terza fonte della filosofia del riso rinascimentale è Luciano, in particolare il Menippus o Necyomantia e i Mortuorum dialogi. Lo sviluppo della satira menippea nel folclore carnevalesco medievale e rinascimentale è al centro di un altro importante studio di Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica (1929), dove il critico introduce il concetto di narrazione polifonica e dialogica, peculiarità della poetica dostoevskiana i cui antecedenti sono da rintracciare in quel filone “minore” della letteratura, definito “serio-comico”, in particolare nel dialogo socratico e nella satira menippea, appunto.
Il carnevale è contraddizione e libertà ‒ sia pure effimera ‒ tutto distrugge e tutto rinnova, mescolando attori e pubblico è una grande platea di se stesso, tutto è ambivalente e invertito: questo bisogno di sospensione e di rovesciamento si esprime ad esempio già nella libertas Decembris dei Saturnali, quando si invertivano i rapporti tra padroni e servi, o nei ludi scenici plautini, che, come spiega Maurizio Bettini nel saggio introduttivo alla Mostellaria, Un’utopia per burla – alludendo così al rito d’incoronazione del godereccio re carnevalesco ‒ «agiscono proprio come scompaginamento fittizio, come inversione giocosa dei rapporti sociologici usati. […] Diciamolo pure, il teatro plautino è un teatro “carnevalesco”»3. Profondamente ambivalenti sono anche le forme del riso carnevalesco, parodistiche e grottesche, deformanti e bizzarre, talvolta con una declinazione realistica: tipico, in tal senso, l’intreccio di umano e animale, come nella metamorfosi dell’Asino d’oro di Apuleio.
Con riferimento alla linea individuata da Bachtin, di poetica del riso e carnevalizzazione della poesia si parla anche in ambito novecentesco in particolare a proposito della portata provocatoria e stilisticamente innovativa delle Avanguardie, quali Dadaismo e Surrealismo, e per autori estrosi, quali Aldo Palazzeschi, autore dell’ “antiromanzo” Il codice di Perelà (1911), scanzonata e allegorica fiaba surreale, ritenuto dal critico Luigi Baldacci il libro più valido e felice della produzione palazzeschiana per la leggerezza di tocco e la decisa caricatura delle idee correnti, resa sul piano stilistico mediante l’uso di lunghissime sequenze di dialogo di gusto teatrale. E l’artista saltimbanco nel gennaio 1914 su «Lacerba» nel paradossale manifesto Il Controdolore ribalta con scherno le convenzioni e il perbenismo proclamando il piacere di farsi beffe di tutto: «Bisogna educare al riso i nostri figli, al riso più smodato, più insolente».
Rossella Farnese
NOTE:
1. «Meglio è di risa che di pianti scrivere/Ché rider soprattutto è cosa umana» da F. Rabelais, Gargantua et Pantagruel, Einaudi, Torino, 1973, p. 5.
2. M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino, 1979, p. 75.
3. M. Bettini, Un’utopia per burla in Plauto, Mostellaria-Persa, Mondadori, Milano, 1991, p. 12.
[Immagine tratta da Unsplash.com]