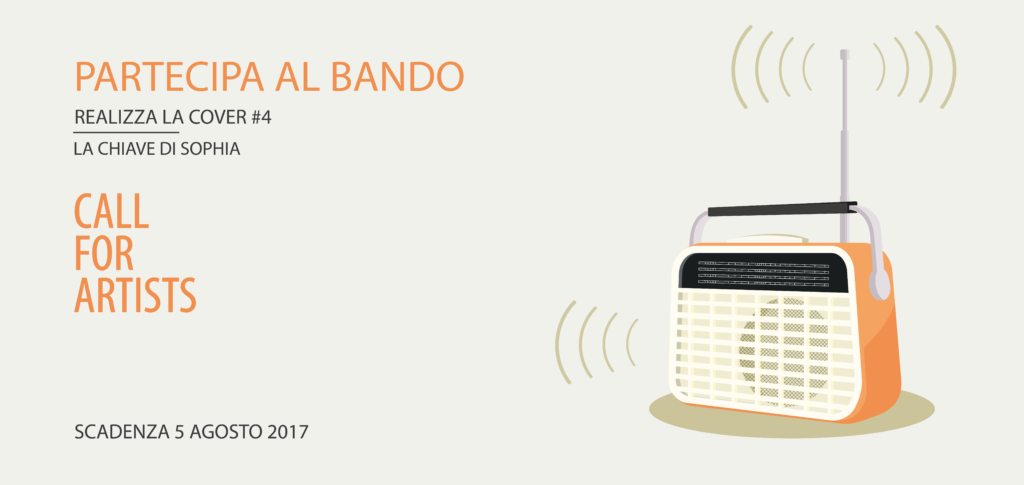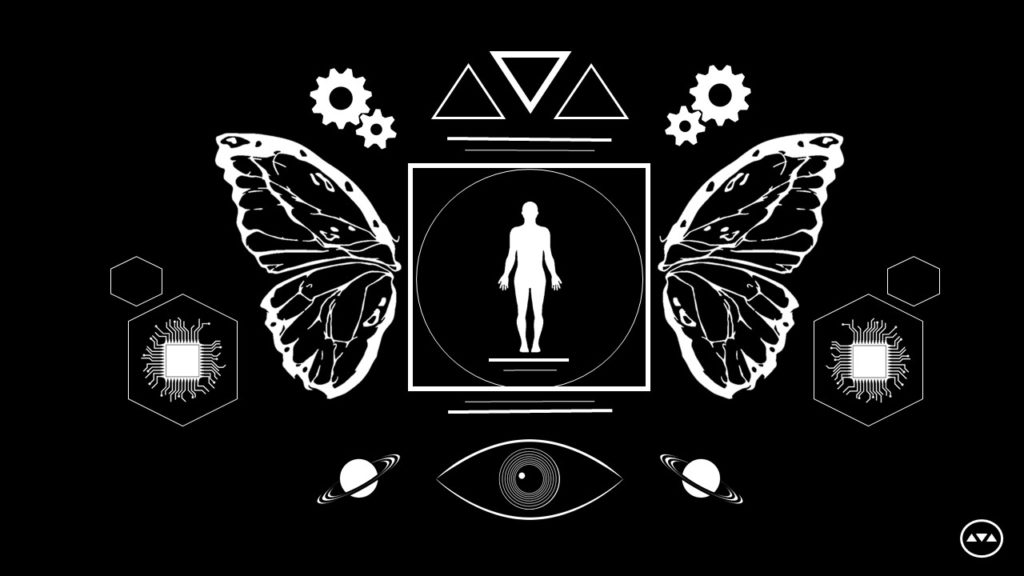Pochi mesi dopo la pubblicazione de La nausea, nel 1939 esce l’altra celebre opera narrativa di Jean-Paul Sartre: la raccolta di racconti Il muro. I cinque racconti sono narrazioni profondamente inquietanti e nelle quali i personaggi vengono scavati dall’interno, mettendo a nudo vergogne, velleità e viltà, che per il pensatore francese tutti noi condividiamo. Il Muro protagonista supremo è il simbolo d’impotenza e d’ostacolo, capace di chiudere all’uomo ogni possibilità di riscatto. Parliamo, quindi, di cinque piccole disfatte.
L’esistenzialismo sartriano può essere definito una filosofia della libertà, della scelta e della responsabilità. L’uomo deve inventare la propria vita e il proprio destino, deve costruire i propri valori. Non c’è un’essenza dell’uomo che prefiguri la sua esistenza, non ci sono norme, leggi, autorità che predeterminano il suo comportamento.
Infatti, soltanto coloro che rifiutano la responsabilità di un’esistenza libera, che credono in una necessità esterna all’uomo, in una stabilità delle cose, in un ordine metafisico che presiede alla vita della natura e della società, possono essere considerati non uomini.
Nel regno di Sartre, dunque, non di rado vige il caos; il nulla ne è l’ospite consueto, l’uomo la vittima. Lo possiamo già intuire leggendo le prime pagine dell’opera «Mi sentivo stanco ed eccitato a un tempo. Non volevo più pensare a ciò che sarebbe successo all’alba, alla morte. Questo non concludeva nulla, non m’imbattevo che in parole e nel vuoto. Ma non appena cercavo di pensare a qualcos’altro, vedevo delle canne di fucile spianate contro di me. Venti volte di seguito, forse, ho vissuto la mia esecuzione»1. Pablo, il protagonista del primo racconto, vede la sua morte «In quel momento ebbi l’impressione che tutta la mia vita mi fosse davanti e pensai: “È una sporca menzogna”. Essa non valeva nulla dal momento che era finita. Mi chiedevo come avessi potuto andare in giro, scherzare con le ragazze […] La mia vita era davanti a me, chiusa, sigillata come una borsa, eppure tutto ciò che vi era dentro era incompiuto»2.
Pablo però si salva per un colpo di fortuna e la prima cosa che fa è ridere. Ride, non solo perché è ancora vivo ma piuttosto per il paradosso al quale è stato sottoposto. Il dubbio esistenziale non può cessare d’esistere e il cruccio viene così irrimediabilmente rimandato. È un riso emblematico, reazione al paradosso al quale Pablo è stato sottoposto. Già Umberto Eco nel proprio capolavoro Il nome della rosa del 1980 ci propose questo concetto: il riso è critica e ironia, è decostruzione, magari per costruire ancora meglio. Il riso si presenta, così, profondamente diabolico e quindi umano.
Dietro alla nauseante precarietà dell’uomo però risiede la libertà: quasi paradossalmente l’effetto di disgusto dipana la libertà stessa come se fossero incatenati a vicenda. Per Sartre infatti il singolo è condannato ad essere libero per il fatto stesso di trovarsi gettato in un mondo senza senso. Nel racconto Pablo stava per essere condannato a morte e invece come d’incanto fu risparmiato: paradosso, non-senso, libertà inattesa.
Ed è ora che ci dovremmo chiedere se la fortuna basti. O meglio: è solo fortuna? Se noi stessi, senza eventi casuali, non riuscissimo a salvarci? Se non riuscissimo a trovare un senso ai nostri accadimenti, come ci comporteremmo? Come potremmo essere risparmiati? Insomma, com’è che si vive?
Forse faremmo come il protagonista dell’ultimo racconto di Sartre intitolato Infanzia di un capo. Luciano Fleurier rampollo di una ricca famiglia di provincia, che produce capi d’industria da quattro generazioni, è destinato ad essere un capo, e così sarà. Prima però Luciano passerà tra mille dubbi tra i quali la propria inesistenza.
Passa alla psicoanalisi freudiana dopo essere divenuto partner sessuale di un poeta pederasta, a far parte di un’organizzazione fascista giovanile e pestare brutalmente un ebreo. I dubbi su sé stesso lo spingeranno, dunque, a una perenne mutazione, passando da un interesse all’altro e da un’identità all’altra. Nulla di più caotico.
Finiti gli studi, passata l’adolescenza, non ha però più scuse: deve prestarsi a diventare uomo, prendendosi tutte le responsabilità e le libertà connesse. Leggiamo «La sua esistenza era uno scandalo e le responsabilità che avrebbe assunto più tardi a malapena sarebbero bastate a giustificarlo. […] Dopo tutto, non ho chiesto di nascere, si disse, ed ebbe un moto di pietà verso sé stesso. […] in fondo, non aveva mai smesso di sentirsi impacciato dal peso della vita, da questo dono voluminoso e inutile, e l’aveva portato fra le braccia senza sapere che farne né dove deporlo»3.
Non è pronto, e chi lo è in fondo?, si chiede Sartre. Decide allora un rifugio ultimo, prima di iniziare a vivere. «”Là dove mi cercavo” pensò, “non potevo trovarmi” […] Il vero Luciano, adesso lo sapeva. […] Tanta gente l’aspettava al varco: ed gli era, lo sarebbe stato, quest’immensa attesa degli altri. “È questo un capo” pensò»4. Sartre conclude l’opera quasi negando quanto scritto fino a quel momento. Così leggiamo infatti: «Esisto […] perché ho il diritto d’esistere»5. Svanisce ogni dubbio, ogni esitazione. Luciano ora è a tutti gli effetti un uomo-capo; ancora una volta come per magia.
È questo l’ultimo dubbio che ci rimane (è l’intero romanzo che ce lo impone nella propria costituzione): Luciano si salva perché si immette dentro a delle massime convenzionali, cioè all’interno di categorie d’essere più che d’esistere? Cioè: devo perché non voglio. Nulla di più lontano dallo stesso autore. Sembra rinunciare, potremmo dire, illudendosi in nome della serenità.
È difficile poter dare una conclusione esaustiva dell’articolo qui proposto. Forse perché ancora oggi non abbiamo compreso Il Muro fino in fondo. Sartre lo sapeva e forse l’intento era proprio questo. Non ci rimane che domandarci: esiste oppure no una via d’uscita al muro che ci sta dinnanzi?
Simone Pederzolli
NOTE
1. J-P. Sartre, Il Muro, Oscar Mondadori, Verona 1980, p. 40.
2. Ivi, p. 41.
3. Ivi, p. 169.
4. Ivi, p. 295.
5. Ivi, p. 295.