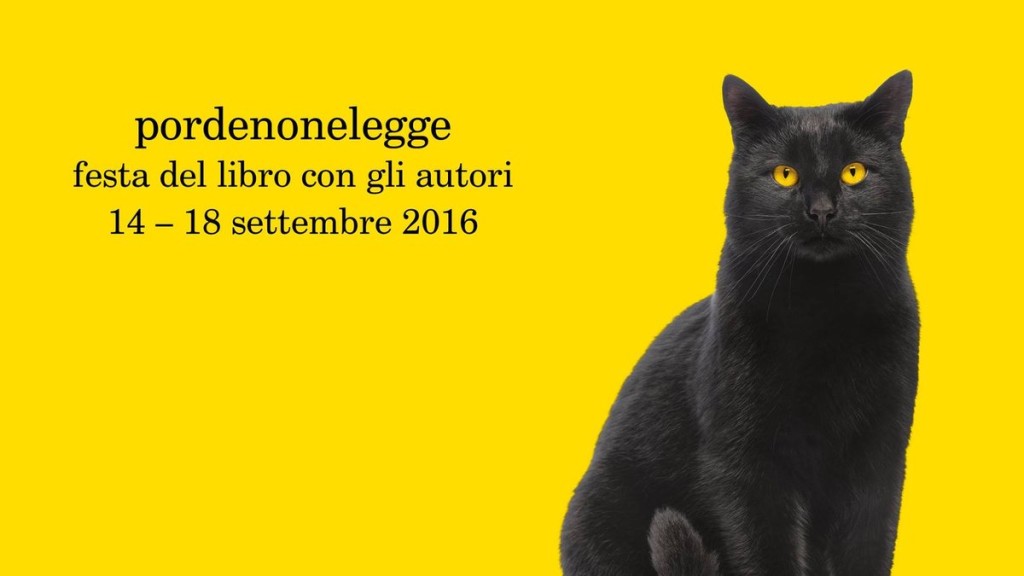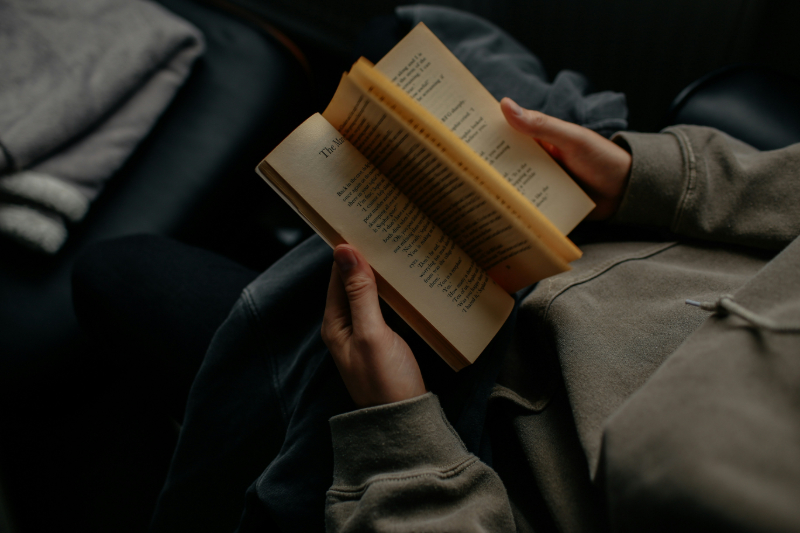Se vi chiedessero quale quadro può essere considerato il manifesto di questi anni quale scegliereste? Non scrivo “epoca” perché spero che il trend guerre-pandemie-cataclismi naturali possa cambiare. Io propongo questo quadro contemporaneo: Piromane, che tu sia dannato (2024) di Mauro Pani, che cercherò di commentare brevemente, trovando le assonanze che lo mettono in parallelo ad una delle opere più importanti del Romanticismo tedesco: Viandante sul mare di nebbia (1818) di Caspar David Friedrich.
La struttura compositiva dell’opera di Pani è similare a quella di Friedrich: entrambi utilizzano la stessa tecnica pittorica, la Rückenfigur, che consiste nel rappresentare il protagonista di spalle. In questo caso l’identificazione, a cui porta l’opera, è con un piromane, che osserva la distruzione da lui creata. Mentre in Friedrich troviamo la pura contemplazione, in Pani la contemplazione dopo l’azione. Entrambi i dipinti trasmettono un senso di finitezza data dal rappresentare l’uomo in scala inferiore rispetto alla natura. È un dettaglio che colpisce da un punto di vista storiografico e culturale. Lo stile artistico e narrativo ottocentesco è permeo del contrasto tra finito e infinito, e della volontà di esprimere la potenza e incontrollabilità della natura. Completamente diversa l’ideologia che si è formata dopo tre rivoluzioni industriali (la prima nel 1784 con l’invenzione della macchina a vapore e la meccanizzazione della produzione; la seconda nel 1870 con l’avvio della produzione di massa; la terza nel 1970 con la nascita dell’informatica): la natura è completamente manipolabile e sfruttabile. Pensiamo alle nuvole artificiali per far piovere nel deserto, alla clonazione, alla creazione degli OGM ecc. Non ci si aspetterebbe, quindi, una tale piccolezza dell’uomo. Pani mostra la grandezza della natura nel suo ritorcersi contro colui che ha provato ad imprimerle un’impronta distruttiva.
Le fonti di luce sono principalmente due: il cielo e i bagliori di fuoco che fanno ardere i fusti arborei. La luminosità del fuoco è più emotivamente impattante rispetto a quella leggiadra della nebbia. Importante anche la scelta del formato verticale piuttosto che orizzontale. Differentemente da Friedrich, che voleva rendere l’infinità della natura tramite l’estensione, qui Pani ci trasmette il movimento del fuoco: il suo espandersi ed elevarsi. In entrambi i dipinti c’è un senso di indefinito: sia la nebbia che il fuoco fanno perdere i contorni al paesaggio. Tuttavia, possiamo notare una differenza: nel Viandante sul mare di nebbia l’indefinito dà un senso di spaesamento, che viene in parte smorzato dai colori definiti e meno vaporosi di alcune rocce più lontane. Quest’ultime contribuiscono a ricordarci che c’è una terraferma, qualcosa di stabile, che può fungere da orientamento, come quando ci si perde in un sentiero. In Piromane, che tu sia dannato non c’è qualcosa che orienta, il cielo di un rosso zampillante ingloba e oscura l’orizzonte di uno spazio paesaggistico vitale. C’è solo distruzione e la sua contemplazione. L’inquietudine di essere arrivati troppo tardi, per cercare di fermare il propagarsi delle fiamme, ci assale.
Il fuoco, ciò che Prometeo rubò agli Dei per portarlo agli uomini affinché potessero progredire, sostituisce la nebbia. Fuoco simbolo di una techné, che può essere tanto costruttiva, quanto distruttiva. L’equivoco semantico connesso al nome di Prometeo riguarda tutti noi e il nostro rapporto con la tecnica. Pro-metheus è “colui che ha la metis del prima”, ovvero è pre-vidente, o è piuttosto “colui che mathei”, cioè “colui che deve imparare”? La crisi del nostro tempo sta in parte nel pericolo che l’essere umano appartenga alla tecnica più di quanto la tecnica appartenga a esso. Di cosa sa farsene l’essere umano dei moderni “doni prometeici”?
Questo dipinto ci ricorda che l’uomo è nel mondo e che una cura dell’ambiente è possibile solo quando ne riconosciamo il valore. Prendersi cura di qualcuno o qualcosa è un principio d’orientamento che riguarda i diritti e i doveri, non la benevolenza o un ben sentire. La raffigurazione di un mondo che brucia è un’immagine spesso associata al cambiamento climatico, indicante la dissipazione, la combustione di energie non rinnovabili, la degenerazione a cui certi modi di pensare e agire portano. Il cambiamento è possibile, ma inizia dalle scelte di ciascuno: dallo spegnere il mozzicone al firmare gli accordi di Parigi. Se non si sceglie ci si immobilizza e le degenerazioni diventano irreversibili. L’uomo contemporaneo da viandante si è trasformato in piromane.
NOTE
[Photo credit Ricardo Gomez Angel via Unsplash]
Elisa Bassignani
Appassionata, riflessiva, ricercatrice. Sta ultimando il percorso di Studi filosofici all’Università di Parma. E’ stata membro del Club dell’Arte-fatto, fondato da Gabriele Trivelloni. I suoi interessi spaziano l’intero campo umanistico, le sue ricerche sono orientate e caratterizzate da una forte interdisciplinarità.