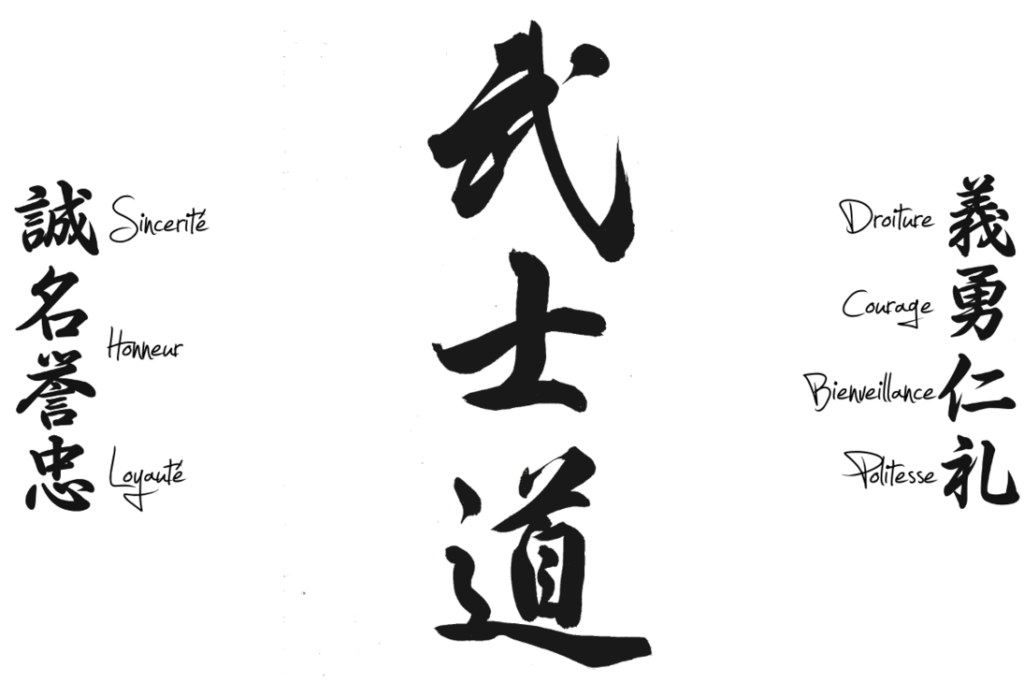Può il gioco, così intrinsecamente inserito nella quotidianità, assumere una piega filosofica e divenire un problema degno di essere trattato filosoficamente?
Il gioco è stato ampiamente ripreso nel corso della storia della filosofia. Basti pensare alle celebri pagine della Politica dove viene annoverato da Aristotele come sinonimo di autosufficienza e libertà, all’estetica kantiana in cui viene associato all’immaginazione o ancora alle riflessioni di Schiller, ove l’azione ludica diviene sinonimo della commistione di sensibilità e razionalità.
Uno dei più celebri teorici del gioco è tuttavia il filosofo tedesco Eugen Fink (1905-1975), allievo di Husserl ed Heidegger, il quale propone una fenomenologia del gioco considerandolo una delle cinque strutture fondamentali dell’esistenza umana insieme all’amore, alla morte, alla lotta e al lavoro.
Fink, in una delle sue opere più conosciute intitolata Il gioco come simbolo del mondo (1960) riprende ampiamente le riflessioni di Eraclito su cui Nietzsche si soffermerà ulteriormente nella Nascita della tragedia, in cui il corso del mondo, tradotto anche con il tempo della vita (aion) è simile ad un bambino che gioca a dadi. Riprendendo il noto frammento 52 di Eraclito, Fink scrive che «la parola greca aion significa innanzitutto, pre-filosoficamente, il corso di una vita umana, il tempo di questa vita con il suo contenuto» (E. Fink, Le jeu comme symbole du monde, 1960, p. 28, traduzione mia). Il sostrato eracliteo del testo permette di pensare e concepire un’idea di tempo non lineare e cronologica, bensì intrinsecamente diveniente: il mondo è un pais paizon, ossia un bambino che gioca ed in questa sua libera, incessante e senza scopo attività realizza la sua apertura al mondo. L’uomo, come scrive Fink, «non è un essere che sussiste semplicemente, nell’immediato: egli è continuamente, senza sosta, relazione col suo proprio essere e con l’essere di tutte le cose; egli esiste nella comprensione dell’essere» (ivi, p. 40, traduzione mia). L’essere umano non può essere disgiunto dal resto del mondo di cui fa parte; è impigliato nella relazione spazio-temporale, è aperto al mondo in cui è libero di autoprogettarsi liberamente, di scegliere il proprio destino al di là di ogni illusione metafisica che presuppone l’esistenza di un ulteriore e superiore mondo. L’uomo è «l’essere paradossale abitato dal pensiero dell’immensità e dell’infinito, che vive nel vortice dell’universo, all’ombra della morte, nelle fatiche del lavoro, le contese per il dominio, la fragile felicità dell’amore, nel gioco che rappresenta» (ivi, p. 54, traduzione mia). Il gioco è, per Fink, la totale gratuità senza scopo, la gioia per il sensibile, l’onnipotenza creatrice di un tempo sospeso da cui egli è totalmente assorbito. Il gioco è simbolo cosmico, del suo essere senza fondamento e senza scopo, privo d’una granitica progettualità ma sempre aperto a nuovi tragitti, orizzonti e possibilità. Concepire metaforicamente il mondo come un gioco permette di ripensare l’esistenza nel suo divenire ondeggiante, aperta al nuovo, ai suoi sentieri laterali ed imprevisti. Questa concezione permette di assaporare l’insegnamento più importante di una filosofia non più arroccata nelle mura accademiche ma che permetta di penetrare l’esistenza quotidiana di chi desidera coraggiosamente mettersi in ascolto di verità libere da pregiudizi e ferrei preconcetti.
Il gioco è la stessa filosofia, che nella sua tensione tra il pensiero e la vita riproduce l’ambivalente rapporto tra il mutevole e l’immutabile, tra la realtà e l’irrealtà di un momento in cui l’essere umano, ossia il giocatore, si apre alle possibilità che lui stesso crea in una delle innumerevoli pieghe della vita in cui egli s’impiglia e che lui stesso crea nel divenire eracliteo dell’esistenza in cui gli opposti si scontrano in un equilibrio sempre sull’orlo di essere rimesso in discussione.
Donare una dignità filosofica ad un argomento apparentemente meno accademico ed intellettuale come il gioco significa imbarcarsi in un oceano di rotte tutte da esplorare, come quelle di cui parla Nietzsche quando nell’aforisma 124 della Gaia Scienza scrive: «Abbiamo lasciato la terra e ci siamo imbarcati sulla nave! Abbiamo tagliato i ponti alle nostre spalle – e non è tutto: abbiamo tagliato la terra dietro di noi. Ebbene, navicella! Guardati innanzi! Ai tuoi fianchi c’è l’oceano: è vero, non sempre muggisce, talvolta la sua distesa è come seta e oro e trasognamento della bontà. Ma verranno momenti in cui saprai che è infinito e che non c’è niente di più spaventevole dell’infinito. Oh, quel misero uccello che si è sentito libero e urta ora nelle pareti di questa gabbia! Guai se ti coglie la nostalgia della terra, come se là ci fosse stata più libertà – e non esiste più “terra” alcuna!».
NOTE
[Photo credit Riho Kroll via Unsplash]