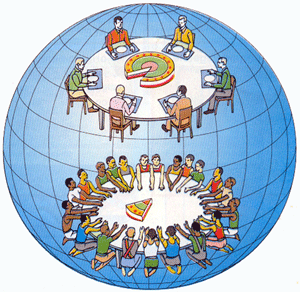La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Queste sono le parole che l’art.4 della nostra Costituzione pronuncia in materia di lavoro e che hanno rappresentato il punto di partenza della mia riflessione.
Prima di tutto, è poi così vero che ognuno è chiamato a svolgere una certa attività secondo le proprie capacità e possibilità?
Il ritmo sul quale stiamo danzando, oramai da molti decenni a questa parte, è quello di una melodia troppo frenetica, ripetitiva e nauseante. Non siamo più chiamati a prendere consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre debolezze e fragilità, ma al contrario, corriamo contro il tempo per combatterle e nasconderle.
Siamo di fronte a quella che viene chiamata una volontà di onnipotenza.
Non più uomini, quanto più macchine. Automi reagenti e spesso rispondenti di un potere superiore.
Già il sistema taylorista prima, e quello toyotista-nipponico dopo, avevano basato il sistema produttivo sull’idea del massimo profitto e della riduzione dei costi. Il modello nipponico, producendo su piccola scala, non solo rispondeva flessibilmente e direttamente ad una domanda diversificata attraverso la realizzazione di prodotti just in time; ma, così facendo, iniziava a consolidarsi una politica basata sulla maniacale ricerca della perfezione: zero scorte, zero tempi d’attesa, zero stoccaggi e soprattutto, zero difetti.
Ed è proprio la ricerca della perfezione che agonizza un mondo lavorativo in cui non si guadagna più per vivere ma si vive per guadagnare. Ci si autoconvince che gli unici valori esistenti essenziali per sopravvivere siano quelli del controllo ossessivo, dell’autonomia e dell’onnipotenza, quando in realtà siamo soltanto rotelle di un ingranaggio che ci priva della nostra libertà rendendoci sempre meno indipendenti. Siamo ubriachi di lavoro, assillati dalle lancette del nostro orologio.
La vita è diventata una competizione in cui ciascuno è chiamato a partecipare. La bravura e l’eccellenza assoluta sono diventate le nostre aspirazioni a causa di una pressione esterna che ci spinge a metterci in gioco se vogliamo diventare qualcuno, se non vogliamo avere appiccicata addosso l’etichetta del fallimento.
Diveniamo così volontariamente pedine di un gioco pericoloso, dove lo scacco matto può diventare fatale. Peccato che l’individualità, una volta reificata, entra a far parte di un circolo vizioso da cui è difficile uscire.
In Miseria della filosofia Marx scrive:
Venne infine un tempo in cui tutto ciò che gli uomini avevano considerato come inalienabile divenne oggetto di scambio, di traffico, e poteva essere alienato; il tempo in cui quelle stesse cose che fino allora erano state comunicate ma mai barattate, donate ma mai vendute, acquisite ma mai acquistate – virtù, amore, opinione, scienza, coscienza, ecc.- tutto divenne commercio. È il tempo della corruzione generale, della venalità universale o, per parlare in termini di economia politica, il tempo in cui ogni realtà, morale e fisica, divenuta valore venale, viene messa sul mercato per essere apprezzata al suo giusto valore.
Siamo parte di quella che Zygmunt Bauman definirebbe una società liquida dove perfino le emozioni e le relazioni diventano oggetto di controllo.
Sta a noi oggi fare in modo che due ingredienti come le risorse umane e quel patrimonio al servizio dell’economia di mercato, ovvero il capitale umano, vengano valorizzati per la loro componente specificatamente vivente e vitale, permettendo l’autorealizzazione creativa e libera di ognuno, sciolta dalle logiche opportuniste.
Sara Roggi
[Immagini tratte da Google immagini]