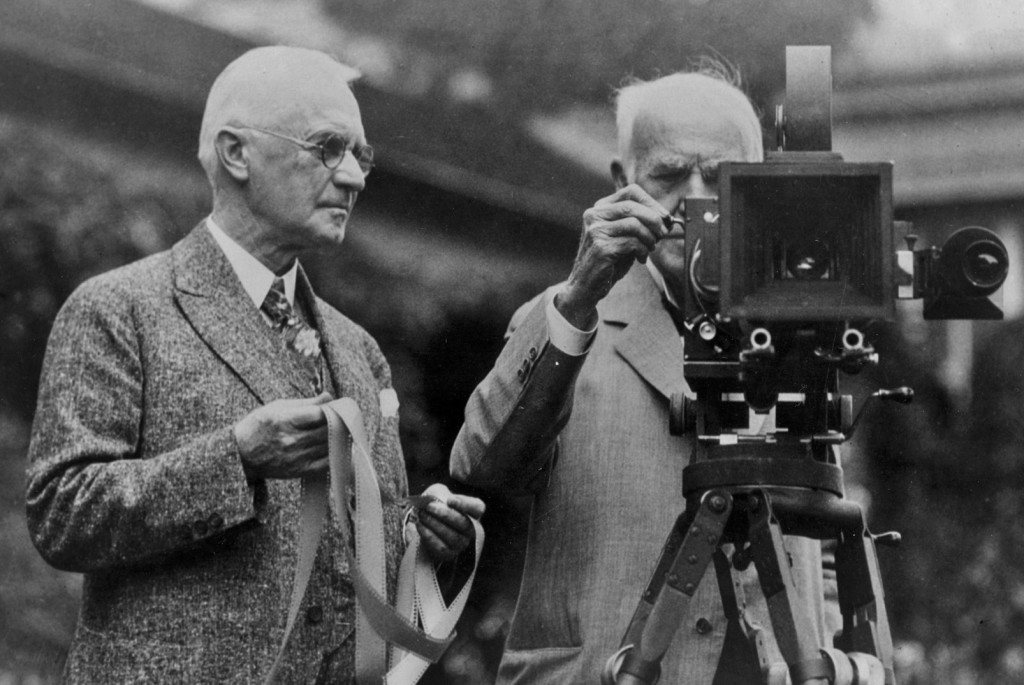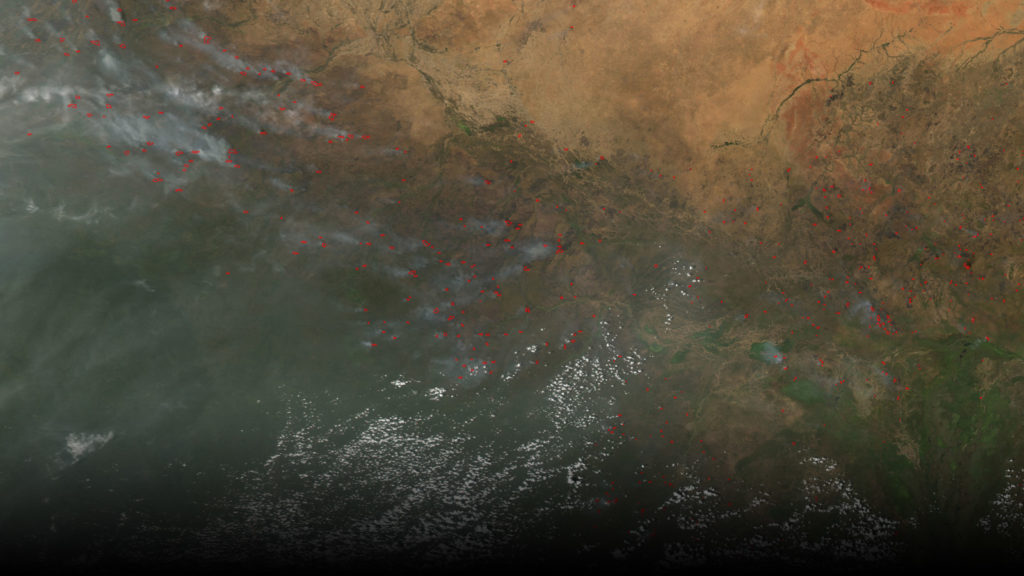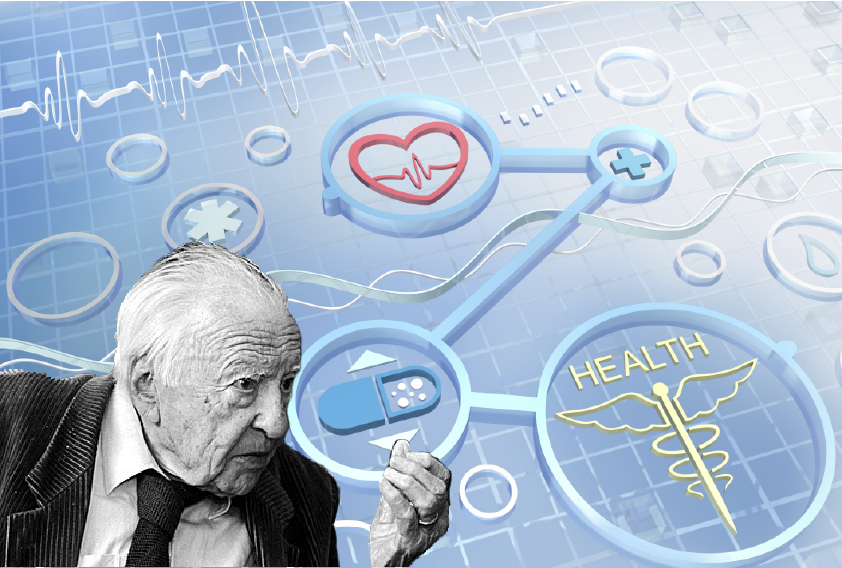Perché nelle università non esistono insegnamenti di filosofia pratica? La risposta è semplice, si dirà, usando una frase abusata: perché l’utilità della filosofia è nel suo essere inutile da un punto di vista pratico; perché, ovvero, la riflessione filosofica si esercita su principi universali, lontani da ogni commistione con la contingenza e la particolarità. Proliferano così corsi di filosofia teoretica, che poco o niente hanno da spartire coi sordidi traffici degli esseri umani qualunque, in cui i professori si librano inarrivabili sopra le altissime vette della speculazione umana, profondendosi in affermazioni talvolta difficilmente intellegibili.
Già duecento anni fa Schopenhauer denunciava questo «scaltro stratagemma di scrivere» – o declamare, nel nostro caso – «in maniera oscura, cioè incomprensibile», presentando «i propri vaniloqui in modo che il lettore debba credere che, se non li capisce, la colpa è sua» (A. Schopenhauer, Sulla filosofia da università, 1990). La ragione profonda di questa strategia affabulatoria era «scrivere senza avere propriamente qualcosa da dire», riempiendosi la bocca di «supreme astrazioni come essere, ente, divenire, assoluto, infinito» (ivi). Questa, secondo Schopenhauer, era – ed è – la cifra stilistica dei professori-da-università, «con il loro pubblico di studenti che accettano creduli» (ivi) tutto ciò che dicono (spesso lodandone la genialità).
Cosa ha a che fare questo con l’assenza di insegnamenti di filosofia pratica? Il filosofo da università, colui che «vuol vivere della filosofia» e non «per essa», si trincera dietro un novello contemptu mundi, un disprezzo per tutto ciò che è mondano e terreno – scambiando il volteggiare senza interessi pratici fra generalizzazioni tanto vaste quanto incomprensibili con la condotta metodologica di una “ricerca disinteressata”.
Malcelata dietro condotte di questo genere, (spesso) si nasconde tutta l’ipocrisia dei ragionieri della filosofia: fintamente disinteressati nella ricerca, disegnano a tavolino programmi e insegnamenti per intercettare il maggior numero di fondi, il maggior numero di studenti o il maggior numero di saggi da pubblicare – rigorosamente – su riviste certificate e accreditate. Scriveva ancora Schopenhauer: «facendone un’industria, l’interesse acquista subito preponderanza sulla ricerca della verità e da presunti filosofi vengono fuori semplici parassiti della filosofia» che ricorrono, «se il vantaggio lo richiede, a ogni sorta di bassi mezzi, compromessi, coalizioni» (ivi).
Anacleto Verrecchia, commentando queste parole del filosofo tedesco, notava che i giovani, «le piante dei vivai universitari […] sono già mence in partenza, anche perché respirano un’aria intrisa di adulazione, di piaggeria, di servilismo e di peronospora intellettuale» (A. Verrecchia, I filosofi di ruolo, 1990). Nessuno di quelli che vengono bollati come «filosofi di ruolo» sarebbe pronto al sacrificio, intellettuale beninteso, in nome delle proprie convinzioni. «Meno che mai – prosegue Verrecchia – credo che si farebbero saltare le cervella per i propri principi. In compenso hanno cacciato una pallottola ideologica nella testa dei loro allievi, scardinandone la facoltà di pensare» (ivi).
Il filosofo da università, in definitiva, specula in astratto di mondi inesistenti e contemporaneamente – spesso in contraddizione con ciò che ha stabilito essere giusto in questi mondi – esercita l’attività di funzionario della filosofia (e del sapere più in generale), di portaborse della conoscenza, abdicando a ogni forma di coerenza intellettuale. Questa lampante contraddizione non è imputabile ai soli docenti universitari, ma è il frutto avvelenato di decenni di tagli alla ricerca e, soprattutto, di una volontà burocratizzante, esclusivamente tesa all’efficientismo e all’ordinaria amministrazione. Viene così dequalificata la specificità che dovrebbe essere propria della filosofia, non mero esercizio compilativo ma libero esercizio dello spirito critico, lontano da dogmatismi e schematismi.
Sarebbe ora, quindi, di rompere questa ipocrisia, e proclamare finalmente l’utilità e la praticità della filosofia, non come disciplina ma come condotta di vita. Ha ragione Schopenhauer quando dice che la filosofia non si può insegnare e che, pertanto, l’istituzione di cattedre di filosofia è una contraddizione in termini. Ma se oggi l’abolizione dell’insegnamento della filosofia può sembrare una velleità, che almeno questo insegnare sia allenamento al libero pensiero e non vuota riproposizione di canoni tradizionali. «La filosofia […] è diventata una cosca mafiosa, con tanto di capibastone, ominicchi e quaquaraquà», perciò è urgente descolarizzarla, «perché l’aria mefitica dell’università non le fa bene» (ivi). E la filosofia pratica, spesso libera dai lacci dell’Istituzione, può contribuire a svecchiare la didattica filosofica.
Edoardo Anziano
[Photo credit Gabriella Clare Marino via Unsplash]