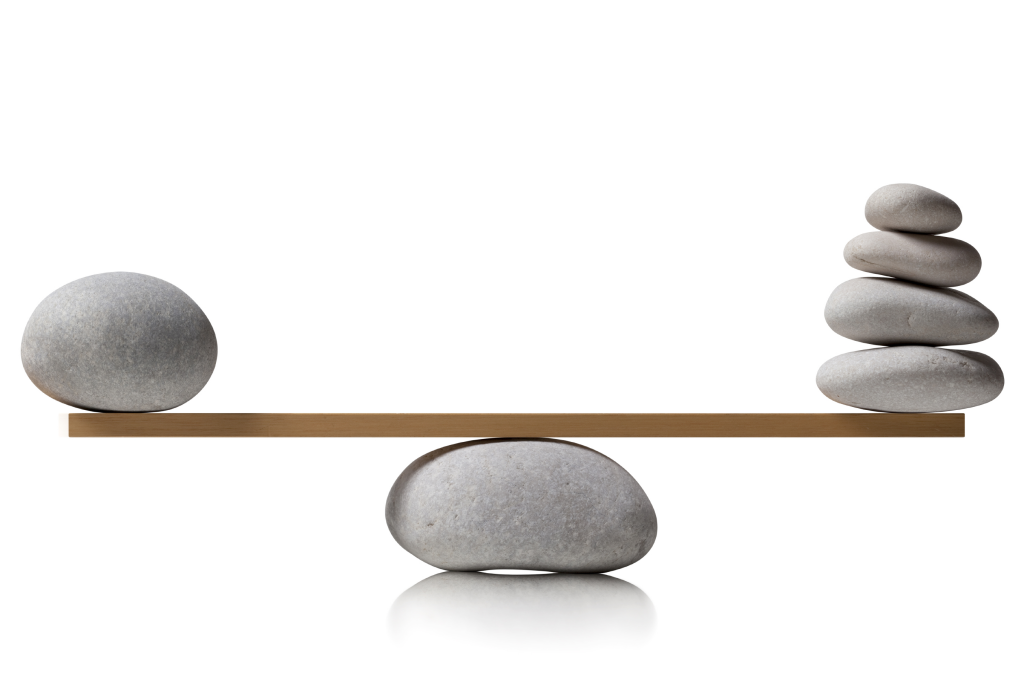Mentre Hollywood già da tempo si cimentava nella produzione di film all-talkie (interamente dialogati) e cominciava a imporsi come modello di cinema universale, il celebre Charles Chaplin perseverava nella creazione di film muti, dimostrando non poco scetticismo per il parlato. Sarà solo con Tempi moderni, uscito nel tardo 1936, che sentiremo, benché in sporadiche circostanze, delle voci umane e, in via del tutto eccezionale, quella di Charlot.
Considerato come uno dei capolavori del cinema chapliniano, dove al meglio si formalizza la sintesi tra patetismo romantico e critica al sociale, Tempi moderni si colloca giustappunto nel centro della dialettica muto-sonoro che coinvolgeva Chaplin in quegli anni. In un film in prevalenza musicato come questo, la parola viene contingentata e inserita solo in alcuni frammenti della narrazione. Il risultato è un chiaro e significativo confronto tra capacità e incapacità espressiva della parola, nel ristretto contesto estetico del cinema come anche nel più ampio orizzonte dell’attualità storica del tempo.
La modernità del capitalismo, della macchina, dell’industria, bersaglio principale del film, che per questo ben si colloca nel panorama artistico dei primi decenni del XX secolo, assoggetta l’uomo alle proprie logiche produttive, ne scandisce i ritmi e i tempi d’azione, ne riduce l’esistenza all’animalità, fino a fagocitarlo letteralmente nei propri ingranaggi. In questo, lo stesso linguaggio viene doppiamente scarnificato: nelle poche occasioni in cui è stato registrato il parlato, l’atto linguistico si isterilisce sia sul piano della relazione tra i comunicanti sia su quello dei contenuti.
Ad una attenta visione di Tempi moderni, si noterà che a parlare non è mai una persona fisicamente presente, una persona in carne e ossa che entri in contatto diretto con l’interlocutore: la parola umana è sempre mediata da un apparecchio tecnologico. Questo vale per il direttore della fabbrica e il suo sistema di video-telecamere; per la voce dell’inventore riprodotta dal registratore; per lo speaker della radio nell’ufficio di polizia della prigione. Nella generale afasia dell’umano, sono le macchine ad aver conquistato il diritto all’udibilità dei propri “discorsi”, ad essersi guadagnate il monopolio della comunicazione verbale, compresa quella dell’uomo. Quest’ultima è così costretta a ridurre il dialogo attraverso cui si articola la relazione bilaterale tra i parlanti a un monologo a senso unico: gli ordini del direttore, le informazioni sull’invenzione, le notizie di attualità del cronista radiofonico e l’intervento inopportuno dello spot pubblicitario della radio non necessitano del contributo del ricevente. Nelle industrializzate metropoli della modernità, a quanto pare, si apre bocca – o, meglio, il microfono – solo per trasmettere contenuti poveri di emotività.
È chiaro, dunque, che il muto di Tempi moderni si carica di una valenza critica nei confronti del progresso tecnologico e industriale, ma se lo si intendesse esclusivamente in questi termini si rischierebbe di ridurre la rilevanza che esso assume nel più generale contesto della prima produzione filmica di Chaplin. Importante chiave di lettura, in tal senso, è la celeberrima scena della canzone senza senso cantata da Charlot nel caffè. Per la prima volta, come si accennava, l’ormai leggendario omino dagli sdruciti abiti ottocenteschi fa sentire la propria voce, rovesciando così una delle caratteristiche peculiari del “canone-Charlot”, ovvero la comunicazione averbale. Eppure, l’immancabile sbadatezza del personaggio e l’acuta trovata della perdita dei polsini, nonché del testo della canzone, impediscono l’effettiva realizzazione dell’atto linguistico. Le parole incomprensibili, date dalla mescolanza di termini e cadenze prosodiche tratte da lingue differenti, divengono pura forma, puro significante privo di contenuto identificativo, bisognose del supporto della gestualità. Trovando proprio nell’esibizione comica il luogo più adatto per esprimersi, Chaplin-Charlot mette in scena se stesso e la sostanza del suo fare artistico, ovvero la “comicità formale”, ma non per questo poco eloquente, ed universale delle sue performance. The tramp vive nel muto e del muto, dell’espressività del volto e dell’esagerazione dei movimenti del corpo, perciò, perché la storia del cinema, ormai indirizzata al sonoro, faccia il suo corso, non può che abbandonare gli schermi. È così che, dichiarando la propria appartenenza a quel mondo, Charlot si congeda dal pubblico e, assieme ad esso, da Chaplin, a sua volta pronto a lasciare che quella parte di sé si faccia passato.
Altro sarà infatti il futuro: quello della nostra contemporaneità, di un uomo fedele alla coerenza mimetica dell’opera cinematografica e abituato alla convivenza con i media tecnologici, alla loro rielaborazione dell’umano. Ritornare, allora, ai tempi dello shock del confronto tra uomo e macchina possa aiutare a tenere in considerazione i limiti della nostra dipendenza tecnologia, i rischi di mutismo collettivo nelle relazioni non virtuali, ma inviti anche a tentare il superamento delle conflittualità e ad aprirsi alle nuove fasi dell’umano.
Beatrice Magoga
[In copertina un fotogramma del film Tempi moderni]