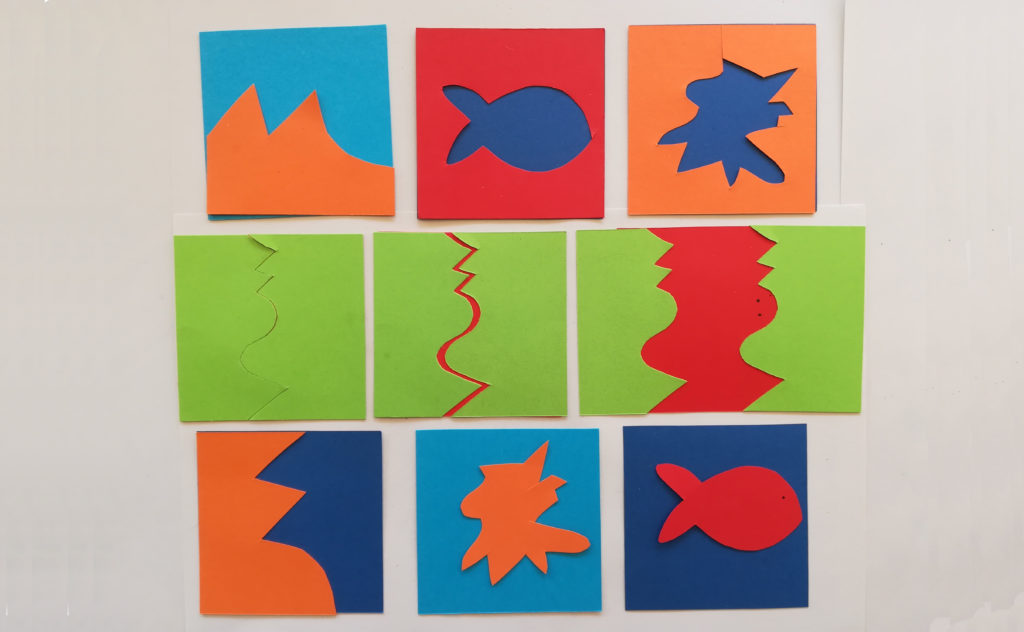«Alle stanze saliva la vecchia, esultante, per dire alla padrona che lo sposo era lì, nella casa. Rapidi erano i piedi, ben salde le gambe. Si fermò accanto al suo letto e disse: Svegliati, Penelope, figlia mia, per vedere con i tuoi occhi quello che ogni giorno desideri. È giunto Odisseo, è a casa, anche dopo molto tempo, è tornato» (Omero, Odissea, a cura di Maria Grazia Ciani, Marsilio, Venezia, p. 351). Così inizia il libro XXIII dell’Odissea di Omero, tra i capitoli conclusivi dell’opera, incentrato sul ritorno di Ulisse ad Itaca, dopo il lungo peregrinare successivo alla guerra di Troia, che lo aveva trasportato attraverso le più disparate e complesse peripezie. Ulisse, ormai stanco e vecchio, arriva ad Itaca debilitato nel fisico e nell’animo, dopo aver perso tutti i suoi compagni di viaggio, prodi soldati, ormai senza più speranze di ritorno. È proprio con questa scena iniziale che il regista Uberto Pasolini lo rappresenta in Itaca il Ritorno (2024), un’opera che vede come protagonisti gli attori Ralph Fiennes e Juliette Binoche rispettivamente nei ruoli di Odisseo e Penelope.
Il film, una delle rarissime riproduzioni cinematografiche dell’Odissea degli ultimi anni, è costruito attorno ad un’attenta caratterizzazione psicologica dei personaggi che mette in evidenza il loro lato umano, nello specifico le loro debolezze e fragilità. In particolare Ulisse viene rappresentato come un uomo pieno di sensi di colpa, che prova vergogna per aver abbandonato la famiglia ed essere tornato in patria senza i propri compagni. Si sente responsabile della loro morte in quanto re e comandante della guerra di Troia, quasi non vuole mostrarsi alle donne di Itaca per non dover affrontare il loro dissenso. Come nell’Odissea di Omero, l’Ulisse di Pasolini inizialmente non viene riconosciuto dai suoi compaesani, ma a differenza dell’opera letteraria questo errore non avviene grazie all’intervento della dea Atena, ma semplicemente la vecchiaia e il fisico debilitato lo rendono irriconoscibile. Proprio questo aspetto è stato oggetto di critica tra coloro che non hanno apprezzato il film, in quanto la mancata presenza della divinità, che non viene mai citata dai personaggi, è ritenuta una grave mancanza del regista, che avrebbe “dimenticato” cosa significava per i Greci la presenza degli dèi. Pasolini, infatti, costruisce l’intero film tralasciando Atena e gli altri dèi, quasi le avventure di Ulisse fossero state vissute da un marinaio sventurato, da un veterano di guerra che racconta la sua storia tornato in patria. In realtà è proprio questa caratterizzazione umana, priva del sovraumano, che avvicina i personaggi allo spettatore, creando una sintonia e una identificazione inevitabile e rendendo l’opera una interessante trasposizione della classicità nella contemporaneità. Questo senso di rispecchiamento sarebbe stato probabilmente molto più difficile se si fosse costruita l’intera vicenda attorno alle innumerevoli divinità greche.
Interessanti risultano inoltre alcune tematiche che vengono affrontate nel film: oltre al sentimento di paura e di vergogna di Ulisse, già citati, sicuramente la relazione tra padre e figlio e quella tra moglie e marito, nonché il legame con la patria. In particolare per quanto riguarda gli aspetti relazionali, Ulisse viene dipinto come un tradizionale uomo, alle prese con un figlio, Telemaco, che si dimostra ribelle, lo accusa di averlo abbandonato, e di aver abbandonato la madre. Da questo rapporto si evince in modo evidente la difficoltà relazionale tra padre e figlio adolescente, che ha bisogno di affermare la propria identità e sé stesso. Analogamente anche il rapporto tra Penelope e Ulisse è un rapporto difficile: Penelope fatica a credere all’identità del marito, sebbene abbia intuito che si tratti di lui ancora prima della famosa prova con l’arco che sancisce definitivamente il ritorno del re. Una parte della sua anima è in collera con Ulisse per averla lasciata e aver permesso che i Proci si insediassero nel suo trono, un’altra stenta a credere che davvero i suoi desideri si siano realizzati e suo marito sia di nuovo a casa.
Infine il profondo legame con la patria è evidente fin dal principio: Ulisse bacia la terra appena giunto a casa, lui, l’uomo dal lungo viaggio, è in colpa per la desolazione che vede, ma allo stesso tempo ben risoluto a riprendere il potere e scacciare i suoi usurpatori. Pian piano egli riprende confidenza con la propria identità, sfrutta la propria astuzia (ricordiamo, infatti, che Omero ce lo descrive come polymetis: l’uomo dei molti inganni) lasciando i panni del mendicante, per ritornare a ricoprire quelli del re. Si potrebbe dire, dunque, che il film di Uberto Pasolini mette in scena un dramma tutto umano, dando una veste quotidiana agli eroi omerici, quei personaggi semimitologici che apparivano così distanti e irraggiungibili e che in realtà si consumano di sentimenti umani in mezzo a noi.
NOTE
[Photocredit Hesan Mohamadi by Unspalsh]