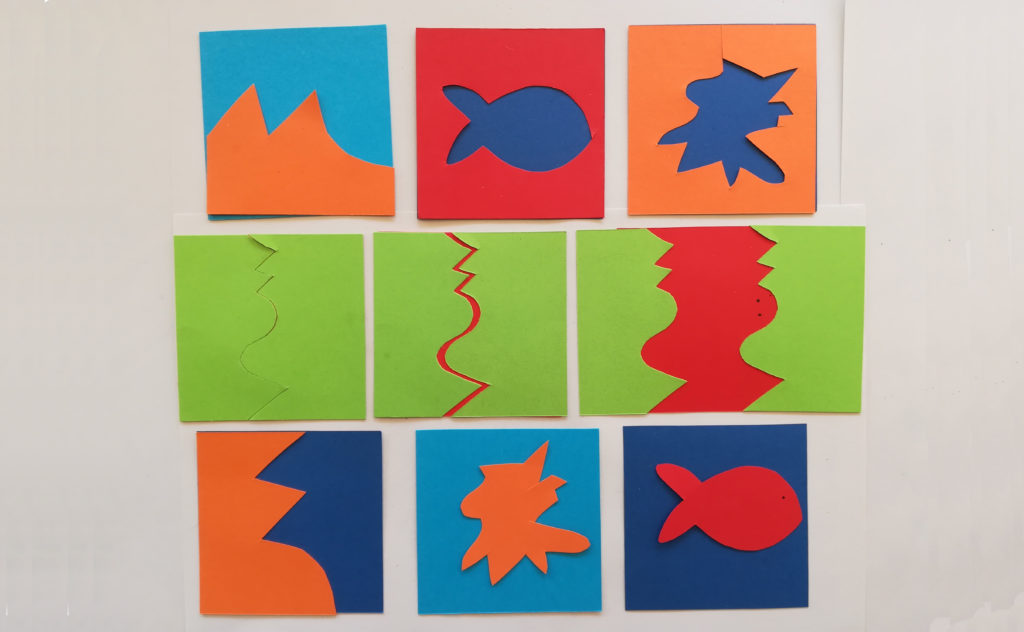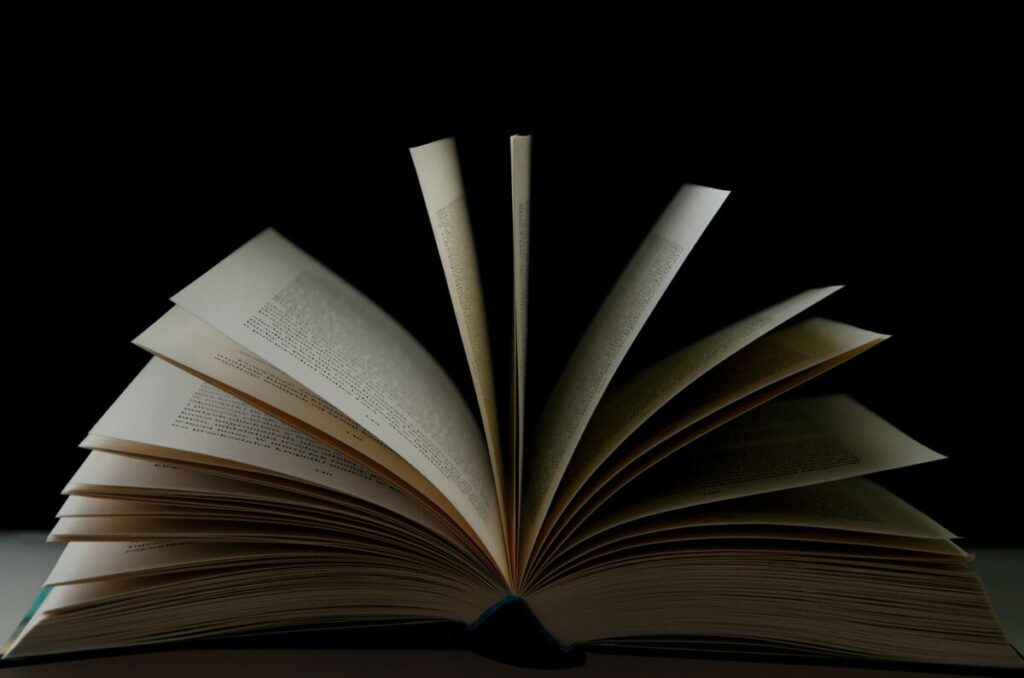Esattamente dieci anni fa, nel suo saggio La società della stanchezza, il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han scriveva: «Ogni epoca ha le sue malattie. Così, c’è stata un’epoca batterica, finita poi con l’invenzione degli antibiotici. Nonostante l’immensa paura di una pandemia influenzale, oggi non viviamo in un’epoca virale. L’abbiamo superata grazie alla tecnica immunologica». Insomma, l’epoca vetero-romantica della tisi, le ondate della terribile influenza “spagnola”, la stagione postbellica del colera e del tifo (e tanti altri virus ancora) sembravano di certo esperienze “nostalgiche” da manuale di storia piuttosto che realtà vive e nitide. Eppure, oggi giorno, la prospettiva è del tutto ribaltata, dal momento che la nostra normalità è segnata dalla pandemia, anzi la nostra normalità è divenuta la pandemia attraverso una quotidianità fatta di distanziamento sociale, mascherine, decreti legge e conferenze stampa.
Ebbene, Byung-Chul Han nell’articolo L’emergenza virale e il mondo di domani (El Paìs, 22 marzo 2020) si preoccupa del nostro modo di reagire al Covid-19, dato che «abbiamo vissuto a lungo in una società senza nemici, in una società di positività, e ora il virus è percepito come un terrore permanente». Sembra di capire che stiamo per pagare a prezzo troppo caro la nostra felicità “globalizzata”, fatta di eccessi, di “tutto e subito”, di status quo sociali e mutamenti ideologici. Se dall’epoca della “solidità” moderna siamo passati ad un universo di liquidità – per dirla come Bauman – in cui tutto pare perdere i contorni netti e distinti a cui eravamo naturalmente predisposti, che futuro ci aspetta in questo momento storico? Navigheremo ancora nell’oceano “liquido” della globalizzazione oppure torneremo alla “solidità” della realtà moderna?
Difficile dare una risposta attendibile, forse impossibile, perché – non da ultima – la precarietà della nostra condizione esistenziale ci impedisce di esercitare quella sana distanza intellettuale per trovare le parole giuste. La globalizzazione pare aver ceduto alle lusinghe dell’eccesso di positività, che si è espresso per il tramite di un eccesso di prestazioni, di produzione, di comunicazione, senza tenere più in alcun conto quella negatività dell’ignoto e della mancanza. Di certo di mancanza si tratta: della mancanza degli altri come fisicità da stringere ed abbracciare, come sguardo da accogliere e a cui rispondere, ma anche mancanza di sé, perché (forse) siamo stati troppo proiettati all’esterno, fuori-da-noi-stessi, sia in presenza che online, e abbiamo finito con il trascurare la parte interna di noi, il nostro io in remoto, troppo presi dal nostro io social-e. Siamo stati troppo fuori, sempre meno dentro, dentro di noi, dentro i nostri pensieri, dentro la responsabilità delle nostre azioni, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre case.
Quella mancanza che, fino a poco tempo fa, ci opprimeva inconsciamente tanto da farci sentire il bisogno irrefrenabile di riempirla oltre misura con azioni, parole, pensieri e tanto altro, ora appare come vuoto e nulla più, come mera assenza. Tuttavia, sentire la mancanza di qualcosa o di qualcuno non dovrebbe essere di per sé un problema, una negatività, poiché desidero ciò che mi manca per essere un sé unitario (completo, forse no) e sensato. Ma se la mancanza diventa vuoto, la mera vita si mostra nella sua disarmante nudità e ferisce, attanaglia nella paura, collassa sotto i colpi dell’attesa. Siamo nati per essere quello che-non-siamo-ancora, perché essere ciò-che-siamo-stati-e-basta toglie l’anima alle persone e alle situazioni. Eppure sembra che il dramma venga proprio da questo vivere in attesa, sospesi tra un ieri in cui ci muovevamo ovunque, progettavamo cento cose e ne facevamo mille, e un domani che non sappiamo se e quando potrà tornare totalmente alla normalità. Avvertiamo una diversa consapevolezza di noi stessi: ci sentiamo vivere sospesi a mezz’aria, perché non siamo forse più abituati a vivere questo hic et nunc, questo sono-io-ora-presente-qui.
L’esposizione continua al rischio, in modo massivo e imprevedibile, potrebbe toglierci qualsiasi orizzonte prospettico senza conservare in alcun modo quella rete di relazioni, legami e riferimenti che abbiamo costruito gradualmente (non senza difficoltà) nella nostra esistenza? Forse una prospettiva in fondo c’è: potremmo non essere più uomini “liquidi”. La liquidità potrebbe aver esaurito la sua validità, inducendo alla conclusione della sua epoca, così da destinarci a una opaca “solidità” post-globalizzata oppure – provocatoriamente – potrebbe porci nelle condizioni di trovare la forza e il coraggio di condurci oltre per mostrare tutta la nostra vulnerabilità e la nostra debolezza. Potrebbe essere giunto il momento di mostrarci per quel che siamo davvero, ragion per cui dovremmo osare ritrovare noi stessi in questa tendenziale consunzione delle nostre certezze. Siamo vulnus, anzi lo siamo sempre stati, pur ostinandoci a mostrare un volto mistificato dietro una coltre di impegni di lavoro, appuntamenti (più o meno) glam e tanto altro ancora. Oggi probabilmente siamo vulnus un po’ di più, come squarcio aperto sulle prospettive della vita, con uno sguardo nuovo che spia oltre il varco per ri-assaporare una umanità fragile e divergente.
Lia De Marco
Laureata in filosofia presso l’Università degli Studi di Bari, abilitata in diverse classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole superiori di I e II grado, ha insegnato dal 1999 in numerosi licei della Puglia. Attualmente è docente di filosofia e storia presso il Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari. Già progettista formativo ed europrogettista, ha maturato un’ampia esperienza nel campo della formazione professionale. Componente del gruppo Buone Prassi della Società Filosofica Italiana (S.F.I.) – Sezione di Bari, si occupa di sperimentazione di attività di didattica integrata della filosofia. Promuove ed organizza eventi culturali e collabora con diverse riviste specialistiche.
[Photo credit Wladislaw Peljuchno su unsplash.com]